Pardo d’oro a Locarno 2013 con ““Història de la mesa mort”, artista partecipante a dOCUMENTA 13 e alla 56esima Biennale di Venezia, Albert Serra è un eclettico regista catalano. Le sue sperimentazioni cinematografiche si sono spesso ibridate con i linguaggi dell’arte contemporanea, mettendo in luce la capacità dell’autore di muoversi tra mondi differenti. Opere come “Honor de cavalleria” (2006) e “La Mort de Louis XIV” (2016) sono alcuni dei tasselli che compongono il sincretismo della sua pratica artistica. In occasione dell’uscita nelle sale italiane di “Pacification – Un mondo sommerso” il 18 maggio, proponiamo un’intervista all’autore, tratta da “Albert Serra. Cinema, arte e performance” a cura di Vincenzo Estremo e Francesco Federici.
Vorremmo cominciare chiedendoti come produci i tuoi lavori? Abbiamo letto in diverse interviste che le videocamere digitali hanno rappresentato un grande vantaggio per la tua pratica e ci domandavamo se ti riferissi alla tecnologia o a qualcosa di diverso. Potresti parlare di come la rivoluzione digitale ha influenzato la tua produzione cinematografica?
Sì, certamente. Innanzitutto la tecnologia digitale ha rappresentato un punto di svolta per artisti e giovani filmmaker come me e per chi non poteva o non voleva avere un’educazione o un approccio accademico al cinema, o semplicemente per chi non voleva andare a scuola di cinema. Da un punto di vista economico, il digitale ha permesso a queste persone di esprimersi liberamente. A partire dall’inizio degli anni Duemila bastava usare un computer e un software di montaggio per rendere possibile quello che negli anni Sessanta era il sogno di molti, ovvero fare un film. Certamente questa accessibilità al mezzo è stata importante, ma non determinante, infatti, pur avendo più libertà produttiva bisognava concepire in ogni caso qualcosa di innovativo, qualcosa che non fosse stato fatto in precedenza.
Così la cosa più importante per me, una cosa che credo di aver sentito sin dall’inizio, è stata quella di sfruttare il digitale per sentire il mondo piuttosto che rappresentarlo. Solitamente con le cineprese da 35 millimetri era possibile registrare solo brani brevi. Spezzoni di 8 o 10 minuti, al massimo 18 minuti con le cineprese da 16 millimetri. Inoltre le cineprese analogiche si portano dietro tutto un apparato tecnico. Le cineprese analogiche necessitano di molta luce, sono degli oggetti molto ingombranti e abbastanza statici, una volta preparate e fissate, non è possibile muoverle a piacimento e inoltre le riprese su pellicola sono solitamente effettuate con gli obbiettivi posti molto vicino al soggetto ripreso. L’invasività della cinepresa limita, a mio parere, la libertà degli attori e ne condiziona la mente e quindi la recitazione e lo spirito. Quindi se si mette insieme la necessità della luce, il peso delle cineprese, l’impossibilità di improvvisazione o la frustrazione per non poter seguire liberamente il proprio istinto, se si mettono insieme tutti questi fattori, diventa evidente in che modo le videocamere digitali abbiano finito per cambiare il modo di fare il filmmaker, evidenziandone innanzitutto le presunzioni mentali.
Con le videocamere digitali è stato possibile iniziare a filmare senza dover preparare le riprese, con le cineprese analogiche era necessario settare le luci, scegliere le giuste focali per gli obbiettivi, calcolare la lunghezza della pellicola e soprattutto bisognava pensare l’intero film suddividendolo in riprese singole ordinate una dopo l’altra. Con il digitale invece mi è stato possibile evitare di pensare al film frammentandolo, per i miei film posso usare qualunque cosa, in qualsiasi momento e accogliere la realtà indagandola a 360 gradi. Per esempio, potrei semplicemente piazzare una videocamera fissa facendola riprendere per un’ora. Ma se nel frattempo sentissi l’ispirazione di muovere la videocamera potrei sempre farlo, magari per filmare il sole dalla finestra solo perché sta per tramontare, e questo mi permetterebbe di essere nel mezzo dell’azione e di comprenderla. Il regista, il filmmaker deve essere, secondo me, il centro dell’azione, deve essere estremamente sensibile, in grado di comprendere e lasciarsi ispirare da quanto gli sta accadendo intorno e tutto questo può avvenire solo perché non vincolato dai lunghi tempi di preparazione del set. Il regista, quindi, deve essere totalmente consapevole di cosa gli sta accadendo intorno, deve essere in grado di poter girare le cose che lui ritiene in quel preciso momento, le più importanti per lo sviluppo del film. Per me questo cambiamento rappresentava una sfida molto interessante, qualcosa che ho creduto sarebbe potuto diventare estremamente radicale, qualcosa che mi avrebbe permesso di non pensare il film necessariamente diviso per scene. Se prima era necessario dividere il film, adesso sarebbe stato possibile articolare il film come un grande elemento concettuale.
All’inizio ero sorpreso, non mi capacitavo di come gli artisti visivi, che solitamente hanno un approccio concettuale all’arte, non avessero colto questa possibilità offerta dal digitale per girare delle cose più ambizione di quanto avessero fatto sino a quel momento. Molti artisti, a mio parere, sono rimasti ancorati all’idea del video e della videoarte, concependo delle immagini in cui prevale la texture e la gamma cromatica, situazioni giocose, in cui il dispositivo diviene più importante di quanto si sta girando. Il digitale sta nel mezzo tra il cinema e il video elettronico, perché ti permette di essere totalmente concentrato in quello che stai facendo, su quello che hai di fronte a te in quel momento. Non è una questione tecnologica, ma qualcosa che ti possa permettere di fare al meglio quello che vuoi fare. Le videocamere digitali ti permettono quindi di focalizzarti sull’immagine ed è da questo punto che sono partito per ripensare il concetto di film, per ristrutturarlo dimenticando la composizione per scene e privilegiando l’improvvisazione.
Hai detto che gli artisti e i registi stanno sprecando le possibilità offerte dalla tecnologia digitale, che non la stanno usando al loro meglio.
Si, solo poche persone usano il potenziale del digitale al suo massimo, ho come l’impressione che i registi continuino a girare in maniera classica e accademica, pur avendo adottato nuovi strumenti con nuova tecnologia. Questo atteggiamento condiziona anche la produzione stessa delle videocamere, per esempio l’ALEXA 65, una videocamera usata a livello professionale anche nelle produzioni hollywoodiane, ha due slot per ospitare due schede di memoria. Mentre lavoravamo alle riprese di Història de la meva mort (2013) abbiamo scoperto che non era possibile continuare a girare ininterrottamente sfruttando la memoria delle due SD, ma che bisognava interrompere le riprese quando una delle due schede era piena. Tutto ciò mi fa pensare che le videocamere digitali professionali siano concepite per agevolare un’idea di produzione cinematografica che ricalchi quella in uso con le cineprese a 35 mm. Io preferisco sfruttare il digitale in maniera ambiziosa, mentre nella produzione cinematografica analogica, i long takes e i piani sequenza erano molto rari e si preferiva suddividere il film in scene poi montate in sequenze più ampie, il digitale deve permetterci di ambire a qualcosa di diverso.
Gli artisti contemporanei che lavorano in video, per esempio, hanno da sempre sviluppato un interesse per il fascino delle superfici e della texture delle immagini, a discapito dei contenuti. Io ho sempre pensato che il video e la videoarte fossero una sorta di grammatica dell’immagine mentre il cinema fosse una ricerca discorsiva. La videoarte però, risultava essere noiosa perché dopo una prima fase sperimentale (negli anni Settanta) non ha saputo evolversi in qualcosa di più ambizioso. Credo che la videoarte necessitasse di maggiore attenzione allo sviluppo di unità narrative, cosa che oggi, con la tecnologia digitale è possibile. Se si considera il lavoro del regista filippino Lavrente Indico Diaz (Lav Diaz) che sta raccontato la storia dei recenti sconvolgimenti politici e sociali del suo paese, ci si accorge di come nel suo caso la documentazione possa coincidere con una sottile articolazione narrativa sospesa in un’ambiente atemporale. Tutta la cinematografia di Lav Diaz è molto ambiziosa e prodotta solo con piccole videocamere digitali e con una troupe estremamente ridotta. Per me, figure come quella di Lav Diaz, hanno compreso come sfruttare al massimo le nuove tecnologie, puntando ad un ambizioso rinnovamento narrativo.
[…]
Vorremmo chiederti se il tuo modo di girare e di montare i lavori cinematografici cambia il tuo approccio al mercato e al sistema dell’arte o al sistema festivaliero? Solitamente mostri i tuoi film sia all’interno del circuito dell’arte che in quello dei festival: qual è il tuo approccio rispetto a questi due contesti?
Da un lato credo che siano lavori diversi e dall’altro lato credo che le cose in questo ultimo periodo si stiano mescolando. Sino ad oggi i film sembravano essere adatti solo per il circuito cinematografico, per i festival, per anteprime nei teatri o per una distribuzione in DVD, mentre le produzioni più marcatamente artistiche sembravano logicamente destinate ai musei. Inoltre le due tipologie di lavori vengono finanziati in maniera differente. Nonostante ciò, credo che in tutta la mia carriera e in entrambi gli ambiti, io abbia lavorato quasi sempre con la stessa ambizione e quasi sempre con lo stesso intento narrativo. Che stessi producendo dei film per il cinema o dei lavori per l’arte, ho sempre lavorato su alcune ossessioni plastiche, con la sola differenza che quando lavoro a delle produzioni artistiche, sento di avere una libertà che non mi è permessa nell’ambito cinematografico. Ad esempio, se sto lavorando a produzioni artistiche sento che posso coltivare delle idee estremamente sperimentali e di poterle spingerle sino al limite dell’assurdo senza correre il rischio di eccedere con l’ironia. Nell’arte tutto quello che può creare contrasto è permesso, mentre con i film di finzione bisogna lavorare per trovare la giusta omogeneità e compattezza. Non è facile lavorare per sottrazione, ma è necessario controllare il carattere del film e fare in modo che non vi sia eccessiva confusione. Nelle produzioni per l’arte contemporanea l’eterogeneità delle idee e dei materiali non produce confusione, ma una serie di suggestioni. Io solitamente lavoro in maniera sinergica, uso i film che produco per l’arte contemporanea anche come momenti per sperimentare cose che poi provo a sviluppare in maniera più organica nei lungometraggi di finzione e dall’altro lato provo ad inserire la coerenza narrativa di questi film nei miei lavori d’artista. E credo che sia un buon modo di bilanciare questi due ambiti.
Ogni progetto necessita un diverso tipo di finanziamento.
Non lo so. Ovviamente mi piacerebbe avere tanti soldi per ogni progetto che realizzo. D’altronde l’arte dovrebbe essere più importante di quanto non lo sia realmente, più del servizio sanitario o dell’educazione. Bisogna prima creare dell’arte e poi pensare a come educare le persone, altrimenti le si educa al nulla. Per questo motivo credo sia molto importante investire nell’arte, perché fornisce i contenuti all’educazione, senza di essa non c’è nulla da insegnare. Immaginate un sistema in cui vi sia un servizio sanitario che tiene in vita le persone e un apparato educativo senza contenuti, mi chiedo: in cosa differisce un sistema simile da una macchina? Qualcosa che lavora affinché tu non muoia, ma che allo stesso tempo non ti fornisce nessun tipo di contenuti, nessuna vita spirituale. Questo è un sistema sociale che fabbrica macchine ed è anche per questo motivo che credo vi siano molti fondi destinati al servizio sanitario e all’educazione.
Ci è capitato di leggere questa tua frase: “Ogni scena dovrebbe essere nuova, con nuovi dialoghi, nuovi punti di svolta perché se essa fosse stata già contemplata, diventerebbe immediatamente vecchia e da buttare via”. Questa citazione viene dal tuo articolo The Dramaturgy of Presence, ed è forse una dichiarazione molto chiara e molto rappresentativa del tuo modo di lavorare. In relazione a questo potresti parlarci del tuo concetto di film come performance?
Questa è stata la mia ossessione sin da quando ho iniziato a lavorare. All’inizio della mia carriera il cinema non era molto importante, le mie radici sono più nell’arte che nel cinema e più precisamente nell’arte delle avanguardie storiche del XX Secolo. In realtà non mi interessava solo l’arte visiva, infatti, ero affascinato dall’energia di rinnovamento e dal lavoro di artisti straordinari e sognatori assoluti come Arthur Rimbaud, persone per cui l’arte è in grado di cambiarti la vita.
A partire da questa idea di arte e vita ho iniziato ad apprezzare la performance come idea e concetto in grado di cambiare la mia vita. La performance è quella forma artistica che ti permette di vivere in tempo reale, nel presente, qualcosa che è totalmente nuovo e che si afferma come una nuova vita possibile, in un determinato e preciso momento. Non è una rappresentazione, ma l’esperienza viva di qualcosa di reale, qualcosa da vivere non per interposta persona, ma dal vivo e nel tempo presente, qualcosa che conta come la tua propria vita allo stesso modo di come conta dormire, bere e tutto il resto. La sfida della performance di essere sempre viva è ben rappresentata dal lavoro di Anish Kapoor che quando apparve sulla scena dell’arte cambiò radicalmente il modo di percepire l’arte stessa. Io credo che una delle cose più scioccanti della performance sia che essa ti permette di scappare dalla tua vita borghese, scappare dal quotidiano e ignorare il passare del tempo, ma soprattutto che ti permette di prevenire quell’atteggiamento conservativo che si assume con il passare degli anni. Nel mio lavoro ho provato a lasciarmi influenzare dallo spirito delle avanguardie storiche degli anni Venti e così, senza delle vere e proprie conoscenze cinematografiche, mi sono detto “facciamo un film, facciamo qualcosa di diverso”. Fare un film rappresentava anche fare qualcosa di divertente, così come gli avanguardisti, anche io volevo sottolineare il lato giocoso di fare arte. All’inizio del XX Secolo la giocosità nell’arte era estremamente importante, lo era per i Surrealisti, per i Dadaisti e anche per i Futuristi, quegli artisti non stavano giocando, ma facevano cose in maniera giocosa da un punto di vista speculativo. Oggi è molto raro ritrovare lo stesso atteggiamento negli artisti contemporanei che temono di essere identificati come “giocosi” e quindi di non essere presi sul serio dal mercato. Per me il lato ludico è connesso alla necessità di fare film, un’attività che deve rappresentare un rimedio alla noia piuttosto che un’attività tediosa.
L’arte deve innanzitutto rappresentare un’esperienza unica e deve richiedere una certa attenzione allo spettatore. La letteratura per esempio è qualcosa che chiede e richiede tempo, non si può scappare dal tempo richiesto di una lettura, non si può fingere di aver letto un libro senza averlo fatto, perché tutti lo scoprirebbero. Che tu sia ricco, intelligente o altro ancora, devi comunque leggere un libro per capirne il significato, non si può scappare da questa condizione. Questa è un’esperienza che richiede una grande quantità di tempo, un condizionamento che mi piace moltissimo.
Ai giorni nostri le inaugurazioni delle mostre d’arte sono diventate dei momenti di esclusiva mondanità, nessuno presta attenzione alle mostre stesse, nonostante le immagini in movimento richiedano tempo per essere esperite. Quando sono arrivato al cinema l’ho fatto avendo ben in mente le esperienze della letteratura e il tempo necessario alla lettura di un libro. Ho provato a raggiungere una natura performativa nel cinema mescolando la performance e il tempo dell’esperienza della lettura.
Il cinema si sa è l’arte della manipolazione: tempo, spazio, narrazione, approccio simbolico, psicologia, io ne volevo fare un’arte reale. Volevo superare qualsiasi approccio tautologico del cinema alla realtà, provando a fare dei film che fossero delle piccole unità di vita reale. Il cinema come performance non vuole essere una rappresentazione, ma la vita stessa. Ma per il cinema, per l’arte della manipolazione, è davvero difficile trovare l’equivalente della performance, così ho iniziato a lavorare su alcune mie ossessioni visive provando a trasmettere l’intensità e la presenza della vita. Per esempio in Història de la meva mort, mentre eravamo quasi a metà della lavorazione del film, ho deciso di passare a girare in un formato diverso da quello con cui avevamo iniziato le riprese. Avevamo iniziato a girare in 4:3, il formato più quadrangolare tra quelli possibili. Di solito io non controllo le immagini sul combo2, è una specie di regola che seguo mentre lavoro alle mie produzioni, ma nel caso di Història de la meva mort mi è capitato di andare al monitor a causa di alcuni problemi con le videocamere. Mentre riguardavo il girato mi sono accorto che le immagini non mi piacevano per niente. Un mio amico, per puro caso mi ha detto: “[…] perché non passiamo al cinemascope ed io l’ho ascoltato, ma non ho detto nulla ai cameramen. Così dopo aver girato e dopo la post-produzione abbiamo perso il 40% della superficie dell’immagine, quasi la metà di quanto avevamo prodotto, ma quello che mi interessava era fare in modo che il film nascesse sullo schermo come in una sorta di performance in cui il film prende vita a partire da un atto arbitrario. Nessuna delle immagini finali del film poteva definirsi precedentemente esistita, quelle immagini sono uniche, esistono solo in quel film e sono nate nel preciso momento in cui abbiamo scelto di cambiare il loro formato.
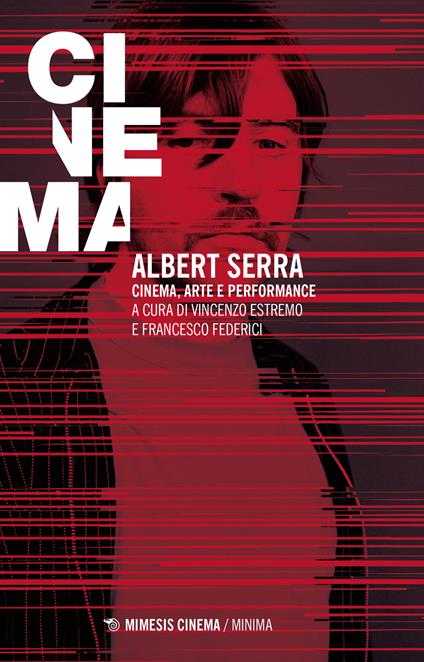
Questo spiega anche la tua idiosincrasia per il documentario.
Sì, certamente. Il documentario non fa altro che spiegare quanto in realtà è stato già spiegato e per me questo non ha senso. A volte mentre sto lavorando a un film prendo delle decisioni del tutto arbitrarie, monto delle scene senza seguire nessuna logica strutturale né dialogica. Preferisco montare in sequenza delle scene che mi piacciono per il loro essere compatibili. Da questo punto di vista credo di aver imparato molto dal modo in cui gli artisti della videoarte hanno lavorato sulle immagini, provando a farle combaciare esclusivamente da un un punto di vista statico. La forma, il colore, la possibilità di creare nuove strutture, il modo in cui le ultime immagini di una scena possono combinarsi con le prime della scena successiva: se queste combinazioni mi piacciono le tengo, se non mi piacciono ricomincio da capo. Non bado molto alla consecutio narrativa delle immagini, né alla corrispondenza tra esse e il dialogo. Preferisco lavorare girando dei piani-sequenza statici ma sempre con alcune variazioni. Questo variare è un altro modo per trasformare il lavoro di manipolazione cinematografica in una performance, infatti, non ripeto mai la stessa cosa in fase di montaggio. Per i dialoghi invece lavoro solitamente a un montaggio su carta, infatti, trascrivo tutte le fasi di un dialogo e poi monto il testo correggendolo direttamente su carta invece che con l’immagine. Questo crea una discrasia tra testo e immagine. Ovviamente questo è possibile solo quando si ha del tempo a disposizione.
Non l’hai fatto a Documenta.
No, a Documenta non c’era tempo a sufficienza, ma quando ho tempo ed energie, perché è un processo molto stancante, allora trascrivo tutte le scene girate su carta – 20 o 30 pagine di dialoghi – e poi inizio a montare direttamente su carta. Quando penso di aver trovato il bilanciamento perfetto tra dialoghi e immagini allora proseguo. Questo metodo mi permette di trovare una coerenza dal punto di vista psicologico e drammatico, ma anche di mettere insieme delle parole che credo si combinino alla perfezione. Quando monto in questo modo tutto si mescola e può capitare che una frase che era nella prima pagina finisca insieme a un’altra che era alla ventesima. Ovviamente questo è possibile quando si ha del buon materiale, ma in ogni caso io provo sempre ad estrarre il meglio da quello che ho girato.
Lavorando in questo modo non si ottiene nessun tipo di conoscenza progressiva, non c’è nessuna direzione, neppure uno scopo preciso a livello narrativo, quello che voglio ottenere è tirare fuori il meglio da ogni scena che metto insieme. Questa estemporaneità, questa ricerca del risultato migliore, sono una forma di performance, un esercizio che termina quando sono stanco, quando sono completamente saturo di lavoro. La scena che finisce per essere inserita nel film è quindi la scena che ho montato fino allo sfinimento. Ogni dialogo presente nel mio film è in realtà un dialogo che non è mai esistito, ma è sempre frutto del mio montaggio, dialoghi pensati nel momento in cui sono stati assemblati in montaggio e non predeterminati con una sceneggiatura. L’unica traccia del dialogo è l’approccio tautologico al cinema, ovvero riprendere la realtà e avere la realtà sullo schermo, per il resto tutto è nuovo, tutto è frutto di una mia performance. Così quando alla fine, dopo aver lavorato in postproduzione, si guarda il film, si ha la sensazione che qualcosa sia nato sullo schermo, nel momento della sua proiezione e non prima.
[…]
Prendendo come spunto The Three Little Pigs vorremmo chiederti qual è il tuo modo di fare ricerca per rimettere in scena il passato, in particolare nel caso di questo progetto che hai fatto per Documenta a Kassel e che è il re-enactment delle vite di Goethe, Hitler e Fassbinder.
Mi baso sull’insegnamento di Hans-Jürgen Syberberg che sviluppa il concetto di opacità riguardo alla storia e al passato. Prendo alcuni elementi che esistono ancora e che si riferiscono al passato e li uso come se fossero completamente opachi. Ho agito in questo modo per quanto riguarda il caso di Hitler, dove ho deciso di girare tutto il contenuto del libro esattamente com’era nel libro. Chiaramente facendo così ho dovuto trovare qualcosa d’interessante a livello dell’immagine perché altrimenti sarebbe bastato leggere il libro, ma credo che con attori non professionisti, con il loro modo di recitare sia venuto in superficie qualcosa di molto particolare: non era una rappresentazione di Hitler ma la nascita di un nuovo Hitler. Il giovane Hitler era veramente uno dei lavoratori di Documenta, uno degli assistenti curatori ed è stato fantastico.
Vedendo il lavoro si ha la sensazione di sentire il passato e non di…
…di insegnare o imparare qualcosa sul passato. Quando tratti questo soggetto come un “materiale” è sempre presente, è opaco, lo hai di fronte. È sempre stato così nei miei lavori e in particolare nelle performance dove questa idea di presente è sempre forte. Riprendo con la macchina da presa la materialità della storia.
Vincenzo Estremo e Francesco Federici


