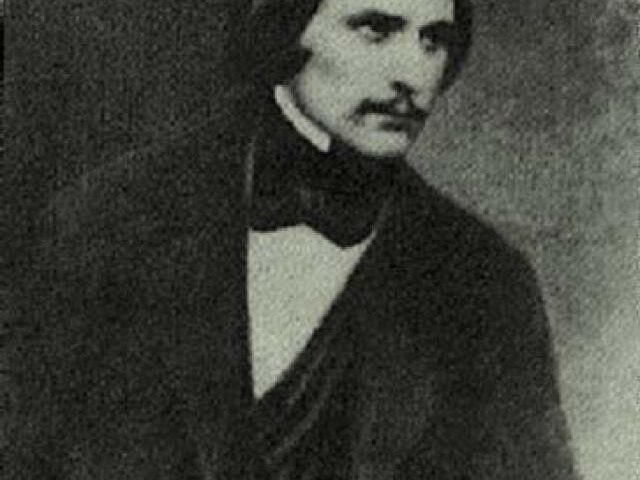Tra i grandi classici della letteratura russa dell’Ottocento, una delle figure centrali è senza dubbio Nikolaj Vasil’evič Gogol’, all’interno della cui produzione un posto davvero particolare può essere attribuito ai suoi Racconti di Pietroburgo (facciamo qui riferimento all’edizione Rizzoli, Milano, 1949). Come è noto, si tratta di cinque racconti accomunati dall’ambientazione nella città russa e nati dall’esperienza dell’autore, ma soltanto successivamente riuniti in una raccolta dai critici.
Ora, in questi racconti, Gogol’ sviluppa storie piuttosto spiazzanti in cui si colgono elementi grotteschi, onirici e paradossali che al di là dello stile narrativo, comunque notevole e acclarato, appaiono sorprendenti al lettore contemporaneo: essi, infatti, sembrano prefigurare straordinariamente molti canoni dell’immaginario più surreale che caratterizzano certi aspetti della cultura e della società nell’evoluzione della modernità novecentesca sino ai giorni nostri.
Può quindi sempre essere opportuno dedicare qualche attenta considerazione in merito a tali racconti da questo singolare punto di vista, legato non tanto alla letteratura o alla critica letteraria in sé e per il quale ovviamente si dovrà rimandare ai più consoni studi di settore, ma appunto all’influenza dei racconti e alle idee e ai contesti cui si intrecciano.
Nella modernità sappiamo che per, le ragioni più disparate, le coordinate del possibile e dell’impossibile vacillano sempre più rispetto alle epoche precedenti e questo è un primo nodo che si può riscontrare nei racconti pietroburghesi. Si può pensare subito al Il naso, in cui viene descritta la vicenda di un funzionario il cui naso, non si sa come e perché, viene perduto e assume una vita propria e autonoma andandosene bellamente (e verrebbe proprio da dire: sfacciatamente) in giro per conto suo, ma in tal senso l’attenzione va pure a Il ritratto, in cui si ripercorre la storia di una sorta di quadro maledetto, che raffigura un diabolico usuraio, a cui si associano i destini degli uomini che ne vengono in contatto; o anche a Il Mantello, in cui un umile impiegato viene derubato del suo nuovo mantello, che tanto faticosamente si era fatto confezionare, e, a seguito dell’ingiustizia patita, muore, divenendo uno spettro.
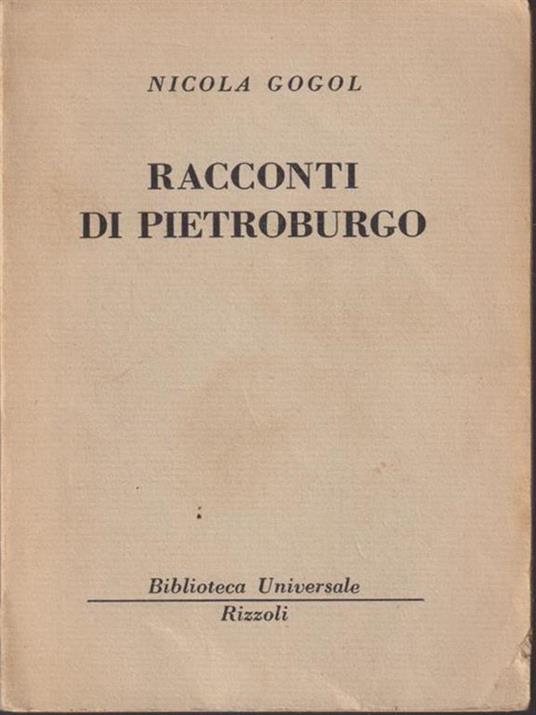
Ma la modernità è anche il momento della centralità della vita urbana, dell’intensificazione degli intrecci e delle relazioni sociali, come ha insegnato con grande acume la sociologia di Simmel (si veda indicativamente Simmel, G., Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici, Bollati Boringhieri, Torino, 2003): a ben guardare, tutti i racconti pietroburghesi restituiscono proprio questa cifra multiforme della grande città moderna e, in particolare, proprio sotto questa luce, è assai esemplificativo il racconto La Prospettiva, in cui si scorgono vividamente dalle parole di Gogol’ i percorsi esistenziali sottesi alla frequentazione della via più importante di Pietroburgo, denominata appunto “La Prospettiva”; in effetti, anche ne Il Ritratto queste suggestioni trovano spazio, quando vediamo il giovane pittore, dopo essere venuto in possesso del quadro diabolico, preso dagli impegni e dalle seduzioni della vita urbana; ma, forse, non sarebbe il caso di trascurare, ne Il mantello, il momento di breve mondanità che l’umile impiegato, grazie al suo nuovo mantello, riesce a concedersi accettando di partecipare a una festa ospitata in una residenza della parte migliore della città.
E, ancora, si deve ricordare che nella modernità grandi sono i rischi di disorientamento, e le questioni di costruzione e ricostruzione del senso e dell’identità (una lettura di teoria sociologica emblematica che si può suggerire al riguardo è Berger, P.L. -Berger, B.- Kellner, H., The Homeless Mind, Penguin Books, London, 1974): ecco allora che si può valutare, in relazione a tali grandi temi, il racconto Il giornale di un pazzo, narrazione di un diario che sembra restituire i passaggi della fenomenologia della discesa di un uomo nelle spirali della follia, una discesa segnata progressivamente e incisivamente dalle date del diario, che, partendo dai giorni normali dell’Ottocento, arrivano poi a indicare il 48 aprile 2000 e sino a momenti ancora più sfasati, come lo squinternato mese “Marzobre” e il 30 febbraio.
Ricorrono poi nei racconti protagonisti di classi sociali che paiono raffigurare i due lati socio-esistenziali forse più dialettici della modernità: da un lato funzionari, dall’altra artisti, entrambi egualmente in balìa degli eventi che Gogol’ delinea, facendo oscillare il lettore tra malinconia e umorismo. Vediamo perciò ne Il naso, l’assessore di collegio Kovalev che si sveglia privo del naso, i giovani pittori, dall’animo tormentato, Ciartkov ne Il ritratto, e Piskarev ne La Prospettiva, il collaboratore di un giornale, Ivanovic de Il giornale di un pazzo, il piccolo impiegato d’ufficio Akakjevic, che svolge mansione di copista, de Il Mantello.
In definitiva, i racconti pietroburghesi trascendono più che mai la loro epoca, hanno già le possibili fascinazioni più sottili, con cui lo scrittore cattura abilmente l’attenzione vincolando alle sue pagine, e che troviamo nei prodotti dell’immaginario mediatico attuale più compiuto, anche cinematografico; in essi con un registro che dosa atmosfere misteriose, grottesche, inquietanti, sentimentali, buffe, il carattere ineffabile della modernità che viviamo pulsa continuamente. Nella narrazione di Gogol’ c’è tutta la ambivalenza dell’immaginario moderno tra inatteso e inevitabile, tra sorprendente e fatale, tra incanto e disincanto, tra aspirazione e meschinità, su cui tanta saggistica dedicata alla cultura e alla società è stata prodotta soprattutto dal Novecento alla nostra epoca (tra i tantissimi riferimenti possibili si può indicare Berman, M., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna, 1985).
Al netto delle retoriche che si associano ai classici e senza dimenticare ingenerosamente la grandezza del capolavoro (seppur incompiuto) di Gogol’, Le anime morte (Feltrinelli, Milano, 2013), pare difficile sfuggire dal pensiero che questa raccolta dello scrittore russo sia una collezione di perle, in cui in ogni storia ciascun elemento e ciascun personaggio viene incastonato con abilità notevole e resta così indimenticabile, sia per la capacità narrativa di Gogol’, sia per le suggestioni che essa determina a cui abbiamo voluto, per qualche momento, proporre di accompagnare la riflessione.