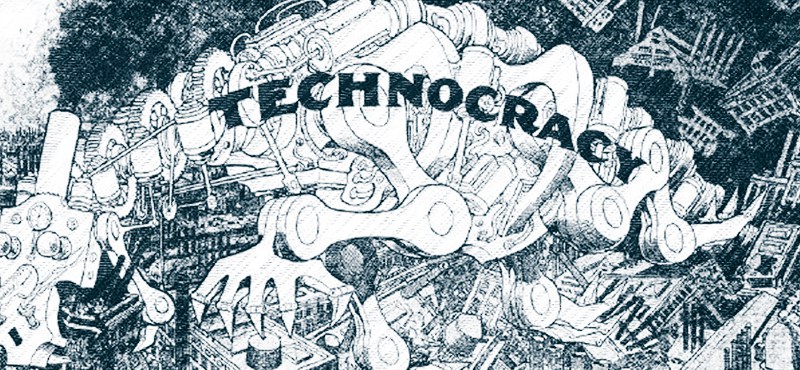Anche se attualmente sembrano giunti allo stadio terminale, sono stati i partiti politici il cuore della politica democratica del Novecento. La democrazia è lo Stato-dei-partiti perché i partiti sono l’espressione di una società formata da “parti”, cioè da legittimi interessi parziali contrapposti, e per questo destinata al conflitto e alla contingenza. È però sotto gli occhi di tutti quanto sia ormai radicata la sfiducia che i cittadini nutrono nei confronti dell’intermediazione politica. Da un lato i partiti vengono accusati di avere perduto ogni interesse per i bisogni del popolo e di essersi trasformati in una “casta” autoreferenziale. Dall’altro viene loro addebitata l’incapacità di governare in modo responsabile e la tendenza a concentrarsi unicamente su interessi elettorali di corto respiro. Si è spesso sostenuto che questa doppia crisi, di rappresentatività e di capacità di governo, sia imputabile ai mutamenti radicali che hanno terremotato la politica e l’economia per effetto della forza sradicante e destabilizzante della globalizzazione, delle nuove forme di governance internazionale e dell’affermazione di un sistema di mezzi di comunicazione autonomo dalle affiliazioni partitiche.
Questa interpretazione è stata spesso utilizzata per spiegare la sfida alla democrazia dei partiti portata dal populismo, che considera la rappresentanza politica convenzionale cieca e sorda ai reali bisogni del popolo. Minore attenzione è stata invece prestata al secondo tipo di sfida, e cioè alle proposte di estendere le prerogative degli organismi esperti a scapito di quelli eletti – ossia alla sfida portata alla democrazia dei partiti da una concezione tecnocratica della politica, cui si attribuisce la capacità di restituire efficienza e professionalità al sistema politico. Eppure, populismo e tecnocrazia potrebbero essere considerati come i gemelli diversi dell’antipolitica, dal momento che condividono la stessa parola d’ordine, la disintermediazione, giudicata come la sola risposta possibile ai meccanismi di chiusura selettiva o alle forme di sclerosi decisionale di cui soffre il circuito rappresentativo.
Populismo e tecnocrazia sono infatti altrettanti esempi di una politica disintermediata, che rinuncia a strutture intermedie come i partiti e le istituzioni rappresentative. Alla democrazia dei partiti viene infatti rivolta l’accusa di trasformare la democrazia in semplice teatro di lotta tra fazioni impegnate a utilizzare il potere politico per consolidare il proprio potere sociale a scapito dell’interesse generale. E di dedicare una parte preponderante della loro attività alla competizione elettorale in vista della occupazione di posizioni di governo piuttosto che dell’azione politica orientata al bene comune. Mentre perciò la mediazione rappresentativa muove dall’assunto che l’eguale libertà di tutti possa essere garantita solo trovando soluzioni di compromesso che lascino sussistere il disaccordo tra le parti nella prospettiva di un bilanciamento degli interessi ritenuto sufficientemente equo, la disintermediazione tecnocratico-populista immagina che sia sufficiente affidarsi alla risoluzione tecnica di problemi che richiedono competenze e opinioni informate.
In generale, è possibile identificare quattro caratteristiche comuni a populismo e tecnocrazia. In primo luogo, sia nel populismo che nella tecnocrazia domina l’idea che vi sia qualcosa come un interesse unitario, generale e comune a tutto il corpo sociale, considerato come una totalità omogenea e indifferenziata. Il compito della politica è di emanare provvedimenti coerenti con il mito dell’unità della collettività sovrana, animata da una volontà unanime espressione del bene comune. Anche se populismo e tecnocrazia propongono visioni fondamentalmente diverse su come identificare l’interesse generale del popolo, questo interesse generale esiste e può essere perseguito lasciando da parte gli interessi frazionari potenzialmente sovvertitori dell’unità politica e tagliando finalmente i ponti con una politica faziosa e particratica.
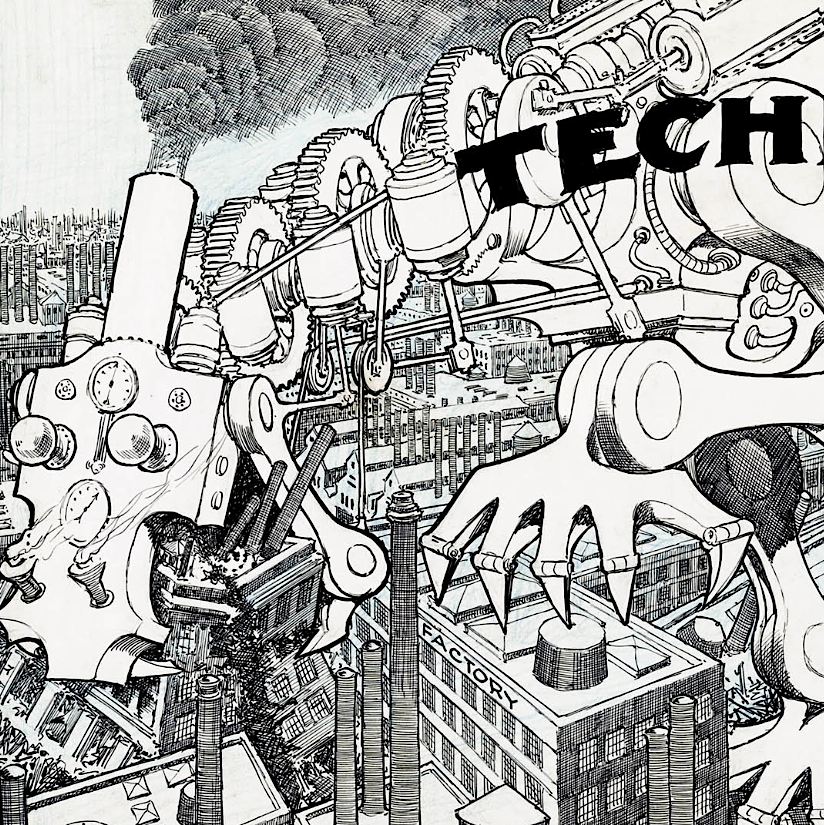
Inoltre, sia il populismo che la tecnocrazia aderiscono a una concezione non pluralistica della società e della politica. La politica deve porsi al servizio del “popolo” inteso come il Tutto, come l’insieme dei cittadini, e non solo come una “parte” tra le molte che costituiscono la società. Non deve rappresentare e aggregare con equità interessi e preferenze preesistenti, ma garantire un bene comune sostanzialmente inteso come non politico – perché non “di parte”. Per questo risulta superfluo immaginare proposte di aggregazione concorrenti da sottoporre al vaglio degli elettori, poiché l’autorità tecnocratica degli esperti o quella del leader nella cui persona il popolo ripone la propria fiducia sono di per sé sufficienti a identificare il bene comune al di là di ogni partigianeria. In questo senso, populismo e tecnocrazia si presentano come fenomeni post-ideologici. E non a caso, quando in occasione delle tornate elettorali occorre proporre un qualche manifesto programmatico, i contenuti da sbandierare di fronte agli elettori sono generalmente vaghi e non vincolanti. È certo vero che anche i partiti politici di massa si propongono di parlare in nome del Paese o della Nazione, ma senza la volontà di riaffermare una rappresentazione unitaria del popolo. L’eterogeneità sociale e il pluralismo prevedono la dialettica tra le diverse istanze rappresentative e interpretative piuttosto che una personificazione unitaria dell’interesse generale. In una democrazia dei partiti, i partiti esercitano precisamente una finzione di aggregazione tra i diversi gruppi sociali, dal momento che le moderne società pluralistiche sono frammentate in interessi organizzati e divisioni partigiane. Il “popolo” della democrazia non è un Tutto omogeneo privo di parti, di parzialità, di pluralismo, ma è una pluralità dove c’è conflitto e bisogno di compromesso. E i partiti sono gli strumenti istituzionali per realizzarlo.
In terzo luogo, sia il populismo che la tecnocrazia, che condividono l’immagine di un Noi collettivo che prefigura un ordine unitario privo di parti, di parzialità, di pluralismo, e ritengono che il rapporto tra il sovrano e il governo non abbia bisogno di intermediari, come i partiti e i mezzi di comunicazione indipendenti. Tutto ciò che crea una distanza e una differenza rappresenta un fattore distorsivo dell’interesse generale. Di conseguenza, populismo e tecnocrazia fanno affidamento su un’élite (presuntivamente) indipendente alla quale demandare il compito di individuare l’interesse comune e la soluzione pertinente. Nonostante si presenti come una forza anti-élite e anti-establishment, il modello populista è altrettanto elitario di quello tecnocratico. Si pensi a come il blog di Beppe Grillo, prima di diventare il motore del MoVimento 5 stelle, abbia esaltato il mito di una valutazione “oggettiva” dei problemi sulla base di una conoscenza “oggettiva” dei problemi sociali, affidandosi più all’autorità tecnocratica degli esperti che all’identificazione ideologica. Secondo questa retorica, gli esperti avrebbero potuto contribuire, meglio dei politici, a promuovere l’interesse generale del popolo. Si tratta di quella priorità attribuita alla competenza rispetto alla partigianeria che ha rappresentato, almeno inizialmente, un tratto distintivo del movimento e l’espressione forse più radicale di antipartitismo – e anche di antiparlamentarismo: non è un caso che uno dei temi caratterizzanti il MoVimento sia stato il rifiuto del libero mandato.
Infine, tanto il populismo quanto la tecnocrazia tendono a evitare la responsiveness, il dovere di rispondere alle esigenze poste dai cittadini. In linea generale, è possibile distinguere due distinte dimensioni della responsiveness. La dimensione verticale si riferisce al possibilità per gli elettori di sanzionare i rappresentanti. Ora, mentre la concezione populista della rappresentanza si basa sul rapporto diretto tra l’élite e il popolo “uno”, la concezione tecnocratica si basa sulla separazione tra il popolo e gli organismi esperti. In entrambi i casi, tuttavia, rimane disapplicata l’idea che il popolo possa sanzionare le élites. Nel caso del populismo sarebbe una sanzione autoinflitta. Nel caso della tecnocrazia il popolo non dispone delle competenze atte a giudicare e non dovrebbe pertanto essere messo in condizione di farlo. La responsabilità orizzontale si riferisce invece alla possibilità di vincolare l’azione delle élites attraverso i fondamenti costituzionali dello Stato di diritto e delle garanzie civili che trovano espressione nelle procedure messe a punto dalla democrazia dei partiti. Sia per il populismo che per la tecnocrazia la priorità va riconosciuta agli interessi della società intesa come un Tutto, e quindi la questione delle procedure diventa sostanzialmente trascurabile.
A questo punto ci si potrebbe chiedere: quanto è radicale questa doppia sfida alla democrazia dei partiti, ed essa rappresenta o no un momento di transizione dall’opposizione all’establishment all’antipolitica? In modi e forme certo diversi, populismo e tecnocrazia costituiscono entrambi forme antipolitiche di rappresentanza. La democrazia dei partiti è fondata sull’idea che il conflitto tra le “parti” sia una condizione permanente di libertà politica e di partecipazione, il populismo e la tecnocrazia vedono la società come un Tutto omogeneo privo di parti, e quindi di parzialità e di pluralismo. Mentre il populismo e la tecnocrazia mirano alla scoperta del Bene comune, i partiti competono per definirlo. Nel caso del populismo, il pluralismo viene ridotto all’opposizione tra il popolo e l’élite. Nel caso della tecnocrazia, il pluralismo viene ridimensionato all’opposizione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Nel primo caso, l’opposizione è tra le élite corrotte e il popolo incorrotto, nel secondo tra chi è irrazionale e incompetente e chi è razionale e competente. L’uno e l’altra sono però un esito del malfunzionamento della democrazia dei partiti, per cui la cura della democrazia non può che consistere, per quanto impopolare questa proposta possa essere, nella cura delle istituzioni intermedie, e dei partiti in particolare.