Faruk Sehic è una delle voci più apprezzate del panorama contemporaneo bosniaco. Romanziere, poeta e giornalista, Sehic è stato vincitore del Premio Camaiore nel 2019 e del Premio Letterario Europeo 2013 con Il mio fiume (Mimesis Edizioni, 2017), opera sconvolgente nella quale lo scrittore documentava la sua esperienza di soldato durante la guerra nei Balcani. A tre anni di distanza, Sehic torna in Italia con Racconti a orologeria (Mimesis Edizioni, 2020) una nuova raccolta che riflette sul rapporto tra uomo e tempo. In questa nota, la traduttrice dell’opera Elvira Mujcic ci racconta l’opera e il suo lavoro di traduzione del libro.
“Il ghiaccio sarà un’email dall’inverno”, annuncia la sognatrice del racconto I sognatori che apre la raccolta di Faruk Šehić sulle note di Absolute Beginners di David Bowie. È un incontro d’amore psichedelico a introdurci nel mondo che, di pagina in pagina, si svelerà con un linguaggio, un tempo e uno spazio propri. La più grande sfida che la traduzione propone è quella di arrendersi al testo e alle sue logiche, si tratta di una resa quasi fisica, un tentativo estremo di fare i conti con l’alterità, piegandosi e facendo posto. Con i libri di Šehić questa resa è ancor più radicale poiché mi impone di abbandonare le mie consuete coordinate spazio temporali e fare conoscenza di dimensioni insolite ed entità sempre in bilico tra il reale e il surreale. Un’immersione analoga mi era già accaduta con il suo romanzo Il mio fiume e proprio in virtù di quella traduzione credevo di essere almeno in parte padrona dell’immaginario dell’autore. Nulla di più sbagliato, dovevo ricominciare tutto daccapo, imparare i nuovi codici e i differenti sistemi di orientamento. Benché in entrambi i testi si possano riconoscere i fili del realismo magico alla Borges e Calvino, le visioni poetiche e fantascientifiche, nonché i riferimenti cult di una generazione cresciuta con il cyberpunk, quello che è sostanzialmente diverso sono gli intenti dei due libri. Ne Il mio fiume l’autore si proponeva di ricostruire il suo mondo perduto, tirare su dalle ceneri la casa d’infanzia sulle rive del fiume, renderla inviolabile ed eterna su un foglio di carta, ricucire lo strappo tra il tempo di prima e quello del dopo, recuperare la memoria di se stesso. Nei Racconti a orologeria la tensione verso un’integrità è svanita, perché essere interi non è possibile, quel che è accaduto ha determinato un altro mondo che non ha nulla a che vedere con il precedente, dunque bisogna allentare il controllo ed educarsi alla sopravvivenza. Andare in pezzi e far parlare ciascun frammento, lasciarlo fluttuare in uno spazio cosmico privo di forza di gravità. Ingoiare una pillola di metamorfosin e varcare la soglia del cambiamento, seguirlo, aderire alle sue regole; in questo consisterà l’evoluzione della specie dopo l’apocalissi.
Inizialmente il sottotitolo mi aveva confusa e dirottata: il sevdah pre-apocalittico. Credevo di aver individuato il tempo, quello precedente l’apocalisse, e di dover solo trovare il ritmo. Mi era chiaro che i racconti avessero un loro meccanismo a orologeria, bisognava solo entrarci e scoprirne il battito. Il ritmo doveva essere quello del sevdah, un termine questo che mi diede da pensare a lungo sulla possibilità di lasciarlo in lingua, poiché si tratta di un genere musicale specifico e come tale intraducibile. Eppure questa soluzione non mi convinceva. Bisognava scavare, fare archeologia, “le parole sotto le parole” scriveva Jean Starobinski. Sevdah deriva dall’arabo “sawda” che indica la bile nera e dal turco “sevda” che significa amore, queste due anime etimologiche si fondono per dare alla luce il cosiddetto blues o fado bosniaco. Eppure definirlo blues è riduttivo, perché il sevdah è un lamento sì, ma anche un inno; è l’audacia del corteggiamento, la disperazione dell’attesa che si attorciglia su se stessa fino a svelarne il luccichio ironico prima di sciogliersi nella sensualità e poi di nuovo, daccapo all’infinito. In un’intervista Šehić dichiarava che il sevdah è il prodotto spirituale più originale della Bosnia ed Erzegovina, ma allo stesso tempo è la dimostrazione che siamo tutti parte di una totalità, di uno spirito del mondo.
Decisi di tradurre sevdah con il termine più semplice: canto, nella ricchezza delle sue accezioni di lamento, inno, preghiera, racconto. Ma dentro la parola canto, rimase un’importante traccia di sevdah che mi rammentava il suo ritmo, quello di un tempo che non ha fretta di compiersi.
Canto pre-apocalittico recita dunque il sottotitolo. Mi aveva fuorviato questo pre-apocalittico, poiché il mondo che i racconti restituivano mi pareva somigliasse più all’apocalisse e al post apocalisse. O forse no, forse l’autore intendeva suggerire che il peggio non è passato. Che tempo è quello prima dell’apocalisse se raccontato con il senno di poi? Corrisponde forse allo scarto tra il lampo e il tuono, è il tempo senza tempo, un lago fermo nel quale tutto accade ora e sempre. È il tempo anarchico della guerra, così liberatorio nella sua assenza di misurazione. O forse è il tempo del dopoguerra, un’agonia lunga venticinque anni che di liberatorio non ha proprio nulla. E se quella discontinuità emotiva ed esistenziale che la guerra ha schiuso si potesse rimuovere, se la suddivisione netta tra il prima e il dopo si cancellasse, sarebbe possibile tornare a fluire senza le pietrificazioni dell’anima che amplificano il trauma all’infinito? Se l’apocalisse fosse solo una questione di tempo che si è bloccato ed incancrenito?
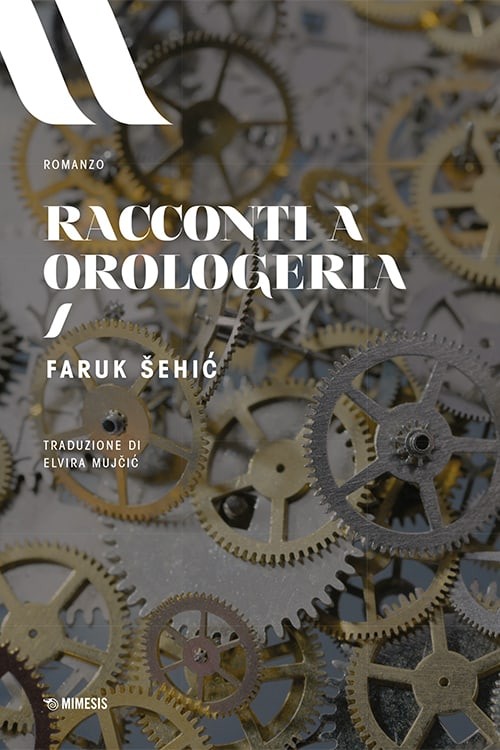
Nella traduzione dalle lingue della ex-Jugoslavia una delle difficoltà maggiori risiede proprio nei tempi verbali, nei continui salti dal presente al passato, anche all’interno della stessa frase, nel mescolarsi spontaneo di un tempo soggettivo, interiore e quello oggettivo, esteriore. Durante la traduzione di Racconti a orologeria questa difficoltà ha raggiunto livelli altissimi, io stessa mi perdevo in un flusso temporale indistinto, in un unico interminabile istante.
Se Il mio fiume era un testo onirico e labirintico dal linguaggio evocativo e poetico, Racconti a orologeria, frutto di componimenti scritti in un arco temporale di più di quindici anni, ricostruisce atmosfere claustrofobiche e oniriche, a tratti crudeli e ripugnanti, eppure ne escono immagini di una fragilità così precisa da risultare insostenibile. È un passare brusco e docile dal realismo al fantastico, dall’insolito al surreale grazie a una lingua inventata che comprende tutto ciò che esiste, ma anche le creature che si muovono nell’ombra, invisibili agli occhi dei più: i Raubari, il Metamorfosin, gli Eoni, la Cavalegna, i Lucezoidi, Mieloid Maionezoid.
“Perché dovremmo ricorrere alla fantascienza, se tutto ciò che ci è accaduto qui è fantascientifico?”, si domanda Šehić. Non c’è da meravigliarsi se è la Bosnia con la sua realtà distopica a fare da sfondo alla narrazione. L’ombra della guerra degli anni ’90 e del dopoguerra sono presenti in ogni racconto, in alcuni unicamente come un fantasma da aggirare, in altri come una premonizione, un accenno o un rimando, in altri ancora nella sua veste più concreta e disumana ossia nello sguardo di un soldato sul fronte. Come accennavo, qui non troviamo la pulsione a ricucire lo squarcio che la guerra ha inflitto, bensì un’urgenza ossessiva di guardare increduli dentro la voragine, aprire ancora di più la ferita per fronteggiare la verità, e desiderare contemporaneamente di farsene carico di testimonianza, ma anche di fuggire. Il dilemma tra memoria e oblio è onnipresente, il dovere di parlare per coloro che non ci sono più si scontra con la necessità di scrollarsi di dosso il passato e diventare altro. In questo senso un ritorno archetipico alla natura diventa la via di fuga.
“Verrà un tempo in cui le persone lasceranno le città in massa. Cercheranno consolazione nella natura, nell’alleanza tra la flora e la fauna. I lavoratori torneranno alle origini, ai villaggi. Le fabbriche abbandonate esisteranno solo per dare corso a un romanticismo industriale, in mezzo all’erba e alle bestie selvagge. Un giorno le passeggiate nelle città abbandonate faranno parte dell’offerta turistica su questo pianeta, per i viaggiatori intergalattici. Quello sarà il mio tempo”.
Da ogni racconto fa capolino l’Improbabile, il Poetico, che spiazza e toglie il velo che celava l’essenza: dopo non si potrà più tornare a essere quelli di prima. “È la nostra ultima tentazione: ricordare tutto ciò che avremmo potuto essere, ma che non siamo mai diventati”.
Ed è proprio questa la dannazione dei personaggi intrappolati nelle storie di Šehić nelle quali è plausibile prendere il tempo tra le mani e dilatarlo fino a farlo durare un’eternità, poi d’un tratto schiacciarlo e accelerare, passare attraverso le trame della storia alla velocità della luce. È possibile essere un soldato e una vittima, metà uomo e metà gatto, un gattotauro, un Cajun bosniaco, un viaggiatore intergallatico o un bambino ultimo superstite dell’umanità. Tutto è possibile tranne uscire da questa storia, uscire dal proprio passato e tornare a essere come prima.
Il tempo passa, il meccanismo ad orologeria pre-apocalittico si è innescato e non c’è modo di fermarlo, anzi bisogna assecondarlo fino al suo compimento, proprio come ci ricorda il ragazzino No:
“Tutto tende alla maturazione, all’invecchiamento e al deperimento. Anche le città decadono così, alla fine. Quel che muore non deve essere rianimato artificialmente. La scomparsa è avvenuta all’improvviso. Come se d’un tratto tutto si fosse fermato. Il tempo era stato risucchiato dallo spazio. E le persone erano svanite. Semplicemente, così, senza lasciare alcuna spiegazione dello spiacevole evento. Il ragazzino No teneva il registro delle stagioni. Utilizzava tomi specifici per cose specifiche. Come Registro della pioggia, Densità della nebbia di domenica e di martedì, Morfologia della Luna di giorno in giorno. Non si occupava di questioni sociopolitiche– e come avrebbe potuto, visto che non c’erano né la società, né la politica? Quando non ci sono persone, non ci sono nemmeno noiosi battibecchi e furbizie di politici. Restano solo le stagioni. Il vento, il cinguettio degli uccelli, i congressi delle talpe”.


