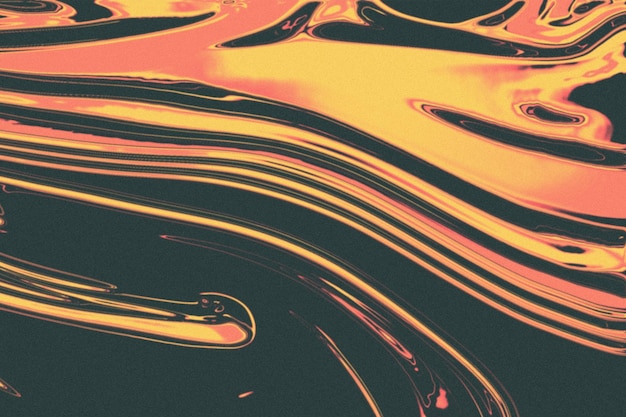Soprattutto a partire dalla modernità, quando dapprima Bacone ammoniva “Sapere è potere” e successivamente Kant coglieva il senso l’Illuminismo attraverso la celebre massima “Sapere aude”, per la persona sapiente, per l’uomo colto, per lo scienziato e per i loro epigoni è sempre più avvertita l’idea che la propria condizione comporti una sorta di responsabilità e che quindi vi sia, per dirla con Fichte, una “missione del dotto”, chiamato a inserirsi nella vita associata e ad assolvere la funzione di guida della società, trascinando dietro di sé e spingendo all’azione gli uomini comuni, inclini all’inerzia (si veda Fichte, G. A., La missione del dotto, Rizzoli, Milano, 1967). In Fichte, la cui interpretazione in merito riflette, nel modo più efficace e pregnante, un certo canone moderno, vi era l’idea del dotto come educatore dell’umanità: egli aveva come obiettivo il perfezionamento morale di tutto l’uomo, perché, secondo Fichte, il dotto «deve essere l’uomo moralmente migliore della sua epoca» (ivi, p. 77). Ora, questa dimensione della responsabilità va intesa nel più ampio contesto sociale, civico e anche politico, e quindi più volte il dibattito si è acceso in proposito, soprattutto dal corso del Novecento in poi, per cui in questa sede può essere interessante proporre un discorso volto ad alcuni spunti particolarmente significativi, utili per visualizzare i nessi chiave della dialettica culturale e politica in cui gli uomini non cessano di essere coinvolti.
Si tratta di un discorso comunque problematico, tanto che Julien Benda, già a partire dai tardi anni Venti del secolo scorso e rendendo le sue riflessioni cruciali per gli eventi degli anni Trenta, denunciava esplicitamente una sorta di tradimento degli intellettuali rispetto alla loro missione tradizionalmente svincolata da condizioni pratiche e mondane e rinviante invece a un canone spirituale; Benda coglieva, infatti, nei nuovi intellettuali del XX secolo tendenze quali il rifiuto di verità e di morali universali e un culto del successo che porta a «umiliare i valori della conoscenza di fronte ai valori dell’azione» (si veda Benda, J., Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea, Einaudi, Torino, 1976, p. 163: la prima edizione francese di questo testo è del 1927); in generale, del resto, si era già entrati in una fase storica che rendeva sempre più impossibile un equilibrio tra i valori della ragione da un lato e i valori della sfera emotiva dall’altro (per una lettura critica d’insieme su questo contesto si consideri Hughes, H. S., Il decennio degli anni Venti: gli intellettuali al punto di rottura, in Id., Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930, Einaudi, Torino, 1967). Malgrado la percezione che il dotto, rispetto a una sua responsabilità pubblica e politica, si esponesse a possibili errori di valutazione, nel corso del “secolo breve”, molto spesso, intellettuali importanti si sono tuttavia trovati a intervenire nell’ambito politico, restando invischiati in situazioni articolate rispetto alla loro possibile missione in tal senso (si veda la lettura critica di Lilla, M., Il genio avventato. Heidegger, Schmitt, Benjamin, Kojève, Foucault, Derrida e i tiranni moderni, Baldini & Castoldi, Milano, 2010). Non è qui necessario richiamare l’esempio ormai iconico di un filosofo come Martin Heidegger nel suo rapporto col nazismo, ed è forse anche più indicativo ricordare i casi proprio di teorici della politica e della società, come soprattutto Carl Schmitt. Il celebre giurista tedesco, infatti, avvertiva la responsabilità, come studioso, di opporsi alla crisi della modernità e alla secolarizzazione dell’età liberale, denunciando l’ipocrisia e l’ideologismo che sono alla base della società liberale; in uno dei suoi diari, Schmitt esprimeva molto emblematicamente il suo monito critico proprio rispetto a coloro che si muovevano nello scenario letterario e artistico, denunciando il fatto che la loro esistenza si dissolvesse completamente nella loro esposizione pubblica: «Si parla molto e in modo molto saggio, ma non ci si compromette con le proprie parole; si dice quel tanto che serve per riempire un libro voluminoso, ma in definitiva non si è detto nulla di pericoloso» (Schmitt, C., Libro terzo, in Id., Glossario, Giuffrè, Milano, 2001, p. 390). Non a caso, conseguentemente, su tanti nodi problematici, a partire dagli anni Settanta, il suo pensiero venne accolto con interesse anche da prospettive marxiste e da significativa parte dell’opinione pubblica tedesca, francese e italiana. Ma, ovviamente, il fatto che questa critica della modernità e del liberalismo, e dei loro processi tanto politici che socio-culturali, sia sfociata in Schmitt, che pure aveva alte competenze giuridiche e politiche, nell’antisemitismo e nel nazismo, ossia in esiti di cui la riflessione politica più qualificata coglie inevitabilmente tutta la natura erronea, evidenzia l’abbaglio della “missione del dotto”, il pericolo di avventatezza e il suo tratto potenzialmente controverso.
Nel cuore del Novecento, comunque, la sociologia di Raymond Aron aveva stigmatizzato nel modo più esplicito la “missione del dotto” rispetto al rischio di possibili fanatismi legati a una visione politica (si veda Aron, R., L’oppio degli intellettuali, Lindau, Milano, 2008) e dunque, soprattutto a partire dall’ultimo ventennio del Novecento, l’idea fichtiana della “missione del dotto”, un po’ a causa delle pericolose commistioni ideologiche della prima parte del “secolo breve”, un po’ per i successivi moniti alla cautela, si è allontanata dalla declinazione del dotto come guida ed educatore: questo passaggio è stato rimarcato molto chiaramente dalla sociologia di Zygmunt Bauman che appunto rileva come, dagli anni Ottanta, il dotto si limiti a veicolare una cauta strategia dell’interpretazione, che «abbandona apertamente, o tralascia come irrilevante rispetto al compito immediato, il presupposto dell’universalità di verità, giudizio o gusto» (Bauman, Z., La decadenza degli intellettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 222). Un altro sociologo contemporaneo come Jürgen Habermas in anni più recenti ritorna, nelle sue analisi, sul tema della “missione del dotto”, considerando il ruolo dello studioso, dell’intellettuale e del filosofo nella società globalizzata del XXI secolo, in cui è sempre forte il rischio di una liquefazione della politica nella comunicazione di massa (si veda Habermas, J., Il ruolo dell’intellettuale e la causa dell’Europa. Saggi, Laterza, Roma-Bari, 2011): in quest’ottica, Habermas, delineando diverse possibilità di configurare questo particolare ruolo ‒ per lui essenziale nella sfera pubblica ‒ segnala in particolare quella del tecnico specialista, quella del “terapeuta” e quella del “diagnosta dei tempi”, ritenendo saggiamente che, probabilmente, per l’epoca attuale, lo stile più opportuno che può accompagnare il pensiero critico risulti quello del terzo caso. Ma, in questo XXI secolo, la “missione del dotto” e la sua responsabilità, pur tenendo presenti le osservazioni influenti di Bauman e Habermas, attraversano una nuova ulteriore transizione, quella in cui Internet, i social media e le più ampie condizioni culturali e comunicative delle società avanzate hanno determinato, tra l’altro, una certa tendenza anti-intellettualistica di matrice populista, comportando il fatto che viene spesso misconosciuto il valore della competenza (si veda Cassese, S., Intellettuali, Il Mulino, Bologna, 2021). Sullo sfondo di nuove tecnologie che, nel collegare il mondo, possono anche generare nuove formule di esclusione (si veda La tecnologia per il XXI secolo. Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, a cura di P. Ceri e P. Borgna, Einaudi, Torino, 1998), così, oggi il problema è quello di stabilire un giusto equilibrio tra vecchi e nuovi mezzi, vecchio e nuovo linguaggio o stile, per cui si determina il rischio che la “missione del dotto” venga alterata proprio dai mezzi del web, finendo per essere inserita cioè in un ambito in cui la dimensione dello spettacolo in sé può prendere, anche involontariamente, il sopravvento (su questo punto si veda, ad esempio, la recente rapida ma indicativa riflessione di Tedesco, F., La cultura come merce: i “dolori” del giovane Prati e i tanti mediocolti, su Il Fatto quotidiano, 14 ottobre 2024, p. 8, disponibile anche su: https://lepalaisdurire.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tedesco-la-cultura-come-merce-i-dolori-del-giovane-prati-e-i-tanti-mediocolti-il-fatto-quotidiano-14-ottobre-2024-p.-8.pdf ; in generale, ovviamente, si ricordino sulla “società dello spettacolo” le considerazioni fondamentali di Debord, G., La società dello spettacolo. Commentari sulla società dello spettacolo, Baldini e & Castoldi, Milano, 2013).
Si deve necessariamente avvertire che la “missione del dotto” e la sua implicazione anche politica, soprattutto nel mondo odierno gravato dalle eredità dell’ultimo secolo, appaiono cruciali per dare coscienza di sé della società, e tale questione tocca estremamente il pensiero critico nel senso più ampio. Quest’ultimo infatti ha una essenza sempre delicata, perché deve rapportarsi alla politica facendo attenzione a non restare invischiato in derive inquietanti, deve interpretare la realtà senza abbandonarsi a logiche meramente funzionaliste o descrittive e, da ultimo, deve sfuggire alle seduzioni di una “società dello spettacolo” che possono inglobarlo in strutture estetiche di produzione e fruizione.
E dunque la “missione del dotto”, che si colloca nel solco del pensiero critico, diventa sempre più ardua e si indirizza sulla scia di un equilibrio fatalmente precario, che, per un motivo o per un altro, rischia di essere tradito, tanto più dopo decenni di individualismo, nichilismo, postmodernismo, consumismo, populismo, ecc., che accompagnano lo slittamento cruciale da un pensiero e una cultura critico-dialettica e una dimensione prevalentemente estetica. Per questo, forse, siamo di fronte a una “missione impossibile”, ma i cui tentativi e i cui fallimenti sono, al contempo, i passi faticosi e dolorosi del cammino della civiltà, ricordandoci così, con buona pace dei tanti utilitarismi oggi dominanti, che tale missione non va considerata come una sorta di mansione, quanto come una sempre ineffabile vocazione, segnata dalla costante tentazione di cedere al fascino di un’idea e di rinunciare alla nostra principale responsabilità: padroneggiare il tiranno che è in noi (si veda Lilla, M., Postfazione. Il miraggio di Siracusa, in Id., Il genio avventato. Heidegger, Schmitt, Benjamin, Kojève, Foucault, Derrida e i tiranni moderni, cit., specialmente p. 226).