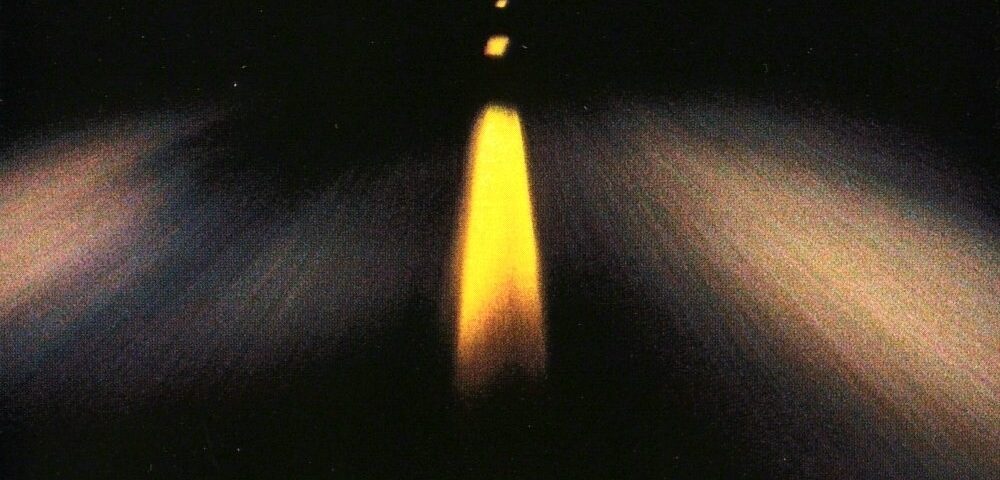David Lynch ha costruito un immaginario dell’onirico e dell’inconscio capace di restituire autenticità al reale. Per continuare a guardare la ciambella e non il buco, su Scenari un estratto di Lynch: il ridicolo sublime in cui Žižek traccia una lettura psicoanalitica di una delle opere più amate di David Lynch, Strade Perdute.
In Strade perdute ci vengono presentate due modalità del doppio, distribuite lungo l’asse della differenza sessuale: le due versioni del protagonista maschile (Fred e Pete) hanno sembianze diverse ma sono in un certo senso la stessa persona, mentre quelle della protagonista femminile (Renee e Alice) sono chiaramente interpretate dalla stessa attrice ma possiedono due personalità differenti (a differenza di quanto accade in L’oscuro oggetto del desiderio di Luis Buñuel, in cui due attrici interpretano lo stesso personaggio). Questa opposizione fornisce la chiave di lettura del film: dapprima, abbiamo la coppia composta dall’impotente Fred e da sua moglie Renee, riservata e forse infedele, attraente ma non fatale; dopo il suo assassinio, compiuto o immaginato dal protagonista, entriamo nell’universo noir e nel suo triangolo edipico. Alla reincarnazione più giovane di Fred viene abbinata Alice, reincarnazione di Renee, femme fatale sessualmente aggressiva; a essi si aggiunge la figura dell’osceno padre-jouissance Eddy, che si intromette nella coppia nel tentativo di impedire i loro rapporti sessuali. Lo scoppio di violenza assassina viene spostato di conseguenza: Fred uccide sua moglie mentre Pete uccide Mr. Eddy, il terzo incomodo. Il rapporto della prima coppia è destinato a finire per ragioni intrinseche: Fred è impotente e debole nei confronti della moglie, da cui è ossessionato e traumatizzato, ed ecco perché deve ucciderla nel passage à l’acte.
Nella seconda coppia, invece, l’ostacolo è esterno, ed ecco perché Pete uccide Mr. Eddy e non Alice. Significativamente, l’unica figura che rimane immutata in entrambi gli universi è quella di Mystery Man. Il punto chiave sta nel cambiamento di stato dell’ostacolo durante il passaggio dalla realtà all’universo noir immaginario: mentre nella prima parte del film l’ostacolo è intrinseco (il sesso non funziona), nella seconda l’impossibilità intrinseca viene estrinsecata nell’ostacolo (Eddy) che, dall’esterno, impedisce la realizzazione della relazione sessuale. Lo spostamento da impossibilità intrinseca a ostacolo esterno rappresenta proprio la definizione di fantasma, di oggetto fantasmatico in cui il blocco intrinseco acquista un’esistenza positiva. Si suppone che, quando questo ostacolo verrà rimosso, la relazione procederà tranquillamente (succede lo stesso nell’antisemitismo con lo spostamento della causa dell’antagonismo sociale strutturale verso la figura dell’ebreo). Nel tentativo di chiarire la logica di fondo dei due ruoli da lei interpretati, Patricia Arquette aveva quindi ragione a schematizzare la trama del film in questi termini: un uomo uccide sua moglie perché gli è infedele, ma non riesce ad affrontare le conseguenze del suo atto e così ha una specie di crollo nervoso durante il quale s’immagina una vita migliore in cui è più giovane e la sua compagna lo desidera sempre. Ma anche la sua vita immaginaria va storta: la sfiducia e la follia che lo affliggono sono così profonde che persino la sua fantasticheria crolla e diventa un incubo. La logica è proprio quella della lettura lacaniana del sogno di Freud “padre, non vedi che brucio?”, in cui chi sogna si sveglia quando la realtà dell’orrore incontrato nel sogno (il rimprovero del figlio defunto) è più orribile della realtà una volta sveglio, per cui chi sogna si rifugia nella realtà per sfuggire al reale incontrato nel sogno. La chiave per l’ultima, confusa parte del fi lm è la dissolvenza graduale del fantasma: quando Fred, ancora nei panni di Pete, immagina la “vera” moglie Renee mentre fa l’amore con Eddy nella misteriosa stanza 26 del motel, oppure quando Pete ritorna ad essere Fred siamo ancora in una dimensione fantastica. Allora, dove comincia il sogno e dove finisce la realtà? L’unica soluzione possibile è che la fantasticheria inizi subito dopo l’assassinio, e quindi le scene del tribunale e del braccio della morte facciano già parte di essa.

Il film ritorna alla realtà dopo il secondo omicidio, e cioè quando Fred uccide Eddy e fugge in auto, inseguito dalla polizia. Tuttavia, una lettura psicanalitica così diretta presenta dei limiti. In termini stalinisti, va rifiutata sia la deviazione psico-riduzionista “di destra”, secondo la quale quanto accade a Pete è semplicemente un’allucinazione di Fred (proprio come in Giro di vite di Henry James, in cui i due anziani servitori corrotti sono solo un’allucinazione del protagonista), sia l’insistenza anarchico-oscurantista e antiteoretica “di sinistra”, secondo la quale bisognerebbe rinunciare a ogni sforzo interpretativo e abbandonarsi all’ambiguità e alla ricchezza audiovisiva del fi lm; Stalin direbbe che sono entrambe peggio… Una lettura freudiana ingenua rischia anche di arenarsi in acque junghiane, qualora interpretasse tutti i personaggi come semplici proiezioni o materializzazioni degli aspetti repressi di Fred (Mystery Man è la sua Volontà malvagia e distruttiva, e così via). È più utile, invece, sottolineare come la trama circolare di Strade perdute riproduca la circolarità del processo psicanalitico; un ingrediente fondamentale dell’universo lynciano è una frase, una catena significante, che risuona come il Reale che insiste e ritorna sempre, una specie di formula che sospende o attraversa il tempo: in Dune è “colui che dorme deve svegliarsi”, in Twin Peaks, “i gufi non sono quello che sembrano”, in Velluto Blu, “papà vuole scopare”. In Strade perdute, ovviamente, “Dick Laurent è morto”, frase iniziale e conclusiva del film che preannuncia la morte della figura paterna oscena (Mr. Eddy): l’intera trama del film, infatti, si svolge nel lasso di tempo incluso tra questi due momenti.
All’inizio, Fred sente queste parole al citofono di casa, mentre alla fine è lui stesso a pronunciarle al citofono: otteniamo così una situazione circolare in cui dapprima il protagonista sente un messaggio che non capisce, poi è lui stesso a pronunciarlo. L’intero film si fonda sull’impossibilità dell’incontro del protagonista con se stesso, come nelle famose scene di distorsione temporale tipiche dei romanzi di fantascienza, in cui l’eroe, viaggiando nel passato, incontra se stesso in un’epoca precedente. D’altro canto, questo processo è simile all’analisi psicanalitica, in cui il paziente dapprima è turbato da un messaggio oscuro e indecifrabile ma insistente (il sintomo) che sembra bombardarlo dall’esterno e poi, a conclusione del periodo di cura, è capace di considerare questo messaggio come proprio, e di pronunciarlo in prima persona. La sequenza temporale sottesa a Strade perdute è quindi quella del trattamento psicanalitico in cui, dopo un’ampia deviazione, ritorniamo al punto di partenza ma assumiamo una prospettiva differente. Per un’analisi più approfondita, ci si dovrebbe concentrare sulle tre scene più importanti del film: lo scoppio d’ira di Mr. Eddy (Dick Laurent) nei confronti di un guidatore; la conversazione telefonica tra Fred e Mystery Man alla festa; la scena ambientata a casa di Andy in cui Alice si confronta con il film pornografico in cui copula a tergo. Ciascuna di esse definisce una delle tre personalità con cui il protagonista entra in rapporto: Dick Laurent è il Super-io paterno eccessivo e osceno, Mystery Man la Conoscenza sincrona senza tempo né luogo, Alice il fantasma del godimento eccessivo.