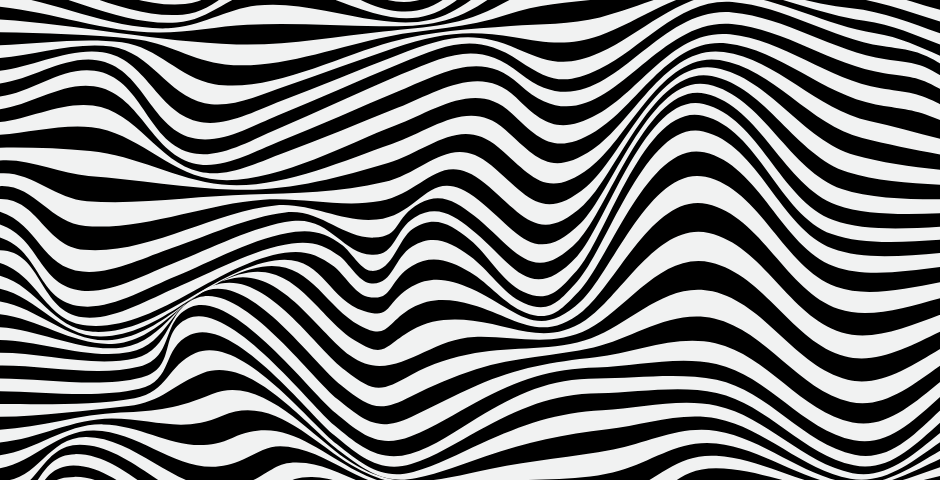Come pensare l’immaginazione nell’età della tecnica. Meglio, come guardare al «ciclo dell’immagine» in un tempo che esalta la tecnologia dell’immaginazione indirizzandola verso una virtualità sempre più marcata e sempre più lontana dalla sua potenza biologica e psicologica.
Gaston Bachelard aveva coniato il termine «fenomenotecnica» per esaltare la «tecnica di effetti» (Noumène et microphysique, 1931-32) prodotta dalla microfisica e da una sempre più raffinata e complessa strumentazione che allontana dalla percezione comune degli oggetti. La “scienza simulante” erogata dai sistemi computazionali tramite l’uso di big data conduce oggi la «fenomenotecnica» a immagini mai prima immaginabili, coniugando astrazione matematica e costruzione tecnologica. Ma Lamberto Maffei, neurofisiologo della visione, valorizza l’aspetto biologico dell’immagine, dimostrando il carattere primordiale dei segnali visivi, correlati all’attivazione del sistema motorio in Homo sapiens ed elaborati da gran parte della corteccia cerebrale. Maffei ci ricorda che con i moderni mezzi di comunicazione di massa le immagini «sono diventate potenti padrone delle comunicazioni e anche mezzo di persuasione e strumento di potere» (La libertà di essere diversi, 2011).
Gilbert Simondon (1924-1989), filosofo nato cent’anni fa, formatosi alla scuola di Bachelard, di Maurice Merleau-Ponty e di Georges Canguilhelm, professore di Psicologia generale alla Sorbona dal 1963 al 1983, ma soltanto da qualche decennio riconosciuto come una delle voci più innovative della filosofia della tecnica, ha inteso come pochi la centralità della produzione delle immagini nella cultura umana. Fin dalla sua tesi di dottorato, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione (1958), pubblicata in forma integrale nel 2005 (ed. it. 2011 e 2020), Simondon coniuga con l’arte fine di un cultore della grecità psicologia, biologia, sociologia e teoria dell’informazione per sviluppare una teoria dell’immagine nel quadro di una riflessione sull’individualità umana e animale. Il filosofo di Saint-Étienne vede l’individuo come l’esito relativo e mutevole di processi di individuazione fisici e biologici, che sono il risultato di relazioni che lo precedono nel sistema pre-individuale e nell’ambiente associato (milieu associé). L’individuo vivente si potrebbe intendere come un cristallo allo stato nascente che si amplifica senza stabilizzarsi, rimanendo in un regime di equilibrio instabile. Con gradi di complessità maggiori l’individuazione umana procede oltre quella animale, costruendo le dimensioni psichiche e collettive che definiscono lo spazio topologico del trans-individuale.
È in questa direzione che trova spazio, in Immaginazione e invenzione (da un corso tenuto alla Sorbona nel 1965-1966), la teoria dell’immagine, coniugata con una teoria dell’invenzione. Il volume, curato con notevole perizia da Roberto Revello, integra l’opera più nota, Del modo di esistenza degli oggetti tecnici (1958, ed. ampliata 1989, ed. it. 2020), e conferma Simondon come uno tra i maggiori filosofi contemporanei della tecnica. Le prime tre parti del libro esaminano l’immagine prima dell’esperienza dell’oggetto, nei suoi aspetti fisiologici e neurologici, a partire dalla motricità, ma anche nella sua dimensione psicologica, dalla fobia all’intuizione come immagine pura; in un secondo momento l’immagine è studiata nel suo contenuto cognitivo, nel contesto delle funzioni percettive; infine, l’immagine viene letta nel suo contenuto affettivo-emotivo, che produce simboli e oggetti-simbolo. La quarta parte del libro si orienta sul tema dell’invenzione, della creatività tecnologica, strettamente connessa con la teoria dell’immagine.
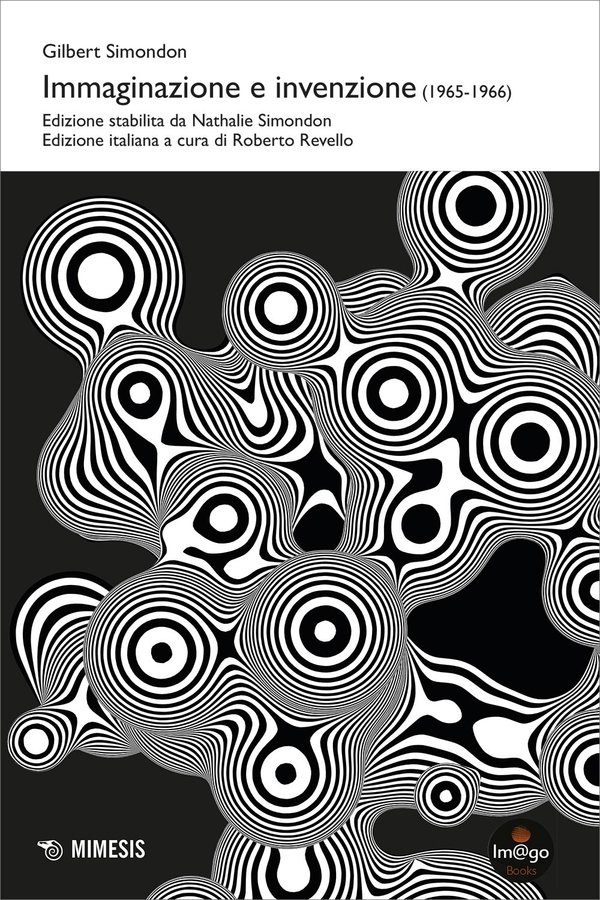
Gilbert Simondon, Immaginazione e invenzione (1965-1966), edizione stabilita da Nathalie Simondon, edizione italiana a cura di Roberto Revello, Mimesis, Milano-Udine 2022, 234 pp., 22€
Due direzioni rendono la ricerca di Simondon di persistente interesse. Da un lato, si prospetta la continuità tra l’individuazione negli animali e negli umani. Un individuo viene riconosciuto come tale per il suo limite mortale, caratteristica propria degli individui pluricellulari. Anche il cenosarco, quella parte di tessuto molle vivente che ricopre la massa scheletrica dei singoli polipi di una colonia corallina, è soggetto a individuazione quando produce la transizione da una colonia all’altra, pagando con la propria vita il distacco dalla propria colonia. Tale analisi della simbiosi mutualistica tra individui viventi avvicina animali e umani: «si è spesso osservato il profondo legame che sussiste fra due buoi al lavoro, che si rivela così forte da indurre, alla morte dell’uno, la morte del suo compagno. I Greci, per indicare questa relazione di simpatia vissuta, tanto solida quanto tacita, impiegavano, come nel caso della coppia umana, la parola azugÛa, ovvero comunità di gioco» (L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione). Dall’altro, Simondon studia la tecnica come produzione creativa che caratterizza il rapporto degli umani con l’ambiente. Gli uomini fondano la cultura su una rete di significati e persistono nelle opere tecniche che hanno realizzato e nel ricordo che possiedono e alimentano. Sviluppando le tesi del paleontologo gesuita Pierre Teilhard de Chardin, Simondon segue l’idea di una persistenza dell’individuo nella collettività attraverso la tecnica e l’affettività. L’oggetto tecnico realizzato dall’essere umano, polo simbolico di significati trans-individuali, perdura oltre l’atto stesso di creazione in maniera autonoma. L’oggetto creato tramite la tecnica esprime «un punto dell’ambiente riorganizzato dall’attività diretta di un organismo».
Pensiamo a una via di comunicazione. Deve possedere una sua stabilità come oggetto fisico, rigida per le strade romane, impermeabile ed elastica per quelle di oggi, coperte di asfalto, ma deve essere anche compatibile esternamente con l’ambiente, seguendo il tracciato «secondo il rilievo e la composizione del terreno, e anche secondo le possibilità di valanghe, frane, ecc.». Proprio in questo intreccio tra compatibilità interna ed esterna dell’oggetto tecnico Simondon ritrova un nesso con l’immagine dell’organismo: «l’oggetto creato è prima di tutto il mondo come realtà organizzata in un territorio; è anche l’involucro delle singole esistenze concrete, così strettamente che per certe specie si fonde quasi con l’organismo, come nei coralli». E tuttavia la differenza costitutiva dell’oggetto tecnico si esprime nello scambio tra il pre-individuale e l’individuato, prefigura la scoperta del collettivo, a partire dalla necessità di pensare gli esseri umani dal punto di vista delle relazioni che li costituiscono. Individuo e società, natura e società, organismo e ambiente vengono così ripensati in un originale nesso intrinseco che pone al centro la relazione.