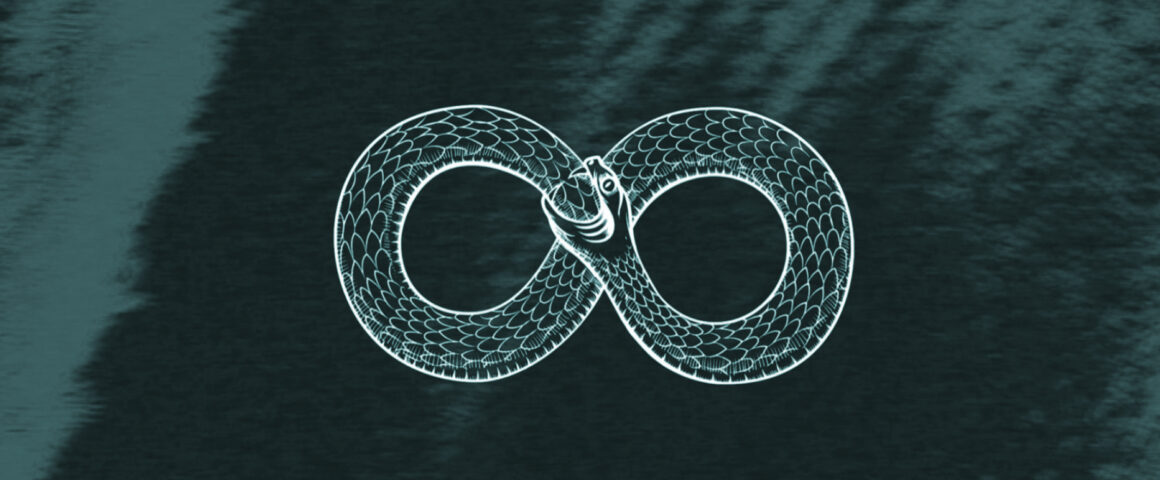“Quel che resta dietro a noi
non importa che si perda:
ci si accorge, prima o poi,
ch’è solo merda.”
“Il tarlo”, Fausto Amodei, Cantacronache 3, 1971
Quando, nel 1867, Karl Marx diede alle stampe il suo Capitale, lo svelamento delle profonde radici di sfruttamento che si celavano alle sue spalle diede inizio a una nuova epoca segnata da riflessioni che mutarono drasticamente la concezione globale dell’intero sistema. Da allora, le pubblicazioni sul tema si sprecano e, soprattutto di recente, hanno riacquisito una nuova linfa che sta portando l’attuale classe di teorici e intellettuali a interrogarsi con nuovo spirito critico sulle contraddizioni interne alla nostra società. Il saggio di Nancy Fraser Capitalismo cannibale si pone con decisione in questa corrente, segnando un vero, e nuovo, punto di non ritorno.
Nella sua indagine, Fraser libera l’idea che abbiamo del capitalismo come “mero” sistema economico, tracciando le relazioni di dipendenza che legano a doppio filo società, natura e politica a un sistema che, pur necessitandole per la sua stessa esistenza, se ne nutre come un vizioso uroboro – la cui metafora viene più volte citata nel testo. Da ciò la definizione di capitalismo cannibale.
Le dinamiche che caratterizzano il rapporto dell’uomo con la natura, o con le proprie istituzioni politiche e coi suoi stessi simili, sono solo apparentemente svincolate e indipendenti, dacché costituiscono testa, corpo e cibo del capitalismo in ognuna delle sue fasi ed evoluzioni.
Fraser apre il saggio proprio con una rivalutazione del concetto di capitalismo. Superando la stantia divisione ontologica tra l’economico e il non-economico, svela quelle contraddizioni che vivono non più nonostante la società capitalista, ma in forza di essa. Quattro contraddizioni, quattro cancrene della nostra società che Fraser dimostra essere inscindibili dai meccanismi della società capitalista. Ben mascherate da dinamiche esterne e indipendenti, ma senza le quali il capitalismo sarebbe privato delle sue stesse condizioni d’esistenza.
Supremazia di genere, deterioramento ecologico, oppressione razziale-imperialista e dominio politico vengono smascherati nella loro relazione strutturale, e non accidentale, col capitalismo. A ognuna di queste contraddizioni viene dedicato un capitolo del saggio in cui, senza mai perdere di vista il filo rosso che le lega a vicenda, vengono esplorate nella loro relazione storica e strutturale con la società capitalista. Fraser si dota delle armi della ricerca storica e sociologica per dimostrarci come i grandi mali che cerchiamo di combattere ogni giorno siano irrimediabilmente invincibili senza una lotta che ne vada a minare la base comune, la sorgente che le nutre e le alimenta. Nessuna rivoluzione che voglia debellare razzismo, sessismo, riscaldamento globale e ingiustizia politica può essere raggiunta senza un valore che le accomuni tutte verso il vero nemico comune. In una parola, ognuna di queste lotte dev’essere necessariamente, e prima di tutto anticapitalista.
Ognuna di queste contraddizioni viene racchiusa in quattro “d”: dipendenza, divisione, disconoscimento e destabilizzazione. L’analisi di questa quadrupla relazione mette in piena luce le dinamiche di fondo di cui parla l’autrice. Un’analisi che, per lucidità e forza d’impatto, è destinata a fare riflettere e discutere la società intera sui mali che la tormentano, ma di cui ignora totalmente le radici comuni.
La società capitalista fa dipendere l’economia dallo sfruttamento razziale, dal dominio di genere, dall’antropocentrismo ecologico e dal dominio politico. Quattro dinamiche senza le quali l’intero meccanismo di accumulazione del capitale sarebbe impossibile. L’economia dei paesi capitalisti dipende dallo sfruttamento e dall’espropriazione dei paesi e delle popolazioni del Sud Globale; dipende dalla sottomissione della donna al ruolo di riproduzione sociale, senza cui mancherebbe la forza lavoro da sfruttare; dipende dall’appropriazione indebita e incosciente delle risorse naturali; così come dipende dal mantenimento di un potere politico neoliberale e debitore delle logiche di mercato.
Allo stesso tempo, ognuna di queste tematiche viene divisa. Una divisione di natura ontologica che le separa dalla società capitalista e tra di loro, facendole passare per mali autonomi, indipendenti, da combattere in arene diverse e con armi differenti. Vengono divise nell’immaginario collettivo dalle dinamiche strutturali che le rendono indispensabili alla società capitalista e, dividendole, ne indeboliscono la lotta. Una moderna forma di divide et impera funzionale solo al raffreddamento morale nei confronti delle sue responsabilità, che il capitalismo vuole celare a tutti i costi agli occhi delle masse.
E ancora, in tal modo, questo regime economico disconosce i costi e i danni che genera. Disconosce le sue responsabilità nei confronti del dominio e dell’oppressione dei paesi periferici del mondo, senza i quali si priverebbe di forza lavoro a bassissimo prezzo, quando non gratuita; di risorse naturali e territoriali espropriate e mercificate a beneficio dei paesi del centro globale; di risorse umane prive di qualunque tutela e protezione dallo sfruttamento legalizzato. Disconosce le conseguenze insite nell’obbligare la donna a farsi carico di tutti gli oneri che concernono la riproduzione sociale; del tempo, dell’energia e del lavoro (non retribuito) senza il quale l’intero meccanismo di produzione perderebbe le fondamenta sociali e culturali che lo reggono in piedi. Disconosce i costi ecologici di un approccio antropocentrico e baconiano nei confronti di una natura vista alla mercé dell’uomo; di uno sfruttamento sconsiderato e auto-distruttivo di una natura immaginata come infinitamente auto-riproduttiva; delle ferite a lungo termine che non si preoccupa minimamente di risanare, in vista del solo profitto e a danno di un ecosistema globale di cui fa egli stesso parte. Infine, disconosce le sue influenze nei confronti di un sistema governativo e istituzionale al servizio del capitale, che antepone la crescita economica della nazione e delle imprese al benessere e alla tutela dei diritti dei propri cittadini.
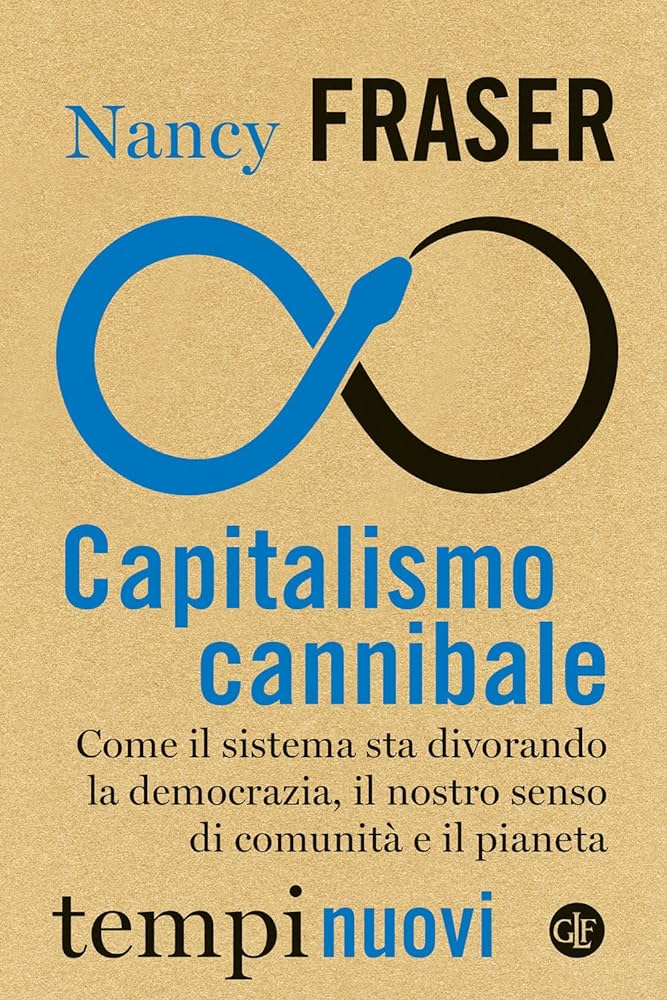
L’effetto che tutto ciò provoca, quando i danni e le conseguenze che il sistema capitalista genera e disconosce raggiungono livelli critici, è quello di destabilizzare – destabilizzare tutto: gli ecosistemi, gli equilibri di genere, le istituzioni governative, le nazioni già da sé instabili. Bisognosa di ognuna di queste dinamiche, l’economia capitalista è comunque pronta a farle a pezzi. Comportandosi da cannibale, divora i propri stessi organi vitali, accecata dalla crescita, dall’accumulazione, dalla ricchezza e dal miope progresso. Da qui, la metafora dell’uroboro, che non si limita a cannibalizzare i propri simili, ma finisce per cannibalizzare se stesso.
Come ogni analisi dotata della lucidità necessaria per porci davanti allo specchio della realtà e a farci confrontare col marcio che ci circonda, la prima reazione può essere di sconforto, di rabbia o di un lacerante senso di ingiustizia e di impotenza. Ma non è finita qui; l’ultimo capitolo del saggio è dedicato a quell’orientamento politico che è l’antitesi per antonomasia del neoliberalismo-capitalista: il socialismo. Fraser accende un faro nella notte, ci indica una strada che, chissà, potrebbe portarci in salvo. Un socialismo nuovo, in grado di ampliare la propria definizione come noi abbiamo ampliato all’inizio quella di capitalismo.
L’autrice ci lascia con delle riflessioni su quali strade potrebbe, e dovrebbe, prendere questo nuovo socialismo. Una strada non solo anticapitalista, ma anche transambientalista, che riappropri il potere politico di ciò che ha ingiustamente ceduto al potere economico, che sia in grado di costruire un fronte comune, paritario, che possa prendere coscienza delle contraddizioni che ci hanno portato su questa strada e che abbia il coraggio non solo di denunciarle, ma di combatterle.
Che evoluzioni prenderà poi la storia, nessuno può dirlo, neanche Fraser. Non sappiamo tra quanto i danni che stiamo causando saranno irreparabili. Non sappiamo quale nuova forma potrebbe assumere il capitalismo moderno, se mai si renderà conto delle contraddizioni che lo attanagliano e nemmeno se è intenzionato a farlo. Quello che è chiaro è che le generazioni future erediteranno un conto salatissimo per secoli e secoli di costi non pagati. Ma ci è chiaro anche qualcos’altro. La specie umana ha affrontato secoli, millenni, di crisi. Millenni costellati di momenti in cui tutto sembrava perduto, in cui la fine era percepita come certa e vicina. Momenti in cui, consapevolmente o meno, e con più o meno successo, una via si è trovata. Il saggio di Fraser ci permette di fare il primo passo in direzione di un futuro diverso: la presa di coscienza. Il resto, per quel che vale, sta a noi.