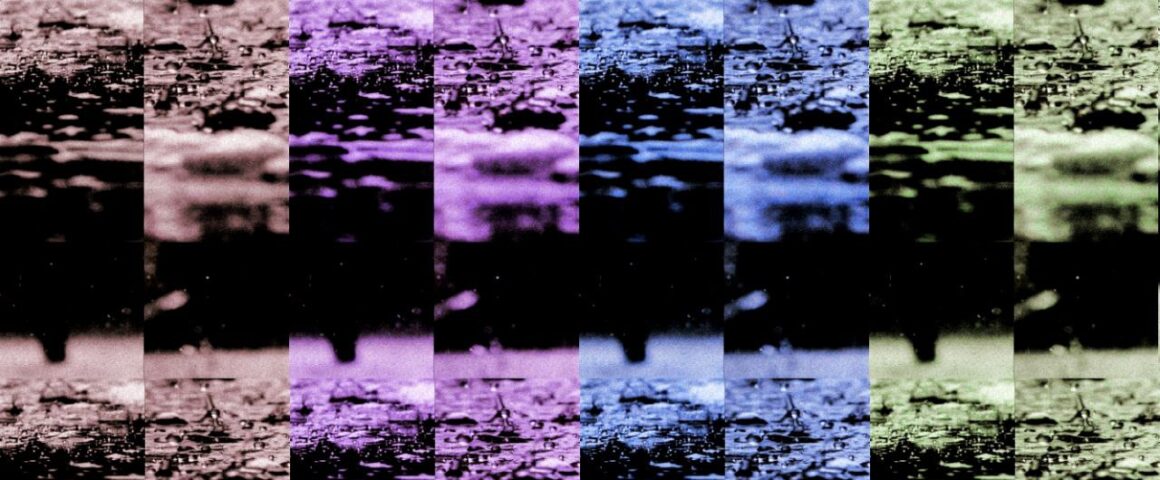Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno riportato al centro del dibattito pubblico la questione del rapporto tra intervento umano sul territorio e rischi idrogeologici. Ma quali sono i processi geofisici alla base di questi fenomeni? E in che modo le attività antropiche li hanno modificati? Oggi su Scenari, un estratto di “Terra senza tregua. Terremoti, alluvioni, eruzioni, cambiamenti climatici tra scienza e comunicazione” di Federico Pasquaré Mariotto e Alessandro Tibaldi.
Al pari di termini come “magnitudo” e “tsunami”, anche l’espressione “rischio idrogeologico” è entrata a fare parte dell’uso comune. Genova è forse la città italiana che meglio esprime la vulnerabilità al rischio idrogeologico, ma sono moltissime le comunità che si trovano ogni anno a dover fare la conta dei danni dopo un’alluvione o una frana. Ma cos’è il rischio idrogeologico? È il rischio associato sia all’instabilità dei pendii, sia ai possibili danni provocati dai corsi d’acqua: la naturale tendenza dei versanti a essere trascinati verso il basso dalla gravità, e la tendenza dell’acqua a fluire da zone più elevate a quelle meno elevate, rappresentano un fattore di pericolosità intrinseca in Paesi prevalentemente montuosi come l’Italia.
Accanto al rischio sismico e a quello vulcanico, il rischio idrogeologico rappresenta uno dei maggiori rischi ambientali con i quali le moderne civiltà ultra-urbanizzate devono confrontarsi. Il rischio derivante dall’instabilità dei pendii è strettamente connesso alla conformazione geologica e morfologica dei versanti, a sua volta influenzata dalle caratteristiche dei depositi e delle rocce dai quali sono formati.
Il rischio associato ai corsi d’acqua, che possiamo definire “rischio alluvionale”, deriva dalla combinazione fra condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali. Un elemento fondamentale è rappresentato dalle precipitazioni: le acque piovane, una volta cadute al suolo, seguono un ciclo che a sua volta dipende dall’assetto geologico, geomorfologico e dall’uso del territorio da parte dell’Uomo.
Il rischio idrogeologico rappresenta la combinazione fra la pericolosità idrogeologica, la vulnerabilità dei centri abitati e il danno potenziale, spesso enorme specialmente in Italia, dove a essere esposti a frane e alluvioni sono beni culturali dal valore inestimabile. A sua volta, la pericolosità idrogeologica rappresenta la probabilità che una frana o un’alluvione di una certa intensità si verifichi in un determinato momento e in una data area.
A confondere spesso le idee di giornalisti e non addetti ai lavori si aggiunge un altro concetto, che vale la pena di introdurre: il dissesto idrogeologico. Quest’ultimo ha una connotazione socialmente rilevante, in quanto riassume l’insieme dei processi e delle azioni che causano il degrado del territorio e del suolo: è ben noto che le attività che contribuiscono maggiormente al degrado del suolo sono di matrice prettamente “antropica” e possono avere conseguenze molto gravi, fino a rendere un territorio particolarmente esposto al rischio di fenomeni estremi, sia di origine franosa che alluvionale. Nei Paesi industrializzati, densamente popolati e intensamente edificati come il nostro, gran parte del rischio idrogeologico dipende dal fatto che il territorio è stato capillarmente modificato attraverso la realizzazione di strade, ponti, ferrovie, che interferiscono con l’ambiente e con la sua evoluzione naturale.
Gran parte della storia geologica della Terra è caratterizzata dalla formazione di catene montuose, che rappresentano la conseguenza più estrema e spettacolare del movimento delle placche terrestri. Le montagne, a loro volta, sono soggette a fenomeni erosivi che, nel corso del tempo, portano allo smantellamento dei versanti e al conseguente accumulo dei detriti verso aree topograficamente più depresse. I fenomeni erosivi che conducono al progressivo livellamento dei rilievi possono svilupparsi attraverso il graduale trasferimento dei detriti rocciosi verso valle, oppure in modo improvviso e violento, come in occasione di frane e piene alluvionali.
Se intendiamo continuare ad abitare le nostre case e le nostre città, dovremo imparare a rispettare la naturale evoluzione del territorio. Ciò che invece si registra sempre più spesso è un aumento del rischio idrogeologico generato dall’occupazione, talvolta abusiva, di aree soggette ai cicli di erosione dei rilievi e al trasporto dei detriti a valle. A peggiorare il dissesto idrogeologico, e dunque la propensione al rischio, contribuisce anche la sistematica deforestazione dei versanti montuosi e collinari.
[…]
Li chiamano “angeli del fango”: volontari, in gran parte giovani, che sono entrati in azione, a più riprese negli scorsi decenni, durante i giorni e le settimane successive a un’alluvione in una delle città del nostro Paese.
La prima volta fu la grande piena dell’Arno che nel 1966 invase Firenze, mettendo a repentaglio l’inestimabile patrimonio culturale del capoluogo toscano. In quella situazione d’emergenza furono proprio le migliaia di giovani volontari, mescolati a centinaia di giovani allievi sottufficiali, a contribuire a salvare dalla morsa del fango un grandissimo numero di opere d’arte, statue e manoscritti antichi. Anche la città di Genova, negli ultimi decenni, è stata più volte aiutata dagli “angeli del fango” a rialzarsi dopo le alluvioni che troppo spesso l’hanno messa in ginocchio.
Lo sviluppo di questi eventi idrogeologici è relativamente semplice da descrivere: un’alluvione si verifica quando le acque di un fiume non possono più essere contenute all’interno delle sponde e invadono le aree circostanti.
La causa scatenante è sempre data dalla quantità di pioggia, che può superare la capacità di assorbimento dei terreni: ciò accade quando le precipitazioni sono particolarmente intense oppure nei casi in cui il dissesto del territorio è tanto grave da rendere impossibile il regolare deflusso delle acque piovane.
Per comprendere il concetto si può visualizzare una pioggia moderata, che cade sul terreno per un periodo di tempo prolungato. Il volume d’acqua piovana, in questo caso, viene distribuito nel tempo e la portata dei fiumi è sufficiente a smaltire il surplus di acqua attraverso il letto fluviale.
Quando invece, come nel caso delle temute “bombe d’acqua”, cade una quantità di pioggia importante in tempi molto brevi, il volume d’acqua incanalato nel letto del fiume è maggiore della capacità di smaltimento del corso d’acqua. In altre parole, il volume che invade il letto fluviale è superiore alla portata e il volume in eccesso è costretto a fuoriuscire (esondare) dagli argini.

Il problema è che i cambiamenti climatici stanno producendo, soprattutto nelle ultime decine di anni, una concentrazione delle precipitazioni: la quantità di pioggia tende ad addensarsi in intervalli più ristretti di tempo, generando velocemente grandi volumi d’acqua. Questi superano la capacità di trasporto da parte dei letti fluviali, esondando così rapidamente (le già citate “alluvioni lampo”) da non lasciare alle autorità alcuna possibilità di allerta per le popolazioni a rischio.
Quando un territorio è preda del dissesto idrogeologico, la capacità dei terreni di assorbire l’acqua può azzerarsi, causando in tal modo un aumento esponenziale dei volumi d’acqua che si riversano nei fiumi durante precipitazioni molto intense.
Come già scritto a proposito delle frane, il dissesto idrogeologico viene incrementato dal taglio indiscriminato degli alberi: quando un versante è soggetto ad attività di disboscamento, viene annullata la protezione offerta dai rami, la cui funzione è fondamentale nel rallentare la caduta dell’acqua sul terreno, riducendo i danni delle precipitazioni (inclusa la grandine) sul suolo e sul sottobosco. Anche quest’ultimo esercita un’azione di rallentamento del movimento dell’acqua sulla superficie del terreno, la quale, a sua volta, ha più tempo per essere assorbita e può in tal modo arricchire la falda acquifera (le acque sotterranee). Se invece gli alberi sono stati asportati e il sottobosco è stato compromesso, l’acqua piovana può cadere direttamente sul terreno, saturando rapidamente lo strato superficiale: in seguito, l’acqua piovana non riesce più a penetrare nel sottosuolo, e tende a scorrere in superficie, con velocità dipendente dalla pendenza del versante, andando a ingrossare i torrenti e quindi i fiumi.
Un’altra attività che aumenta la propensione di un’area a essere colpita dalle alluvioni è la cosiddetta “impermeabilizzazione”. Ricoprire il territorio di cemento ha infatti l’effetto di impedire l’infiltrazione della pioggia nel terreno, aumentando i volumi e la velocità dell’acqua che scorre verso i fiumi. Anche la cementificazione degli alvei fluviali è responsabile della riduzione dei tempi di deflusso dell’acqua, che può riversarsi a valle più velocemente. Infine, le alluvioni vengono rese ancora più distruttive dalla presenza di ponti con “luce” troppo limitata, che costituisce un ostacolo al deflusso dell’acqua.
Le alluvioni sono quindi una diretta conseguenza del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici in atto: negli ultimi decenni si sta purtroppo assistendo in Italia a un incremento di questi fenomeni, anche in bacini idrografici di piccole dimensioni. Il motivo principale è da imputare alle precipitazioni intense e localizzate, molto difficili da prevedere, come osservato negli ultimi anni specialmente in Liguria, Toscana, Calabria; qui sono presenti piccoli bacini idrografici, con tempi di sviluppo delle piene dell’ordine di qualche ora e il conseguente innesco di alluvioni, non di rado devastanti.
È possibile ridurre i rischi derivanti dalle alluvioni attraverso interventi strutturali e non strutturali. Tra i primi, la costruzione di argini, canali scolmatori e invasi di ritenuta. Tra gli interventi non strutturali rientrano in primo luogo la salvaguardia della qualità del territorio (che rientra nelle attività di prevenzione) e in secondo luogo la gestione delle emergenze.
La predisposizione di un sistema efficiente di allertamento è un punto tanto fondamentale quanto controverso. In Italia non mancano quasi mai le polemiche (e talvolta gli strascichi giudiziari) a seguito di un’alluvione: al centro delle controversie è quasi sempre la mancata o insufficiente allerta da parte delle autorità. Quanto accaduto nella notte fra il 9 e 10 settembre 2017, a Livorno, ne è un chiarissimo esempio.
Federico Pasquaré Mariotto, Alessandro Tibaldi