Pioniere della fusione tra musica etnica orientale e sonorità occidentale, ideatore di colonne sonore memorabili tra le quali Furyo (1983) , L’ultimo imperatore (1987) e Il tè nel deserto (1990). Sakamoto si svela nelle pagine del filosofo orientalista Leonardo Vittorio Arena che ha saputo ascoltare e comprendere fino in fondo le sue opere.
Su Scenari proponiamo un estratto di La filosofia di Sakamoto. Il wabi/sabi dei colori proibiti di Leonardo Vittorio Arena (Mimesis Edizioni, 64 pag. 6,00 €, 2017).
Si può parlare di Sakamoto in merito a una filosofia della musica, come è qui il caso, e in quale misura, dal punto di vista dell’artista stesso? E come formulare un’analisi dell’opera che non sembri musicologica, e sondi lo speculativo?
“Credo che concetti come questi, quali la filosofia della musica, la ricetta con cui la si confeziona, vengano soltanto dopo la musica. Nella maggior parte dei casi, giungono quando la musica è finita. Quando scrivo musica, provo un mood, un’emozione o un sentimento (feeling). Scrivo, e la musica mi guida verso qualche destinazione. Così, non so dove andrò finché non ho finito di comporre musica. È un processo davvero imprevedibile. La musica ha il suo linguaggio, la sua grammatica. Quando scrivo, mi sento come se cavalcassi un’onda o qualcosa di simile. Faccio surf, per vedere dove ciò mi porterà”.
Il che non esclude che da questo moto imprevedibile, impercettibile, se non alla fine, non si possa trarre una filosofia della musica, pur non chiedendogli di farlo al compositore/musicista; Nietzsche deplorava che Wagner fosse l’interprete e anche l’ermeneuta della sua musica, e penso si debba dargli retta. L’artista segue l’ispirazione del momento, che poi elabora, ed è impegnato in un processo creativo che è ben diverso da quello del critico, cui non si chiederà di essere nel contempo esegeta della propria musica. Le annotazioni dalla viva voce di Sakamoto mostrano che, a dispetto delle intenzioni, egli stesso fornisce spunti su come intendere filosoficamente la propria opera o i suoi tratti teorici, il che non indica una contraddizione quanto piuttosto l’adozione di un’attitudine insopprimibile, grazie alla quale talvolta si teorizza sulla propria musica e le si dà un senso, mentre ciò non esclude che il critico o il filosofo possano trovare altri significati, inediti o ignoti al compositore. Per dirimere la questione, e giustificare, se solo ce ne fosse bisogno, ciò che sto scrivendo e un’analisi che ho già fatto su altri musicisti, basta sottolineare che il termine “filosofia” acquista qui un’accezione più ampia e meno angusta di quella della Storia della filosofia con la maiuscola, dove solo a certi scrittori viene attribuita, in base a criteri mutevoli, la patente o l’etichetta di filosofi.
Anche la metodologia di composizione dà adito a riflessioni speculative. Sakamoto stabilisce una connessione, lungimirante, ed evocativa, tra la cassa della batteria e la pulsazione del feto dentro l’utero, il che giustificherebbe la predilezione successiva dell’adulto per il ritmo, nel rap, hip hop o altrove, la connessione filosofica che “ci riporta al luogo, l’unico totalmente sicuro, in cui siamo stati”. Cosa altro è, se non qualcosa di filosofico, la sua concezione secondo cui fare musica dal vivo, in un concerto, non è un atto creativo? Ne colgo il nesso con i processi secondari freudiani, quelli del pensiero, dove si dice che essi elaborano un materiale già dato, e noto, senza poter pretendere di crearlo dal nulla, di crearlo tout court.
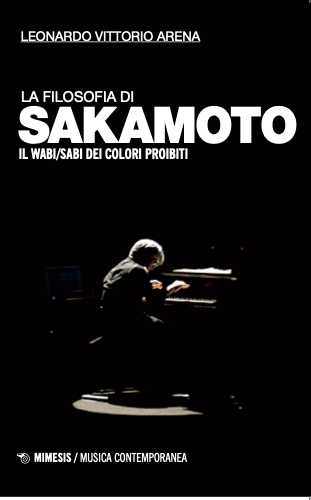
È strano, strano che lo dica un musicista imbevuto del classico, il quale ha strizzato l’occhio al jazz, e che sa quanto di improvvisazione il rock, pure, abbia generato, eppure eppure… Al di là della motivazione, che Sakamoto non stenta a trovare, c’è qualcosa nella sua posizione che sembra incontestabile e che può porci in sintonia con lui, quantunque ciò si spinga ai limiti del parossismo, dal punto di vista della pedagogia musicale, come quando, nello Sweet Revenge Tour del 1994, egli consente alla band soltanto di riempire i vuoti che la base registrata lascia scoperti, base che ha il ruolo dominante nel concerto; a Londra, una voce di donna dal pubblico, si leva sferzante, tra le pause tra un brano e l’altro, perentoria e graffiante, iconoclasta e forse reazionaria: “Ryùichi, ti vogliamo dal vivo!”.
La sperimentazione, in suo nome, si può fare, e dire, di tutto: Sakamoto procede sulla sua scia, imperterrito, e ciò legittima, in parte, una performance come quella citata, l’uomo contro la macchina, la quale ha il ruolo prevalente; “l’applauso remoto sulla nota Fa”. Ovvero: un concerto dal vivo, computer collegati in rete per spettatori coscienti, ciascuno può approvare, manda un segnale al server, la nota fa; come dire, mi piace, è tutto bello, la pressione di un tasto, un gesto semplice, quasi zen, o così lo diviene, o lo si legge, e poi, nella sala da concerto s’illumina uno schermo gigante, si contano i fa, si accumulano… C’è un collegamento a Internet, e spettatori in sala e musicisti vedono la reazione in real time, o soltanto con pochi secondi di delay, che possono fare di tutto, angosciare il musicista, bisognoso di approvazione, o inebriarlo: la performance è sempre più interattiva, al passo con la frenesia del nostro tempo, dove una pausa di un millesimo di secondo può farci pensare a una connessione lenta, stigmatizzandola, o farci sentire delusi per un messaggio che stenta ad arrivare… L’interazione tra la sala, il gruppo e la rete, è sullo sfondo, uno sfondo autorevole che si fa sentire… Se la musica è tempo, come Sakamoto ribadisce puntualmente, tutto ciò non comporta la recessione da un tempo lineare a uno virtuale, che tenderà sempre più a imporsi come il vero tempo – a che pro, dunque, la protesta della signora a Londra? C’è forse la possibilità di un concerto dal vivo, o ciò non ucciderebbe la spontaneità, l’immediatezza di una esecuzione che può soltanto dirsi in differita per il ritardo dei tempi, il delay dei tempi midi, per cui si invocano connessioni più efficienti o strumenti che non ci facciano angosciare se il segnale, il fa o qualsiasi altra nota, è pregno di attese? Modo per dire che, nel reame dell’interattivo, si sospende la dualità vero/falso, reale/virtuale, presenza/assenza fisica, con tutto quel che ne consegue.
Non c’è civiltà pura nel pianeta Terra, da qui Sakamoto fa esordire la sua analisi della cultura mondiale, con particolare riguardo per la musica: il suo amore per Debussy o Ravel non è marcato soltanto dalla Francia, ma anche dalle commistioni di entrambi i musicisti con altri mondi, il Giappone per il primo, il mondo islamico, in senso lato, per l’altro; non diverse considerazioni valgono per la ripresa da parte di Sakamoto di motivi di Tom Jobim, laddove la cultura portoghese o brasiliana si alimenta a svariate fonti, sempre ibride, l’armonia jazz, europea, e le melodie sudamericane: “Le civiltà sono sempre integranti e alimentantesi l’un l’altra, così il nord e il sud, l’est e l’ovest. Non ci sono barriere…”.
Nella stessa intervista, Sakamoto rivela la sua riscoperta della musica giapponese tradizionale, “in termini di silenzio e materiale”, la possibilità di utilizzare lo spazio tra le note, un tratto che può essere mediato anche da Cage, oltre all’amore del compositore americano per la combinazione probabilistica o casuale degli eventi, di contro al calcolo del compositore ottocentesco occidentale. Per quanto si sforzi, Sakamoto non riesce, né può trovare, un elemento comune che funga da collante tra i suoi molteplici interessi musicali delle sue opere, se poi questo esiste o è localizzabile, però, perché è un magma molto ampio quello che si profila. Del resto: “Amo le risonanze degli strumenti antichi (stava parlando della viola di gamba, NB). Esistono dei profondi legami dentro di me tra la musica antica e l’ecologia, ma sarebbe arduo spiegare quali. (…) Per me tutto è collegato”.
L’ecologia, certo, rispecchia una gran parte dei suoi interessi e del suo attivismo nella sfera sociale, la preoccupazione per il futuro del pianeta, ma anche la sua fiducia negli esseri umani, tratto che non condividerebbe con David Sylvian… Sakamoto ritiene che la musica possa svolgere un ruolo determinante nell’affrontare le problematiche ambientali. Quando l’intervistatore osserva che il suo modo di suonare il pianoforte suggerisce una alchimia di nostalgia e tristezza, da un lato, e anche, dall’altro, una grande speranza per il futuro, Sakamoto non lo nega, ma non accompagna questa speranza con una vena ottimistica, che sarebbe fuori luogo.
Tutti questi tratti e molti altri emergono dalla autocoscienza del compositore, il quale si mette a nudo, diciamo fino al 2001, nella sua autobiografia musicale Ongaku wa jiyù ni suru, una raccolta di alcuni articoli e/o interviste per la rivista Engine, da cui traspare la sua confessione misurata.
È di qualche aiuto già il prologo, una rassegna del passato, ma anche del suo presente e del futuro, che attinge alle scuole primarie: alla domanda cosa vuoi fare da grande, Ryùichi risponde che non vuol essere nulla o nessuno, una vocazione cui crede di esser stato fedele, se non altro per i suoi molteplici interessi, che lo hanno portato a rivestire i panni dell’attore cinematografico, o del compositore di colonne sonore, non solo nei film in cui recitava, del musicista di gruppo, la Yellow Magic Orchestra (YMO), dove cantava anche, e così via – il “così via” apre inauditi orizzonti espressivi.
L’altro tratto preliminare è il riconoscere che in lui c’è sempre stata una contraddizione (sogu; anche: conflitto); per esempio, la sua appartenenza alla YMO, e nel contempo la fierezza di mantenersi integro, un solista, il fatto che nello stesso gruppo, in una dimensione collettiva, scopre la propria vocazione peculiare e il suo mondo musicale.
E poi, in ordine sparso: il Sakamoto che non è entusiasta di fare pratica al piano, sin da quando, a tre anni, lo si costrinse a farlo, in una scuola sperimentale di Tokyo, un musicista in erba che già sente, per pigrizia o intuizione, che la via alla creatività o all’espressione non può essere quella; la difficoltà del mancino, il quale deve adattare la sua visione del mondo al pianoforte, in quanto la sinistra accompagna e la destra sottolinea melodie, mentre lui sente di dover fare il contrario, e trova conforto in Bach, dove i ruoli delle mani talora si scambiano e la sinistra riprende il canto della destra; la riluttanza, in svariati periodi della giovinezza, a dedicarsi totalmente alla musica, sentendo che forse la sua vocazione non è quella o principalmente quella; l’amore per i Beatles, nato da I Want To Hold Your Hand, e bilanciato, all’inizio, da Tell Me degli Stones, primo disco acquistato; gli Stones più sporchi – in seguito, li direbbe punk –, e perciò anche più adatti dei Beatles come modelli; questi ultimi un influsso più duraturo, è vero, ma non ci sono sue cover beatlesiane, al contrario di quella, magistrale, di We Love You, una scelta azzeccata; gli Stones stonati, per il ragazzo che studia pianoforte con atteggiamento perfettino; poi gli arrangiamenti e le armonie lo spingono verso i Beatles; l’interruzione, anche se breve, dell’attività musicale per la pallavolo, più tardi rifiuto degli eventi sportivi, la ripresa di una vocazione inavvertita – il proprio talento lo si scopre tardi o forse non si vorrebbe farlo; le prime letture significanti, Georges Bataille, Madame Edwarda e Histoire de l’oeil – sulla scia di Mishima, il quale, pure, si abbeverò ai testi filosofico-erotici della cultura francese novecentesca, Histoire d’O sullo sfondo per entrambi; poi la lettura di Burroughs, non solo per lo spirito del tempo: Il pasto nudo; e poi ancora… ma sì: la filosofia! – la Fenomenologia dello spirito, un Hegel di cui non ricorda nulla, attrazione per il filosofico, forse non corrisposta; grande coacervo di influssi musicali, persino il jazz, che non lascerà molta eco nelle sue opere, per quantità e non per qualità: un mondo variegato, spiccano nomi celebratissimi: Thelonious Monk ed Eric Dolphy, ma soprattutto Coltrane – l’Asia del sax soprano, una volta di più?; dal jazz al filosofico, di nuovo: letture al ‘68: Marx, Manoscritti economico-filosofici del ’44, Saggio sull’imperialismo di Lenin, superfluo dirlo, Il Manifesto del partito comunista…; ma anche la mainstream nipponica, i visionari, Kòbò Abe, altra lettura obbligata dell’epoca, poi la raffinatezza triste, sublime, di Kenzaburò Òe; infine, a concludere un ciclo, quello liceale (!), la vasta gamma dei musicisti classici contemporanei: Strawinskij e Schönberg, Bartok, il conterraneo Tòru Takemitsu; il minimalismo che lo intriga moltissimo: Terry Riley, con le sue incursioni/evocazioni indiane (“La cosa più impressionante era sentirlo suonare l’organo in maniera impetuosa…”); il gamelan indonesiano, che dovette abbagliare il suo idolo, Debussy, il quale, come un asiatico, canta del mare e delle nubi, una musica fluttuante che può rammentare a un giapponese la pittura ukiyoe e la transitorietà del samsàra, dell’universo, un nirvàna che non potrebbe distaccarsene…; a chiudere un capitolo, mentre si veleggia verso il Sé, in tonalità junghiane, archetipiche, la questione di come inserire il Giappone nell’area della musica mondiale, ovvero della propria, l’idea che la musica occidentale sia finita in un vicolo cieco, e che, da parte sua, se ne attenda un rinnovamento, una musica planetaria, che tutti possano capire ma che, nel contempo, inglobi molti aspetti dell’avanguardia, dell’elettronica, mentendosi semplice e difficile al tempo stesso: un Sakamoto pop, ma pop sperimentale, il progetto degli anni a venire, quando la sua strada incrocia quella di altri due musicisti, e si forma YMO, ma prima c’è un disco solista, Thousand Knives, che segna l’inizio della sua carriera, il distacco dall’attività di musicista da studio (“lavoro nichilista”, come lo chiamò) verso quel quid misterioso che lo spinse dentro se stesso, il Sé junghiano, si diceva, non a torto…


