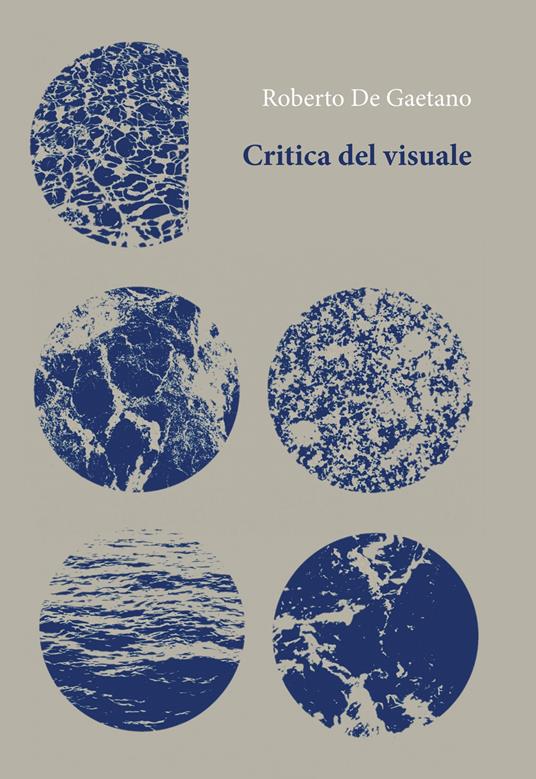Roberto De Gaetano (Roma, 1965), laureatosi alla Sapienza di Roma, docente all’Università degli Studi di Torino e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e visiting professor all’Università di Chicago, insegna attualmente Filmologia presso l’Università della Calabria. Ha fondato nel 2006 il quadrimestrale Fata Morgana, di cui dal 2017 è attiva anche una versione web. Tra le sue ultime pubblicazioni, La potenza delle immagini (2012), un Lessico del cinema italiano in tre volumi, Cinema italiano: forme, identità, stili di vita, vincitore del premio Limina, e Le immagini dell’amore.
A ottobre ha pubblicato Critica del visuale (Orthotes Editore, 2022), un’ambiziosa raccolta di saggi brevi che traccia un percorso di vera e propria meta-critica accademica.
Ludovico Cantisani: Critica del visuale, la sua ultima pubblicazione appena edita da Ortothes, sin dal titolo si propone l’ambizioso compito di affrontare di petto una delle categorie critiche più usate e abusate degli ultimi anni (o decenni): il Visuale, concetto-spugna a cui fin troppe volte si è fatto riferimento perdendo di vista le differenti specificità del linguaggio filmico, televisivo e audiovisivo in genere.
Da cosa nasce la sua insofferenza verso questo concetto-fiume? Quali altri concetti vorrebbe proporre in alternativa, per affrontare criticamente la marea di materiali audiovisivi che sempre più spesso affollano i nostri occhi?
Roberto De Gaetano: L’ideazione e la circolazione di una categoria, a maggior ragione quando questa manifesta un indubbio successo, non può essere spiegata con ragioni di efficacia epistemologica. Sono i sentimenti, le motivazioni, e gli interessi profondi presenti in un dato momento storico quelli che guidano il carattere selettivo di scelte teoriche e lessicali. Tali scelte non sono mai dunque svincolate da ciò che accade nella vita sociale complessiva di un paese o di una parte del mondo (quella occidentale). Ebbene, la nozione di visuale si è imposta in forma concomitante a processi complessivi di destoricizzazione e destrutturazione dell’esperienza empirica determinata a vantaggio di adesioni ideologiche a quella che potremmo chiamare una totalizzazione satura del reale, animata da pure logiche di scambio che hanno mancato radicalmente le dinamiche d’uso. L’uso delle immagini – estetiche o meno – ha un peso molto maggiore nell’esperienza concreta determinata di spettatori e fruitori rispetto al loro scambio. Anche quando il loro uso diventa abuso. Cioè quando si trasformano le immagini stesse con il loro potenziale estetico in meri dispositivi di conversione. Questo abuso, quando c’è, se pensato dal punto di vista dell’esperienza concreta e singolare dell’usare le immagini, manifesta tutta la sua problematicità. Quando invece viene eluso, attraverso la totalizzazione categoriale, diventa teorema. Il visuale è un teorema, che corrisponde su un piano culturale allo scambio illimitato dell’economia neoliberale. È un teorema che permette lo scambio senza fine di tutto con tutto. L’uso delle immagini, invece, anche nel raccordo e nella comparazione delle immagini stesse, mantiene il suo irrinunciabile carattere problematico, che ci preserva da derive totalitarie. L’uso delle immagini apre direttamente ad un pensiero critico delle immagini stesse. Perché la pratica comparativa è sempre caratterizzata da un tratto di problematicità, evidente dalla centralità che assume il principio e il metodo di montaggio, da Warburg ad Ejzenštejn fino a Didi-Huberman. Metodo e principio che escludono ogni generica adesione totalitaria al piano indifferente del visuale.
“La concettualizzazione generica e totalizzante del discorso accademico da un lato, e la moltiplicazione sterile della mini-recensione nel discorso giornalistico dall’altro hanno annullato la forma stessa del pensiero critico”, si legge in Critica del visuale. Quale terza via Lei identifica per ridare alla critica la sua dignità e la sua funzione.
La critica è un gesto che parte dall’interrogazione riflessiva della singolarità dell’oggetto con cui si rapporta. Ed è pertanto un discorso che resiste e si pone in contrapposizione sia a categorizzazioni totalitarie (come quella di visuale), sia a discorsi ancillari che eludono l’oggetto costruendosi come addensati veloci di cliché, quasi sempre istruiti e dettati dagli uffici stampa, di cui sono sintomo l’uso di stellette per sintetizzare il giudizio. Categorizzazione astratta o elusione recensiva ignorano la determinatezza e singolarità dell’opera di cui invece la critica deve tenere conto. Ma questo non è ancora sufficiente a definire il proprio di un discorso critico. Che deve essere anche capace di estrarre dall’oggetto, con metodo empirico ed induttivo, idee e schemi interpretativi in grado di proiettarsi anche su un asse temporale. In grado cioè di operare periodizzazioni in cui tradurre l’interpretazione delle immagini e delle opere e la loro storicità. Ogni spettatore appassionato, vedendo un film costruisce naturalmente, sia su un asse sincronico che diacronico, comparazioni e connessioni. Dunque costruisce degli schemi – più o meno impliciti – di raccordo e di senso tra le opere. Questi schemi sono quelli che guidano – o dovrebbero farlo – anche le riflessioni critiche, da cui scaturirebbero sia le periodizzazioni storiche, che altrimenti si ridurrebbero a meri elenchi di date e nomi, sia le riflessioni teoriche, che senza base critica, cioè senza rapporto con il dato empirico, resterebbero astratte.
I dieci capitoli di Critica del visuale fanno riferimento nelle sue argomentazioni a numerosi maestri della critica: tra questi il più vicino, cronologicamente a noi, è Serge Daney, forse il più celebre esponente della “seconda generazione” dei Cahiers du Cinéma, ma non mancano veri e propri filosofi come Walter Benjamin, fino a risalire all’Ottocento con Friederich Schlegel. Se dovesse tracciare un breve elenco, quali sono i “numi tutelari” del suo pensiero critico, anche se non per forza citati nella sua ultima pubblicazione?
Per il cinema non c’è alcun dubbio che i critici cinematografici più rilevanti siano stati André Bazin e Serge Daney. E questo per una capacità unica di guardare e leggere i film, facendone emergere idee decisive per la comprensione del cinema stesso. Hanno entrambi tenuto insieme nel modo più alto l’empiricità del filmico e l’universalità del cinematografico. Rompere questo nesso sarebbe nefasto, perché il filmico rimarrebbe cosa muta, o sarebbe – sganciato dal cinematografico – strumentalmente utilizzato per altri fini (per meri contenuti o semplificanti ideologie); e il cinematografico senza il filmico darebbe vita ad una teoria come categorizzazione astratta senza alcuna incidenza sulle cose. Mi è capitato di scrivere che la teoria per essere interessante deve essere sempre “impura”, cioè deve misurarsi con l’empiricità del dato (in questo caso del film), così come la critica per essere incidente deve avere un portato teorico, cioè liberare nell’incontro con l’opera tutto il potenziale di idee di quest’ultima. Come non pensare al nesso istituito da Bazin tra lettura del cinema neorealista e approfondimento della categoria del “realismo” al cinema, o alle parole anticipatrici di Daney che, per leggere certi autori francesi come Besson, li derubrica sotto la categoria di visuel, che eluderebbe ogni mediazione critica? Altri autori hanno contribuito a comporre una costellazione di nomi per me importanti in questo specifico campo di riflessione: Walter Benjamin, Northrop Frye e Stanley Cavell. Se al primo dobbiamo una ripresa delle grandi teorie romantiche dell’opera d’arte come depositaria di una verità che può venire alla luce solo attraverso il discorso “prosaico” della critica, e al secondo dobbiamo la più potente schematizzazione categoriale della critica novecentesca, Anatomy of Criticism, a Cavell e al suo volume sulla commedia del ri-matrimonio, Pursuit of Happiness, va riconosciuto un ruolo significativo nella valorizzazione del portato etico e critico delle singole opere e dei singoli generi (oltre alla commedia anche il melodramma), decisivo per la ricomprensione della nostra esperienza ordinaria di spettatori.
Sin dalle prime definizioni del concetto di critica esposte nel suo volume – “la critica emerge in prima istanza come discorso che media tra l’opera e il pubblico, e mediando educa quest’ultimo, lo sottrae ad un’adesione indifferenziata alle forme di discorsività imperanti” – Critica del visuale sembra manifestare una derivazione meditata dall’immaginario concettuale di Gilles Deleuze. Quali pensa siano i maggiori punti di forza della sperimentale “tassonomia cinematografica” esposta tra L’immagine-movimento e L’immagine-tempo? Pensa che ci siano anche dei limiti, nella visione deleuziana del cinema?
Parlare de L’immagine-movimento e de L’immagine-tempo significa parlare dei due tomi che negli anni ottanta hanno segnato il pensiero del cinema, orientando diverse generazioni di studiosi, e creando la cornice per la costituzione del fortunato campo disciplinare della filosofia del cinema (campo che però in quanto tale non vuol dire molto). Per quel che riguarda il nostro specifico discorso, L’immagine-movimento e L’immagine-tempo sono un esempio potente di resistenza a qualsiasi idea di visualità indifferente e totale. Le immagini sono forme espressive del reale – pensato sia nella sua dimensione attuale che virtuale – e contano per il modo in cui portano ad espressione un problema come identificativo di un modo di essere: percettivo, attivo, affettivo, pulsionale, rimemorante, noetico. L’espressività delle forme filmiche (inquadrature, sequenze, generi, stili autoriali) e delle idee cinematografiche ad esse connesse (tassonomia delle immagini) trovano il loro fondo comune – mediato dalla metateoria bergsoniana – in una identità radicale tra cinema e reale: esemplificata ne L’immagine-tempo dal fatto che la classificazione stessa delle immagini viene costruita facendo a meno della stessa parola immagine, ancora presente ne L’immagine-movimento. E così abbiamo “cristalli di tempo”, “falde di passato”, “punte di presente”, “potenze del falso”, come tante articolazioni dirette di un reale, i cui modi d’essere, determinati e distinti, sono indistinguibili dalle immagini. L’immagine è la potenza espressiva di un modo d’essere del reale. E dunque ben distante dall’essere elemento oggettivo e tecnico neutro (picture), disponibile alla convertibilità totale con altre immagini su un piano illimitato di visualità anonima.
(Orthotes Editrice, 128 pag., 2022)
Più volte nel saggio Lei fa riferimento anche ad affermazioni e riflessioni del recentemente scomparso Jean-Luc Godard, che nella sua sessantennale esperienza registica non ha mai abbandonato le sue originarie radici da critico dei Cahiers du Cinéma, realizzando una forma di cinema che fosse meta-critica, e critica dell’immaginario nel suo complesso. In che modo dal suo punto di vista nel cinema di Godard regia e critica hanno interagito tra loro, soprattutto in operazioni come Histoire(s) du cinéma o il più recente Livre d’image del 2018?
Critica ed arte sono distinti in merito al senso e al valore sociale che hanno, ma non rispetto alla “procedura di verità” (per riprendere una espressione di Alain Badiou) che attivano: l’arte parla del mondo “poeticamente”, cioè in forma più immediata (se questo termine può avere un qualche senso), la critica ne parla “prosaicamente”, cioè attraverso l’esplicita mediazione dell’opera. La critica cioè abita uno spazio di mediazione più esplicito e più marcato rispetto all’opera d’arte. Per questo molti registi partono come critici prima di arrivare alla regia. Ma spesso continuano ad esserlo anche dopo, continuano ad accompagnare la loro “pratica” con un’attività riflessiva costante sia sul loro “fare” sia su quello degli “altri”. Attività formativa (produttiva) e attività riflessiva entrano in gioco entrambe, con accenti diversi, in quei composti che chiamiamo “opere d’arte” o “riflessioni critiche”. “Pensare con le mani” dice il Godard di Livre d’image, ponendosi come esempio magistrale della riflessività della forma inscritta esplicitamente nella materialità del processo creativo. Che dunque procede attraverso esplicite mediazioni critiche di immagini della storia del cinema e di discorsi (Histoire(s) du cinéma). Se la critica rende esplicito il tratto di riflessività implicito nell’opera, quando questo tratto è l’opera stessa ad esplicitarlo significa che quest’ultima manifesta direttamente la mediazione critica. La posta in gioco – come sempre in Godard – sarà parlare del mondo, l’unica cosa che davvero conta. E sapere che parlarne significa tener conto delle altre immagini e degli altri discorsi che ne hanno parlato. E dunque creare riflettendo: “Une forme qui pense, une pensée qui forme” dirà del cinema nelle Histoire(s). Il metodo di questo processo creativo esplicitamente e criticamente mediato sarà, anche per Godard, il montaggio. Ogni immagine è sempre nel montaggio, è sempre almeno “due”, e dunque strutturalmente resistente ad ogni logica di mero scambio visuale.
Al termine del capitolo La contingenza della forma, fa fuggevolmente riferimento al controverso biopic su Silvio Berlusconi firmato da Paolo Sorrentino, scrivendo che “il dominio delle categorie cosmiche anche in ambito estetico e culturale ha corrisposto al dominio del pensiero neoliberale, determinando una saldatura politico-estetica, culturale-scientifica, di cui un film come Loro di Sorrentino è un esempio significativo”. Potrebbe approfondire il suo pensiero sulle ambiguità e le insufficienze di Loro di Sorrentino?
Sorrentino – perlomeno in Loro – è l’esempio opposto a Godard. La sua forma si attua attraverso una saturazione acritica del visibile. È un esempio di quel cinema del visuale incriticabile, dove le immagini sembrano prosciugare ogni alterità del reale, risolvendosi in una monoplanarità senza scarto. Ho parlato, in Cinema italiano: forme, identità, stili di vita, ampiamente del film, evidenziando come l’estetizzazione crepuscolare della forma che lo anima ha necessitato del crepuscolarismo di un Berlusconi vecchio. All’opposto, Moretti nel Caimano ha smontato il personaggio pubblico Berlusconi nel pieno della sua presenza politica, restituendolo attraverso tre maschere. Questa scomposizione, in quanto articolazione di un continuum, è già di per sé critica nei confronti di ciò di cui parla. E si predispone più naturalmente ad entrare in una discussione pubblica articolata e segnata da un esplicito pensiero critico nei confronti del presente. Ciò significa che la critica è incentivata e alimentata dal carattere interrogativo e problematico dell’opera che ha di fronte, come nel Caimano, o è resa più difficile dal blocco di visualità estetizzante e compatta, come in Loro. Se un’opera non pone domande e tende ad eludere la mediazione critica, parlarne diventa difficile, e forse anche inutile.
Uno dei capitoli più originali e se vogliamo più sofferti del suo ultimo libro, il quarto, si apre con la domanda: “perché la critica cinematografica è di fatto scomparsa in Italia?”. Innanzitutto, secondo Lei a cosa si deve questo deficit?
La questione in Italia è complessa e va vista in termini genealogici. Le difficoltà della critica cinematografica italiana affondano le radici nella prima parte del Novecento, quando la filosofia neoidealista, Croce e Gentile per intenderci, ha mancato il rapporto con la nuova arte e con le immagini. A differenza della Francia, dove il pensiero di Bergson da un lato, e la declinazione francese della fenomenologia, con Sartre e Merleau-Ponty dall’altro, hanno messo al centro la questione delle immagini, dell’immaginazione, dell’immaginario e della percezione; determinando con questo il contesto più favorevole per sviluppare un discorso critico specificatamente cinematografico, come quello di Bazin nell’immediato Secondo dopoguerra, che poi ha avuto sbocco nella fondazione dei Cahiers du cinéma, nella nascita della Nouvelle Vague ecc. In Italia, invece (tranne rare eccezioni), il discorso critico sul cinema è stato sempre trainato da un più generale discorso ideologico-culturale (marxismo prima, semiotica poi, visual culture oggi) che ha teso ad includere le opere in categorie concettuali fagocitanti, pensate prima e altrove.

In che modo, attraverso riviste da lei fondate e/o dirette tra cui, in primis, la storica Fata Morgana, ha cercato praticamente ed editorialmente di risollevare le sorti della critica cinematografica italiana?
Fata Morgana quadrimestrale prima, per quanto riguarda la teoria, Fata Morgana Web più di recente, per quanto riguarda la critica, hanno provato a costruire dei campi alternativi. A partire da un’idea di fondo. Se parti da un concetto, e dunque dalla teoria, devi saperne misurare tenuta, effetti e plasticità dall’incontro effettivo con le opere: devi sapere cioè costruire una “teoria impura” (una intera sezione di ogni fascicolo monografico di Fata Morgana è dedicata proprio a questo “uso empirico” del concetto, si apre cioè programmaticamente all’“impurità”). Se invece parti dalle opere, e dunque dalla critica, devi saperne tirare fuori e rendere esplicite le idee che l’opera singolare contiene in sé in forma implicita, e dunque devi saper costruire una “critica riflessiva” (questo è stato ed è il compito di una rivista di critica come Fata Morgana Web).
La lettura del suo Critica del visuale solleva e in fondo lascia aperta la risposta alla domanda se esiste effettivamente uno specifico critico, oltre al tanto dibattuto specifico filmico. Lei cosa risponderebbe?
Se la critica è un gesto, che presuppone l’esistenza di un campo sociale articolato di discussione, tale gesto contribuisce a ridefinire e ad ampliare tale campo attraverso una serie di atti. Atti critici, appunto. Riconoscere l’importanza di tale campo è decisivo per una cultura, perché permette di evitare l’uniformità e il conformismo di posizioni totalitarie. All’interno di tale campo le forme del discorso critico devono sapere tener conto della singolarità degli oggetti e del loro portato di idee. Il raccordo tra i primi e le seconde definisce la specificità della forma critica, che nei suoi momenti più alti riguarda sempre anche la comprensione e la riconfigurazione delle forme di vita individuali e collettive. Parlare del cinema significa parlare del mondo. E parlarne criticamente, a partire dal nostro desiderio profondo di spettatori, significa pensare sia il cinema sia il mondo non solo nella possibilità di poter essere compresi, ma anche cambiati. Per questo la critica ha sempre una portata etica, di cui spesso ci si dimentica.