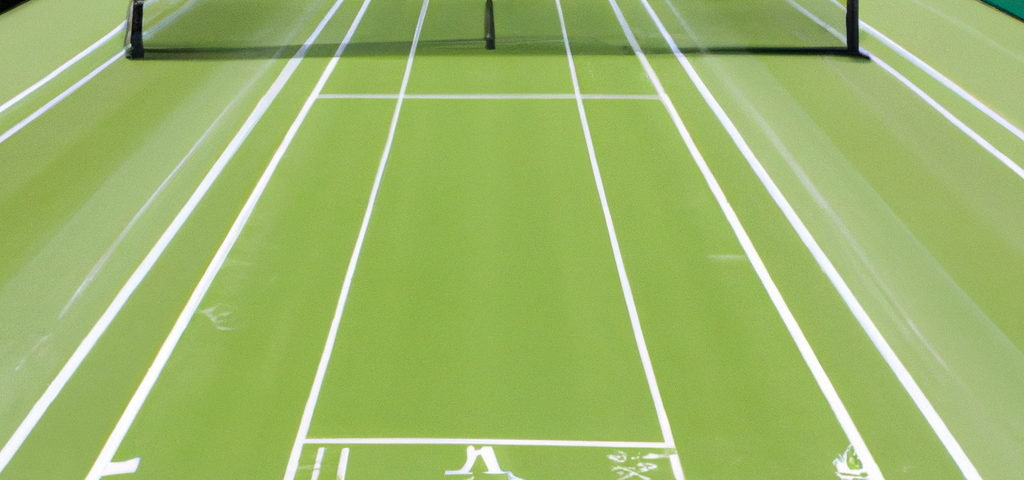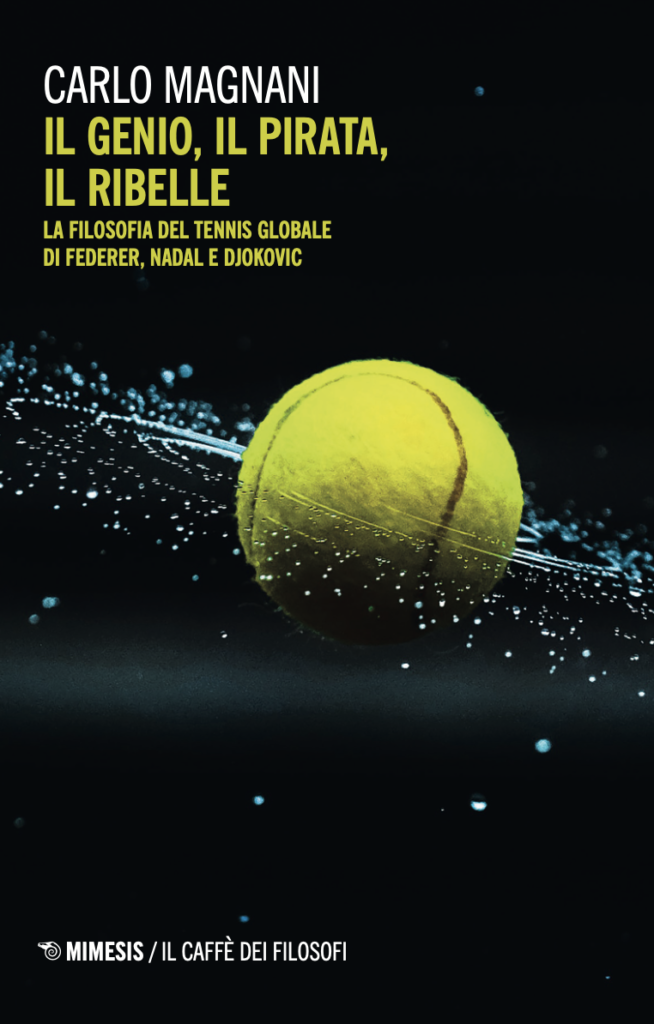Con una lettera condivisa il 15 settembre 2022 sui suoi profili social, Roger Federer ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal mondo del tennis, dopo più di vent’anni passati sui campi da gioco. Adesso che questo sport ha perso uno dei suoi Big Three, cosa possiamo aspettarci per il futuro?
Lo abbiamo chiesto a Carlo Magnani che, con il suo ultimo libro Il genio, il pirata, il ribelle (Mimesis, 2022), ha trattato non solo di tennis ma anche filosofia, focalizzando l’attenzione sui tre grandi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia: Nadal, Federer e Djokovic.
Gaia Oliverio: Poche settimane fa abbiamo assistito ad un importante momento nella storia del tennis: il ritiro ufficiale di Federer dai campi da gioco. Lei stesso, nelle pagine del suo libro, ha definito Nadal, Djokovic e Federer i Big Three, adesso che è venuto meno uno dei pilastri di questo sport, possiamo dire che si è chiusa un’era? Cosa possiamo aspettarci dal futuro?
Carlo Magnani: Sì, si è chiusa un’era, quella di Roger Federer. Però, restando fedele all’idea althusseriana che la “storia è un processo senza fine e senza soggetto”, non ne trarrei conclusioni frettolose dettate dalla emotività. Il rischio che vedo è quello della celebrazione della “fine del tennis”, dopo Federer il nulla. Sarebbe una profezia errata, come quella molto celebre di Fukuyama sulla “fine della storia”, poi smentita dai fatti. Intanto restano in attività gli altri due Big Three, Nadal e Djokovic, che sono ancora molto competitivi. Poi ci sono vari giocatori, anche giovanissimi, che stanno animando il circuito. La situazione è un po’ bloccata soprattutto a livello psicologico. Da un lato, abbiamo degli “anziani Regnanti” che non vogliono mollare il Potere e che usano tutta la loro esperienza e saggezza; dall’altro, dei Giovani Leoni intimiditi che preferiscono rimanere nell’ombra per non perdere l’illusione che tutto è ancora possibile, che il futuro è ancora là davanti. È la dialettica del Puer e del Senex di cui parla Hillman. Il futuro ci riserverà ancora delle sorprese, soggettivizzare troppo non serve, si perde di vista il contesto. Il guaio è che il tennis assomiglia molto alla società globalizzata, nell’ultimo decennio vi è stata una concentrazione di vittorie in mano a pochi grandi competitori, abbiamo vissuto l’epoca di una oligarchia illuminata. Ecco, questo dato mi pare destinato a tramontare, non si vedono nuovi Signori all’orizzonte.
Ha definito Federer come “il messia del tennis, colui che è morto tante volte ed è sempre resuscitato”, che “si fatto davvero uomo per riportare un po’ di Luce in un mondo secolarizzato”. In questo senso, qual è, secondo lei, il più grande miracolo che è riuscito a compiere?
Federer ha rappresentato un momento di trascendenza in un contesto del tutto laico e secolare. Il tennis globale rispecchia pienamente i caratteri della società globale: in entrambe dominano la potenza, il calcolo, la tecnica, cioè il nichilismo. Federer ha dato l’illusione di poter superare tale immanentismo assoluto proponendo una teologia tennistica. Foster Wallace ha parlato a proposito di “esperienza religiosa”. Con Federer la volontà di potenza ha trovato modalità espressive in grado di fare sorgere domande di senso: su tutte quelle relative alla bellezza. Attenzione però: il suo gesto tennistico non è meno efficace e violento di quello degli altri campioni. La magia, il suo genio, consiste nel fatto che tale gestualità riesce a rimandare a qualcosa d’altro. Le sue vittorie sono state spesso tribolate, non ha sfruttato mai le tante palle utili avute per chiudere un set o strappare il servizio all’avversario. All’inizio della carriera era più facile vederlo perdere che vincere, tra le Belle Promesse dei primi anni duemila era quello meno vincente. I giornalisti del settore sostengono che avrebbe potuto vincere di più. Poi ci sono stati gli infortuni e gli inciampi, primo fra tutti trovarsi di fronte un mostro di pura forza come Nadal. Forse la Pasqua di resurrezione di Federer è stata la finale 2017 degli Open di Australia, quando si è ritrovato in finale con il solito Nadal: nessuno dei due veniva da un periodo esaltante e la finale fu una sorpresa per entrambi. Giunti al quinto set, Roger era sotto di 1-3 e pareva ormai ripetersi il destino che vede Ettore soccombere sotto i colpi di Achille: invece fu la nemesi. Federer fu quanto mai cinico e risoluto, rapido e veloce a portarsi a casa il trionfo.
(Mimesis, 112 pag., 2022)
Conclude il libro sostenendo che in futuro sarà molto più difficile che in passato trovare delle peculiarità che facciano emergere un giocatore dalla massa e che, dunque, “il rischio è quello di doversi accontentare di differenze minime, basate su sfumature e dettagli in un contesto di assoluta omologazione e conformismo”. Alla luce di ciò, secondo lei, ad oggi, c’è un giocatore, sia nel panorama nazionale che internazionale, che possa sfuggire a questo processo di omologazione che il tennis ha pian piano subito nel corso degli anni?
Il tennis del futuro rischia parecchio, serviranno delle grandi personalità, come quella di Djokovic, ad esempio, per evitare che il dominio della tecnica stenda un velo di conformismo poco attraente. Ormai giocano tutti alla stessa maniera, e questo è un dramma. Anche qui il parallelo con la società dell’età globale è calzante: se un unico grande “pilota automatico” governa le società, non c’è spazio per il pluralismo. Ritengo che il giocatore più inattuale, il vero resistente alla omologazione, non è stato Federer ma il francese Gasquet, che ha vinto pochino, ma che aveva le movenze per giocare ancora con le racchette di legno: poteva essere benissimo un campione degli anni Quaranta. In Italia siamo giunti da poco al tennis postmoderno contemporaneo, con Berrettini e Sinner, ci abbiamo messo più tempo di altre Nazioni. Però c’è ad esempio Lorenzo Musetti che gioca un po’ come la tradizione moderna voleva: Musetti si riallaccia alla tradizione nazionale italica di tocco e fantasia. Personalmente amo il tennis della tradizione moderna, cioè quello degli anni Settanta e Ottanta, il tennis che ha gettato le basi di ciò che c’è oggi, ma la contemporaneità ha ormai voltato le spalle a quella tradizione. Il greco Stefanos Tsitsipas fa rivivere la tradizione del tennis classico che deriva dalla linea Sampras-Federer. Insomma, l’epoca del nichilismo e dell’immanentismo assoluto domina il tennis, e chi apre uno spiraglio verso la trascendenza può diventare una vera risorsa.
Ci sarà mai, secondo lei, una democratizzazione del tennis nel vero senso della parola?
Il tennis nasce nelle corti del Seicento, quindi non può essere democratico. I circoli cittadini dove vive la “costituzione materiale” del tennis risentono di una certa atmosfera elitaria. Tuttavia, esistono le personalità democratiche. Il tennis della tradizione moderna che citavo prima ne è stato un grande esempio. Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli, tutta la squadra di Coppa Davis del 1976 era di fatto espressione di ceti popolari. Così come lo stesso Borg. Oggi, non so se un “ragazzo del popolo” possa ancora divenire un campione, la specializzazione tecnica ha anche alzato i costi della formazione. Dei Big Three, l’unico di estrazione popolare è Djokovic, che non a caso è anche il più “politico” dei tre, nel senso che è molto vicino ai valori della sua comunità. Vedo però che non è abbastanza “politicamente corretto” per piacere alla stampa mainstream.
Sentiamo spesso parlare di tennis maschile mentre quello femminile, che, come ricorda lei “offre le storie e i personaggi più interessanti nel primo decennio del Duemila”, viene messe un po’ in disparte. A questo proposito, le viene in mente un paragone come quello tra Federer-Heidegger ma tra una tennista e qualche filosofo del passato?
Da qualche parte ho degli appunti in cui provavo a mettere in relazione le grandi tenniste con le maggiori filosofe. Il dualismo tra Martina Navratilova e Chris Evert è senza dubbio uno dei casi più interessanti da analizzare. Così come Billie Jean King, e la lotta per l’emancipazione: ecco, lei potrebbe essere una ideale Mary Astell. Lea Pericoli, qui da noi, è stata una antesignana, una vera Aspasia di Mileto del tennis. La bella Gabriela Sabatini potrebbe discutere sul mistero di Eros nel Simposio, come Diotima. Chris Evert incarna i valori della tradizione vittoriana, mentre la Navratilova è di certo più schierata sul fronte riformatore. Per tornare alle italiane, Simona Vinci potrebbe personificare le inquietudini di una Zambrano. Volendo c’è materia.