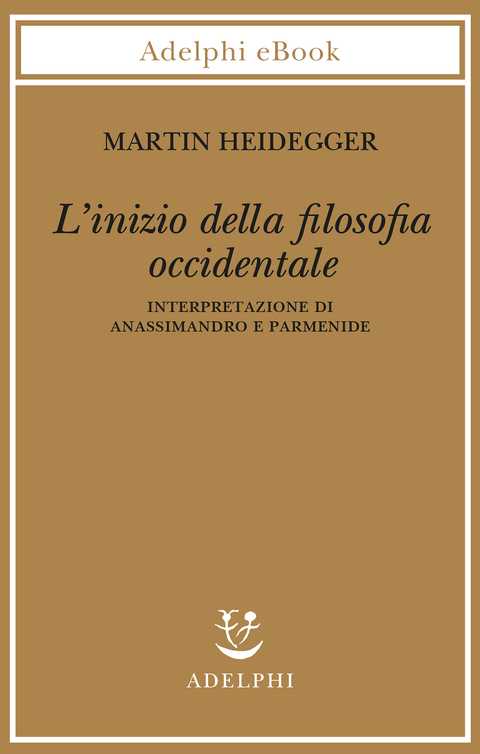Giovanni Gurisatti è professore associato di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova. Si occupa prevalentemente di filosofia e di estetica tedesche tra Ottocento e Novecento, e, in particolare, dell’opera di Schopenhauer, Heidegger, Benjamin. La sua prospettiva di ricerca riguardante l’ermeneutica heideggeriana è stata sviluppata nelle monografie L’animale che dunque non sono. Filosofia pratica e pratica della filosofia come est/etica dell’esistenza (Mimesis Edizioni, 2016), ed Est/etica ontologica. L’uomo, l’arte e l’essere in Martin Heidegger, (Morcelliana, 2020). Ha inoltre tradotto e curato una parte importante delle opere di Heidegger edite per Adelphi, condividendo e proseguendo il percorso iniziato da Franco Volpi.
La sua curatela più recente è L’inizio della filosofia occidentale. Interpretazione di Anassimandro e Parmenide, che riporta un corso tenuto da Heidegger a Friburgo nel semestre estivo del 1932, uscita a settembre per i tipi della casa editrice milanese.
“La traduzione è sempre il risultato e la sintesi ultima di un’interpretazione”, dice Heidegger nel primo capitolo del testo, “non è mai un mero sostituirsi di una lingua straniera alla lingua materna, poiché presuppone la capacità di tra-dursi, con la forza originaria della propria lingua, nella realtà del mondo che si manifesta nella lingua straniera”. Partendo da quest’ultimo volume abbiamo intervistato il professor Gurisatti sul suo pluridecennale percorso di frequentazione dei testi heideggeriani, e sulla complessità della traduzione delle opere del pensatore tedesco.
Ludovico Cantisani: Qual è stato il suo percorso di filosofo e studioso, e quando si è accostato per la prima volta all’opera di Martin Heidegger? A che punto della sua carriera parallelamente al percorso universitario si è aggiunta anche l’esperienza di curatela editoriale e di traduzione dal tedesco?
Giovanni Gurisatti: In verità il mio percorso di studi non iniziò come “filosofo”, poiché secondo lo spirito del tempo nel 1976 cominciai a frequentare in modo “militante” i corsi presso lo IUAV di Venezia, con indirizzo urbanistico e storico. Tuttavia, proprio nel contesto veneziano si stava discutendo molto, a partire dal Krisis di Massimo Cacciari (1976), del “pensiero negativo” centroeuropeo – tra Vienna fin de siècle e Repubblica di Weimar –, da Nietzsche a Simmel, da Wittgenstein a Freud, da Benjamin a Heidegger, e così via. Oltre ai vari saggi di Cacciari sul tema, e alla Gaia scienza di Nietzsche, nel marzo 1979 mi capitò per le mani un numero monografico di “Nuova Corrente” (nn. 76/77 del1978) dedicato a Heidegger, cui seguì immediatamente la (vorace, ma faticosa) lettura di Sentieri interrotti e di Saggi e discorsi; nel medesimo tempo incontrai l’Angelus Novus, l’Opera d’arte e il Dramma barocco di Benjamin – una “polarità”, quella tra Heidegger e Benjamin, destinata a segnare tutta la mia Weltanschauung filosofica. Fu in seguito a questi “eventi” che nel 1980 abbandonai lo IUAV per trasferirmi a Filosofia a Padova, dove fui studente e, col tempo, divenni docente. Anche la mia esperienza di traduttore dal tedesco fu abbastanza precoce: nel 1984 Franco Rella e Giorgio Franck, che insegnavano allo IUAV, mi chiesero di tradurre e curare, per la CLUVA di Venezia, i Problemi formali del Gotico di Wilhelm Worringer, che uscì nel 1985, anno della mia laurea in Filosofia. Regalai una copia di questo testo a Franco Volpi, allora ricercatore a Padova, con il quale ero già in rapporti di amicizia. La traduzione piacque a Franco, che nel 1987 pubblicò Segnavia, la sua prima curatela di Heidegger per Adelphi. Ne seguì l’intensificarsi di una frequentazione “elettiva” che, dopo vari passaggi intermedi, portò alla prima nostra comune produzione adelphiana, Il principio di ragione di Heidegger, del 1991, inaugurando un’assidua collaborazione destinata a durare quasi vent’anni.
Il primo, importante traduttore italiano di Heidegger è stato Pietro Chiodi, seguito, tra gli altri, da Franco Volpi, che ha curato molte opere del filosofo tedesco in Italia, soprattutto per Adelphi. Quali sono state le sue principali correzioni rispetto alle iniziali scelte di Chiodi? Dal suo punto di vista, quale è stato il maggiore contributo ermeneutico apportato da Volpi, in Italia, alla comprensione dell’opera di Heidegger?
Quale fosse l’atteggiamento di Volpi quando nel 2003-2004 si apprestò a rivedere, per Longanesi, la storica versione di Essere e tempo pubblicata da Pietro Chiodi nel 1970 (ma già apparsa per UTET nel 1969, e, prima ancora, nel 1953 per Fratelli Bocca), ce lo dice lui stesso nell’Avvertenza che precede la sua nuova edizione uscita nel 2005: anzitutto quello del “rispetto” e del “ritegno” nei confronti delle principali scelte terminologiche e stilistiche adottate da Chiodi, nei confronti delle quali Volpi, più che un rifacimento, operò una sorta di “restauro conservativo”, puntando più a risanare tacitamente talune mancanze di precisione, rigore e coerenza del tutto, e con l’unico scopo di riattribuire al capolavoro heideggeriano – traduzione inclusa – il suo originario splendore. Un po’ come si fa per gli affreschi dei grandi artisti. Ciò nondimeno, il prezioso Glossario collocato alla fine del volume lascia intendere quali sarebbero potute essere le sue scelte alternative. A puro titolo di esempio posso ricordare il termine chiave Befindlichkeit, tradotto da Chiodi con l’espressione – molto marcata in senso esistenzialista – “situazione emotiva”, alla quale Volpi avrebbe preferito (come di fatto accade in tutte le sue traduzioni) la versione, tecnicamente più corretta e meno compromessa dal punto di vista psicologistico, di “sentirsi [trovarsi] situato” o “situatività”, come quintessenza ontologica, non psicologica, di quella dimensione dell’esistenza umana, che ha sì a che fare con l’“emotività”, ma ne è anzitutto quel presupposto ontologico di passività, opacità, finitezza e gettatezza del Dasein che non si esaurisce affatto nella sfera meramente emotiva-emozionale, ovvero passionale. Ma appunto, Volpi non intervenne, per non stravolgere una delle scelte decisive di Chiodi, ormai entrata nell’uso.
Nella nota introduttiva a ‘La selvaggia chiarezza’, il volumetto adelphiano che raccoglie le prefazioni e le postfazioni ai testi heideggeriani di Adelphi curati dall’amico filosofo, Antonio Gnoli rimarcava che il corpo-a-corpo compiuto da Franco Volpi sui testi di Heidegger, pur colmo di ammirazione, non era esente da critiche, soprattutto per quanto riguarda i ‘Contributi alla filosofia (Dall’evento)’. Qual era l’atteggiamento di fondo di Volpi nei confronti dell’opus heideggeriano? Su quale delle possibili e molteplici direttrici interpretative Volpi soffermò la sua attenzione?
Una cosa va detta: con tutta la sua manifesta “passione” per il filosofo che egli considerava indubbiamente un grande “maestro” del Novecento, Volpi non ebbe mai nei confronti di Heidegger un’ammirazione supina e priva di spirito critico, tipica di una scolastica cultuale e propensa all’apostolato, e avrebbe senz’altro condiviso le parole di Heidegger secondo cui “nessuna vera filosofia, se intesa nella sua verità, si lascia professare. Gli ‘apostoli’ sono sempre quelli che non capiscono niente”. A questo proposito c’è da dire che le critiche di Volpi nei confronti di Heidegger sono, a volte, assai più radicali di quanto ci si potrebbe aspettare. Circa la lettura che egli diede dell’opera di Heidegger nel suo complesso, e in particolare di Essere e tempo, posso solo dire, in questo spazio, che, oltre a una infinità di approfondimenti teoretici e filologici sulle origini e sugli sviluppi del pensiero heideggeriano, i principali risultati innovativi della sua ricerca furono senza dubbio l’analisi dettagliata del rapporto tra Heidegger e Aristotele (vera matrice, a suo avviso, di Essere e tempo), nonché il conseguente inserimento di Heidegger nel contesto – per Volpi filosoficamente e culturalmente decisivo – della cosiddetta “rinascita (o riabilitazione) della filosofia pratica” in Germania, una corrente di pensiero che ha visto protagonisti alcuni tra i principali allievi di Heidegger stesso: Gadamer, Arendt, Ritter, Jonas, Strauss. Ma altrettanto decisivi sono i serrati confronti critici che Volpi propose tra Heidegger e i principali protagonisti del pensiero moderno e contemporaneo, da Kant a Hegel e Nietzsche, fino a Brentano, Adorno, Husserl, Wittgenstein, e così via. A questo proposito è in corso di stampa, per l’editore Morcelliana, una raccolta – curata dal sottoscritto e da Nicola Curcio – dei principali saggi di Volpi su Heidegger, alla cui pubblicazione mi permetto di rinviare.
Lei ha contribuito alla pubblicazione di diverse edizioni adelphiane di opere di Heidegger curate da Volpi, traducendo ‘Il principio di ragione’, il ‘Parmenide’, ‘I concetti fondamentali della filosofia antica’, le ‘Conferenze di Brema e Friburgo’, la ‘Fenomenologia della vita religiosa’, oltre a vari scritti di Schopenhauer e di Schmitt; dopo la prematura morte di Volpi nel 2009, Lei ha continuato il percorso curando e traducendo sempre per Adelphi altri volumi della ‘Gesamtausgabe’ heideggeriana come ‘Identità e differenza’, i ‘Concetti fondamentali della filosofia aristotelica’, e da ultimo, appunto,‘L’inizio della filosofia occidentale’. Quanto alle scelte specifiche di traduzione e di interpretazione, Lei ha fatto qualche modifica significativa al glossario approntato da Volpi?
Con grande onestà intellettuale e rigore metodologico, Volpi ha sempre corredato le sue personali traduzioni di Heidegger – penso alle principali, Segnavia e Nietzsche per Adelphi, ma anche Essere e tempo per Longanesi – con glossari nei quali chiariva nel dettaglio il motivo delle sue principali scelte terminologiche. Oserei dire che, proprio per questo, tali glossari potrebbero costituire un testo scientifico a sé stante, come se fossero saggi ermeneutici. Al tempo stesso, egli non ha mai mancato di esplicitare, ove necessario, le sue scelte di traduzione anche all’interno dei testi tradotti, poste tra parentesi tonda. Ne è derivato ovviamente un patrimonio lessicale indispensabile per chiunque si voglia cimentare nell’arduo e ingrato compito di tradurre Heidegger. Io stesso, nelle mie traduzioni, eseguite dapprima sotto la sua attenta supervisione, e poi in piena autonomia, non ho mai potuto prescindere dalla sua autorevole “scuola”, sempre improntata nell’individuare le soluzioni più rigorose dal punto di vista filologico, ma anche più chiare e comprensibili da quello semantico. Volpi era letteralmente ossessionato dalla necessità di trovare – aristotelicamente – il “giusto mezzo” tra queste due istanze, e aborriva le formulazioni che, pretendendosi “letterali”, risultavano poi illeggibili e imperscrutabili. È vero però che nessun glossario di base, ancorché d’eccezione, può esaurire le complesse varianti terminologiche che Heidegger adotta per ogni suo singolo scritto o corso, sicché io stesso – sia in presenza sia in assenza di Volpi – ho dovuto sempre aggiornare, modificare e integrare le sue scelte di fondo, a seconda del singolo contesto. Ma questo, come si sa, fa parte del “mestiere” dell’allievo, con la sola non trascurabile differenza che, con Volpi vivo, discutevamo di continuo delle “nostre” scelte di traduzione, mentre dopo la sua morte il mio dialogo con lui è diventato purtroppo solo virtuale.
Venendo a ‘L’inizio della filosofia occidentale’, appena pubblicato da Adelphi: da quali considerazioni ermeneutiche ed editoriali è nata la scelta di tradurre questo specifico corso dei primi anni Trenta? Nella sua prefazione al volume, Lei afferma che esso “rappresenta una vera e propria cesura nel percorso di Heidegger dopo ‘Essere e Tempo’”. Dopo la rivoluzione concettuale apportata dalla celebre Kehre, quali elementi di discontinuità rispetto all’Heidegger di ‘Essere e Tempo’spiccano ne ‘L’inizio della filosofia occidentale’?
Per quanto riguarda la celebre Kehre, ovvero la “svolta” di Heidegger, oltre Essere e tempo, in direzione di una interrogazione dell’essere che non passi più attraverso un’analisi esistenziale del Dasein, cioè dell’uomo, ma si rivolga direttamente all’essere stesso, ovvero alle “tracce” che l’esperienza iniziale-originaria dell’essere, al tempo della Grecia preplatonica, lascia nelle parole e nelle scritture dei “presocratici”, solitamente si è fatto riferimento al decisivo corso del 1935, Introduzione alla metafisica, centrato sui nomi di Eraclito e Parmenide. Viceversa, la strada che porta a Essere e tempo, negli anni precedenti al 1927, si presenta – come scrive proprio Volpi – lastricata dal confronto continuo con Aristotele, e in second’ordine con Platone, mentre le impronte lasciate dai pensatori iniziali nel “primo” Heidegger non sono poi così marcate. In Essere e tempo il nome di Eraclito compare una sola volta, Parmenide occasionalmente e Anassimandro per nulla. Sembra quindi che tra Essere e tempo (1927) e Introduzione alla metafisica (1935) si spalanchi un abisso incolmabile. Invece, il corso del 1932 sta a dimostrare fino a che punto Heidegger già nei primi anni Trenta avesse le idee molto chiare su quale fosse il percorso – né aristotelico né platonico – da intraprendere per dare risposta alla questione dell’“inizio più iniziale”, ovvero riguardo a quella sorgente primordiale da cui è forse ancora possibile (ri)attingere – sempre ammesso che la si ritenga degna di domanda – a un’esperienza originaria, pre-metafisica, dell’essere in quanto tale, un balzo nel Primo Inizio già stato in vista di un Nuovo Inizio venturo. Le riflessioni su Anassimandro e Parmenide, ma soprattutto la “considerazione intermedia” sviluppata nel corso del 1932, volta a chiarire i profondi motivi ermeneutici dell’interrogazione del primo inizio, contengono in nuce molte delle problematiche poi magistralmente sviluppate in Introduzione alla metafisica. Una lacuna che, a mio parere, Adelphi ha fatto bene a colmare.
Questo corso dell’estate del 1932 è dedicato specificatamente ad Anassimandro e a Parmenide. A Parmenide dieci anni dopo Heidegger avrebbe dedicato un nuovo corso universitario, che Lei ha tradotto per Adelphi nel 1999. Tra l’estate del 1932 e l’inverno del 1942 qual è la cesura che si può rinvenire nell’interpretazione heideggeriana di Parmenide?
Bisogna tenere conto, anzitutto, che la questione dell’inizio pre-metafisico nell’ambito della “storia dell’essere” esplode, letteralmente, nel percorso di Heidegger, negli anni Quaranta: nell’estate-autunno del 1942 egli prepara nel dettaglio un intero corso (poi però non realizzato) completamente dedicato al Detto di Anassimandro; nel 1942/43 tiene il grande corso su Parmenide, e nel 1943-1944 i due celebri corsi su Eraclito. Quanto al Parmenide, le differenze con il corso del 1932 sono evidenti: mentre qui si tratta di una esplorazione preliminare che prende in considerazione tutti i frammenti del lascito parmenideo, con un meticoloso commento, parola per parola, a fini didattici, di ogni sua variante, per accedere alla concezione parmenidea dell’essere e del rapporto tra essere, pensiero (noein) e linguaggio (legein), il corso del 1942/43 trae spunto da pochi versi decisivi (22-32) del poema didascalico di Parmenide per sviluppare una intensissima riflessione sulla questione della “verità” originaria come “aletheia”, dis-velatezza (dell’essere) concepita nella sua differenza dalla forma della “adeguazione” (omoiosis) e “correttezza” (orthotes) dell’asserzione che essa acquisterà, successivamente, nell’opera di Platone, e, quindi, con la metafisica. Questa specifica disamina è, in effetti, assente dal corso del 1932, e costituisce senza dubbio un elemento di decisiva maturazione teoretica del pensiero heideggeriano, che è sempre in fieri, animato da una intensa volontà di inesauribile interrogazione dei problemi. Va da sé che l’enigma dell’aletheia (nel suo nesso con la physis) costituisce il cuore greco dell’intera filosofia di Heidegger – soprattutto quando viene giocato in contrasto con la certezza calcolistica della tecnoscienza moderna – ma nel corso del 1932 questa problematica era ancora in potenza, e non in atto.
Come spesso capita in Heidegger, anche ne ‘L’inizio della filosofia occidentale’si trovano diverse riflessioni sulla corretta traduzione dei presocratici, fino a vere e proprie rielaborazioni filologiche di alcuni frammenti. A che cosa si doveva la polemica di Heidegger nei confronti dei filologi del suo tempo, e quanto questa polemica era un’eco del celebre scontro tra Nietzsche e Wilamowitz? Nel riportare in italiano le citazioni dei presocratici proposte da Heidegger Lei ha fatto parziale riferimento a qualche traduzione italiana pregressa, come quella di Giorgio Colli, oppure ha tradotto ex novo basandosi più sul tedesco di Heidegger che sul testo greco originale?
Ogni qualvolta Heidegger propone le sue traduzioni degli antichi testi greci – in particolare quando si tratta dei filosofi presocratici, oppure di poeti come Omero, Sofocle, ecc. – emerge il problema della “fedeltà” o meno di tali traduzioni. Proprio nel corso del 1932, apprestandosi a proporre la sua traduzione dei frammenti parmenidei, egli argomenta ironicamente: “È divenuto oggi di moda confutare le mie interpretazioni dei filosofi precedenti affermando ‘questo è Heidegger, non Hegel – Heidegger, non Kant’, e così via”, il che vale tanto più per Anassimandro, Parmenide, Eraclito, ecc. Già in Essere e tempo Heidegger teorizza il celebre “circolo ermeneutico” come fattore positivo, non necessariamente vizioso, cioè ineliminabile ma produttivo, della comprensione interpretante – quindi anche della traduzione – di un testo (e non solo), nel presupposto secondo cui “l’importante non sta nell’uscire fuori dal circolo, ma nello starvi dentro nella maniera giusta”, ovvero nella piena ed esplicita consapevolezza della propria prospettiva di interprete. Il vero errore, semmai, è quello di ritenere – dice Heidegger nel corso del 1932 – “che esisterebbe in assoluto un’interpretazione in sé vera e vincolante per chiunque in ogni momento”, un errore tipico della cosiddetta filologia “scientifica” (oltre che della scienza tout court), la cui illusorietà, prima ancora che fallacia, è stata stigmatizzata da ogni genere di ermeneutica, non da ultimo quella gadameriana. Direi anzi che, abbandonando la comoda pigrizia con cui si sciorinano giudizi di arbitrio e inattendibilità filologica da parte di Heidegger, chiunque leggesse con la dovuta attenzione, sine ira et studio, i suoi corsi su Anassimandro, Eraclito, Parmenide, ecc., scoprirebbe piuttosto con quanta prudenza, accortezza e meticolosità egli proponga le sue traduzioni interpretative, nella assoluta consapevolezza del loro carattere sperimentale, ed esplicitando sempre senza remore il suo problema di fondo, cioè la storia dell’essere e delle sue espressioni nel linguaggio. A maggior ragione il traduttore di Heidegger traduttore non può che attenersi nel modo più attento e rigoroso “alla necessità e all’originarietà della problematica che fa da guida all’interpretazione” di Heidegger stesso, senza lasciarsi fuorviare o lusingare da altri modelli, basati su altri presupposti, ancorché autorevoli. Chiunque si appelli, qui, all’“esattezza” della traduzione semplicemente non sa che cosa significa tradurre – qui il Benjamin del Compito del traduttore fa ancora testo. Una cosa è certa: con le sue traduzioni e interpretazioni, Heidegger ci rende “viva, attuale e intrigante” la Grecia arcaica esattamente come Nietzsche, con la sua Nascita della tragedia, ci rende ognora viva, attuale e intrigante l’antica esperienza del tragico, in un modo inarrivabile per qualsiasi filologo “classico”.
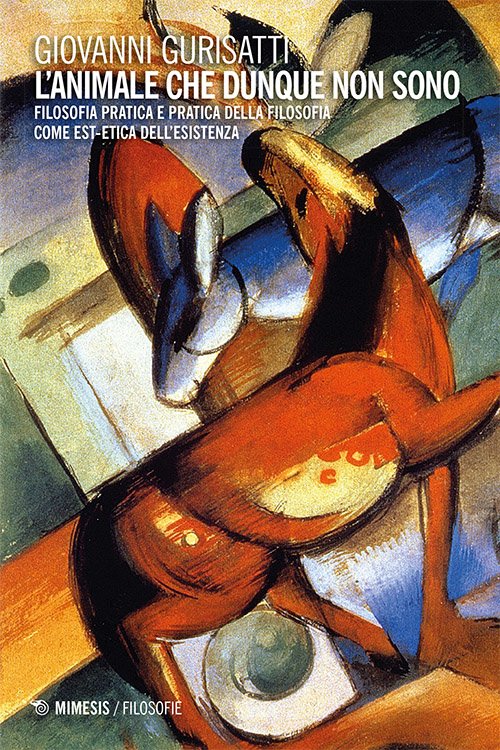
Tra i testi che fanno parte dell’edizione integrale, tedesca, degli scritti di Heidegger pubblicata a Francoforte da Klostermann, quali altri libri di Heidegger inediti in italiano secondo Lei meriterebbero al più presto un’edizione e una traduzione nel nostro Paese?
Come Lei sa la Gesamtausgabe di Hedegger comprende 102 volumi, in gran parte già tradotti anche in italiano, in parte pubblicati in tedesco ma non tradotti, in parte ancora in preparazione. Ed è logico che, con il passare degli anni, si stia arrivando, per così dire, al fondo del barile, raschiare il quale non è detto che convenga: i testi fondamentali sono già stati prodotti e tradotti, mentre ciò che resta sono per lo più materiali frammentari di vario genere (spesso di dimensioni impressionanti), ma non vere e proprie “strutture” (compresi i corsi universitari) significative, ancorché incompiute. Le alternative quindi sono chiare: o tradurre comunque “tutto” ciò che reca il marchio “Heidegger”, cosa di per sé improponibile, di fatto inutile – perché di interesse per i soli addetti ai lavori, che avrebbero comunque accesso agli originali tedeschi –, ed economicamente fallimentare; oppure ri-tradurre, almeno in parte, e con circospezione, ciò che è già stato tradotto, migliorando, rivedendo e “rilanciando” cose già viste e note; oppure infine limitarsi a ciò la cui mancanza costituisce effettivamente una lacuna degna di integrazione per la conoscenza diffusa, e non solo specialistica, del pensiero heideggeriano. Il mio pensiero va, ad esempio, ai due volumi 80.1 (2016) e 80.2 (2020) della Gesamtausgabe contenenti conferenze inedite di Heidegger sui più svariati argomenti e autori filosofici – si tratta tuttavia di complessive 1400 pagine, sicché sarebbe opportuno operare una scelta oculata di testi, cosa però non prevista da Klostermann e dai gestori del lascito. Il maggiore interesse va probabilmente al vol. 82 (2018) della HGA, che contiene le personali riflessioni di Heidegger (a partire dal 1936) sulle proprie stesse pubblicazioni, soprattutto su Essere e tempo, alla luce dei successivi sviluppi della sua filosofia (e delle critiche a essa rivolte) – in particolare dei Contributi alla filosofia (1936-1938) –, ma anche su Che cos’è metafisica?, L’origine dell’opera d’arte e la Lettera sull’“umanismo”. Si tratta anche in questo caso di circa 600 pagine, e comunque l’edizione riproporrebbe la questione: a quale edizione di Essere e tempo fare riferimento? A quella di Chiodi, di Chiodi/Volpi, di Marini? Mi piace pensare che la traduzione di questo volume della HGA avrebbe potuto offrire a Franco Volpi (traduttore dei Contributi alla filosofia) l’occasione per mettere finalmente allo scoperto la “sua” personale versione della terminologia di Sein und Zeit … ma si tratta, purtroppo, di un triste sogno …
Per concludere, ma rimanendo al Suo rapporto con Volpi. Nel 2019, per ricordarlo a dieci anni dalla morte, Lei ha curato per Morcelliana, con Antonio Gnoli, un volume collettaneo di interventi di colleghi e amici dello scomparso,intitolato ‘Franco Volpi. Il pudore del pensiero’. Poi nel 2020, sempre per Morcelliana, è uscito un Suo libro, ‘Est/etica ontologica. L’uomo, l’arte, l’essere in Martin Heidegger’, che – come dice Lei stesso nella Sua introduzione – “si apre e si chiude nel segno e nel nome di Franco Volpi”. Ci può parlare brevemente di questo Suo testo?
Per Volpi uno degli elementi di maggiore criticità del pensiero di Heidegger fu il suo rapporto con l’etica, al punto che egli parlò, nei riguardi del filosofo, di un’esplicita “rimozione dell’etica”. Nel mio libro cerco appunto di riprendere l’idea (purtroppo non sviluppata) di Volpi di una “lettura foucaultiana” di Essere e tempo e di altri luoghi dell’opera di Heidegger, centrata sul rapporto tra singolo e comunità, cura di sé e cura degli altri, governo di sé e governo degli altri. Direi che proprio in quanto “rimossa” la dimensione etica gioca in Heidegger un ruolo determinante – tanto più se direttamente collegata con la dimensione estetica, cioè con la sua filosofia dell’arte e della poesia. È per questo che, in via sperimentale, ho adottato l’espressione “est/etica”, con la quale ho voluto sottolineare che nel mio libro affronto Heidegger da due prospettive diverse ma a mio avviso complementari: quella “etica”, riguardante la questione dell’uomo e del suo modo di essere e di comportarsi, tramite una comparazione con gli animali e le filosofie dell’animalità, cui è dedicata la prima parte, e quella “estetica”, riguardante la questione dell’arte, della poesia, del linguaggio e della tecnica tramite un confronto tra Heidegger e Schopenhauer, Rilke, l’Oriente, Benjamin, cui è dedicata la seconda parte. Non v’è nulla di “etico” nella prima parte che non trovi riscontro nell’“estetica” della seconda, e viceversa. Ma, soprattutto, la grafia “est/etica” (che non ha alcun fondamento etimologico), vuole significare l’indissolubile polarità dinamica tra l’apertura etica nei confronti dell’Essere, del Mondo e dell’Uomo, da un lato, e quella particolare forma accogliente, ontocentrica ed eterocentrica dell’agire umano che è il fare poetico-artistico, dall’altro. Per dirla con Heidegger: solo in quanto esercita un ethos dell’“abitare” il mondo, l’uomo può dargli forma in termini “poetici”, e solo in quanto esercita una aisthesis poetica nei confronti del mondo, può prendersene cura in termini “etici”. In questo senso la filosofia di Heidegger è una forma di meditazione che ci insegna ad abitare esteticamente il mondo e a prenderci eticamente cura di esso, degli altri e di noi stessi.
Nell’ultimo periodo della sua vita, su quali direttrici si stava dirigendo la ricerca di Volpi sia per quanto riguarda lo studio di Heidegger, sia per quanto riguarda la sua concezione filosofica generale?
Negli ultimi anni, Volpi cercava di uscire non solo dalla cerchia di Heidegger, ma anche dalla propria stessa precedente interpretazione della sua opera, un po’ troppo schiacciata su una lettura “aristotelica” di essa. Ecco allora le sue perspicaci aperture nei confronti dell’ultimo Foucault, che, com’è noto, ha ben poco di “aristotelico”. Per quel che mi riguarda, Heidegger non è, come talora ha scritto Volpi, “il” filosofo del Novecento, ma è certo un pensatore con cui non si può non fare i conti, e nei confronti del quale sia ostracismi sia ammiccamenti ironici servono poco. Heidegger va studiato e correttamente interpretato per quel che è, tanto più oggi, in un momento in cui – secondo lo spirito tecnologico del tempo – soffia sempre più forte il vento che spinge la filosofia a una dubbia mésalliance con i saperi e i linguaggi sedicenti “forti” (la scienza, la matematica, la logica, l’epistemologia, la gnoseologia, l’indagine empirica, la sociologia, l’informatica, la statistica, ecc.), scordando quella sua originaria e incancellabile ispirazione “umanistica” etica ed estetica, cogitativa e meditativa, che consiste nel sottoporre a critica radicale la riduzione del sapere a razionalità strumentale-antropocentrica e alla prassi tecnoscientifica di dominio calcolistico dell’uomo sul mondo. Così però si priva la filosofia della sua costitutiva funzione decostruttiva di aprire sempre e comunque nuovi “orizzonti di senso” in grado di trascendere l’ordine abituale dei (cosiddetti) dati di fatto. Una prospettiva, questa, di cui Heidegger, nel Novecento, si è fatto strenuo difensore, con i rischi e gli errori che tutte le posizioni “estreme e radicali” come la sua inevitabilmente comportano.