Scrivere di cinema è sempre un esercizio traduttivo da un codice semiotico, visivo, a un altro, verbale, che implica il rispetto di silenzi, sospensioni, ambivalenze e margini d’interpretazione. Di tale equilibrio tra detto e non detto va tanto più tenuto conto quando ci si accosta alla parabola del personaggio principale di un’opera come Tomboy, che incarna uno “stare sulla soglia”, sia dal punto di vista dell’età – essendo ancora nell’infanzia in cui tutto è possibile – sia dal punto di vista del genere femminile/maschile.
Architetture del desiderio. Il cinema di Cèline Sciamma, (Asterisco 2021)
Su Scenari proponiamo un estratto dal capitolo “Tomboy, o l’instabilità di genere” di Silvia Nugara del libro “Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma” a cura Federica Fabbiani e Chiara Zanini (Asterisco, 2021). Un’analisi accurata del film “Tomboy” (2011) scritto e diretto da Cèline Sciamma che affronta l’instabilità di genere, la sessualità e l’infanzia, in un dialogo con le teorie di Judith/Jack Halberstam sulla soggettività trans*.
Tomboy, garçon manqué, maschiaccio
La scelta di un titolo in inglese non è casuale: tomboy avrebbe un quasi-equivalente francese in garçon manqué (maschio/ragazzo ma ncato) ma, come l’italiano maschiaccio, l’espressione reca echi negativi che il film evita. Il participio manqué evoca il fallimento della giovane nel realizzare un modello di riferimento maschile, come dimostra l’uso che ne fece Simone de Beauvoir ne Le Deuxième Sexe:
«Verso i 10, 12 anni la maggior parte delle ragazze sono veramente dei ‘maschi mancati’, vale a dire dei bambini cui manca la possibilità di diventare dei ragazzi. E non solo ne soffrono come di una privazione e di un’ingiustizia; ma il regime cui vengono condannate è malsano. In loro l’esuberanza della vita è bloccata»[1]
Beauvoir prende di mira l’impaccio degli abiti femminili, i limiti alla libertà di movimento, l’imperativo di seduzione e di risposta al desiderio maschile, il confinamento al corpo e all’immanenza con cui viene costruita socialmente la donna come Altro del Soggetto. Le sue analisi riconoscono dunque al garçon manqué una tensione verso la liberazione, una capacità di trasgressione della frontiera uomo/donna, di violazione delle norme imposte alle donne per limitarne l’indipendenza e la presa sul mondo. Tuttavia, l’approccio di Beauvoir risente di un’idea negativa del femminile e dell’omosessualità: «Il ‘ragazzo mancato’, scoprendo di essere donna, prova a volte una brutale delusione che può portarla addirittura [sic] all’omosessualità [2]». Nel 1971, invece, agli albori del movimento femminista francese a cui Beauvoir stessa partecipò, sul secondo numero della prima rivista di movimento “Le Torchon brûle”si leggeva un articolo nel cui titolo tanto il garçon manqué quanto la sale “gouine” sono soggetti che si riappropriano degli appellativi rivolti loro quali insulti per farne strumenti di lotta contro l’oppressione patriarcale.
Nello scegliere la parola tomboy, Sciamma conserva senz’altro l’idea di disallineamento sesso/genere/sessualità presente nell’archivio discorsivo francofono che abbiamo evocato ma apre all’immaginario più contemporaneo e globale di quella che Halberstam chiama female masculinity per sottolineare che la maschilità è una costruzione sociale e culturale portata avanti non solo da corpi biologicamente assegnati come maschi ma anche come femmine. Si può trattare di donne fisicamente forti, muscolose o mascoline (come la tennista Martina Navratilova), di donne che si fanno identificare al maschile (come Radclyffe Hall, autore de Il pozzo della solitudine), di lesbiche butch (come la cantante k.d. lang), di trans FtM (come il già citato Leslie Feinberg), di drag king (come l’Elvis impersonator Elvis Herselvis) oppure di tomboy. Così Halberstam definisce la nozione di tomboy:
«‘Maschiaccio’ è in generale il termine che contraddistingue la maschilità femminile nell’infanzia. […] Il comportamento da maschiaccio è generalmente associato al “naturale” desiderio da parte della bambina di quella maggiore libertà di movimento che è di solito consentita ai maschietti. Molto spesso questo comportamento è letto come un segno di indipendenza e di autonomia e può persino essere incoraggiato, a patto che esso rimanga saldamente ancorato a un senso stabile dell’identità femminile della bambina. Un tale comportamento è tuttavia punito quando si presenta come il segno di un’identificazione maschile portata all’estremo (come può essere la scelta di un nome da maschio o il rifiuto assoluto di indossare abiti femminili) e più ancora quando minaccia di estendersi oltre l’infanzia e nell’adolescenza.»[3]
In queste parole si ritrova praticamente una sinossi del film di Sciamma ma il cinema dispiega le sue possibilità nella durata e nel dosaggio delle informazioni. Il titolo Tomboy ci orienta a pensare che il personaggio presente sin dalla prima inquadratura sia una bambina ma non ne abbiamo subito la certezza. Anzi, nelle scene iniziali, il film si serve di una simbolica del maschile per indurci a inferire che è un bambino: taglio di capelli corto, abbigliamento sportivo che consente un’andatura rilassata, complicità con il padre insieme a cui guida l’automobile e trasporta alcune scatole di un trasloco in atto, cameretta con le pareti blu a contrasto di una sorellina molto femminile che ha una stanza rosa. Il corpo asciutto e prepubere dell’interprete contribuisce a questa illusione giocata sul filo dello sguardo. Sciamma fa leva sul modo in cui il binarismo di genere permea le nostre percezioni per condurci progressivamente di fronte ai limiti della riconoscibilità in termini puramente binari.
Essere e interpellazione
Dopo averci orientato a credere che il film abbia per protagonista un bambino, Sciamma compie un passo ulteriore nel rafforzare tale convinzione con una scena di “interpellazione”[4]. È estate e il personaggio ancora senza nome deve abituarsi a un nuovo contesto di vita. Dalla finestra di casa, vede giocare dei coetanei in giardino. Decide di scendere ma, mentre si avvia verso il gruppo, incontra una ragazzina che gli si rivolge al maschile: «Sei nuovo?». Lui/lei rimane un momento in silenzio, poi risponde di sì. Nello spazio di quel breve silenzio ha deciso di lasciar credere alla nuova amica ciò che quest’ultima ha mostrato di intendere. Lisa si presenta e poi sollecita: «Sei timido? Non vuoi dirmi come ti chiami?». Altro silenzio per poi dichiarare: «Mickaël, mi chiamo Mickaël».
Dopo le presentazioni, Lisa e Mickaël si addentrano nel bosco e giungono a una radura dove si uniscono al gruppo di amici di Lisa per giocare a ruba-bandiera. Lisa usa la sua autorevolezza presso il gruppo affinché “il nuovo” venga accolto, poi gli concede di vincere non senza avergli detto che lo sta facendo di proposito per renderlo gradito agli altri. L’innamoramento di Lisa è già scattato e la seduzione è in moto.
La sera, ritroviamo Mickaël nella vasca da bagno di casa che si lava insieme alla sorellina Jeanne. Se fuori di casa Mickaël è impegnato in attività fisiche e sportive, nello spazio domestico le attività ludiche con Jeanne ruotano per lo più intorno ai ruoli e all’identità: si acconciano i capelli alla mohicana, si fanno dei ritratti e leggono Il libro della giungla che narra la storia di un bambino diviso tra due comunità di riferimento, gli umani e gli animali. Nella vasca, la piccola canta una canzone con una rappresentazione di genere fortemente polarizzata (Les filles se sont maquillées et les garçons se sont ennuyés[5]) poi Mickaël la intervista e lei recita la parte di una trentacinquenne con ambizioni da pop star, infine giocano a Indovina chi?. A un certo punto, la voce fuori campo della madre sollecita la fine del bagno. La donna entra in scena, aiuta la piccola a uscire dalla vasca, la avvolge affettuosamente in un asciugamano e se la porta via.
Mickaël resta a bagno, solo e serio, mentre fuori campo la madre richiama all’ordine con un’altra interpellazione: «Laure! Esci dalla vasca!». È la prima volta che sentiamo il nome di Laure. Stacco di montaggio e il personaggio ci appare a figura intera, nudo, con il sesso femminile esposto. Laure ha fatto credere a Lisa e agli altri di chiamarsi Mickaël e il film sancisce così lo scollamento tra sesso e genere in Laure/Mickaël. Si noti infatti che il nome Mickaël è quello dell’angelo combattente, un nome di derivazione ebraica il cui significato nella Bibbia può essere interpretato come l’interrogazione «chi è come Dio?», e cioè chi può permettersi di creare il mondo e gli esseri umani? Chi può trasformare il Verbo in carne? Chi decide ciò che siamo e quali sono i nostri margini di vita e azione? È come se, nel nome, Mickaël recasse una domanda sull’esistenza a cui tutto il film cerca di fornire delle risposte che però resteranno provvisorie, data l’età dei corpi in gioco ma anche data la singolarità di ogni corpo, desiderio e traiettoria esistenziale.
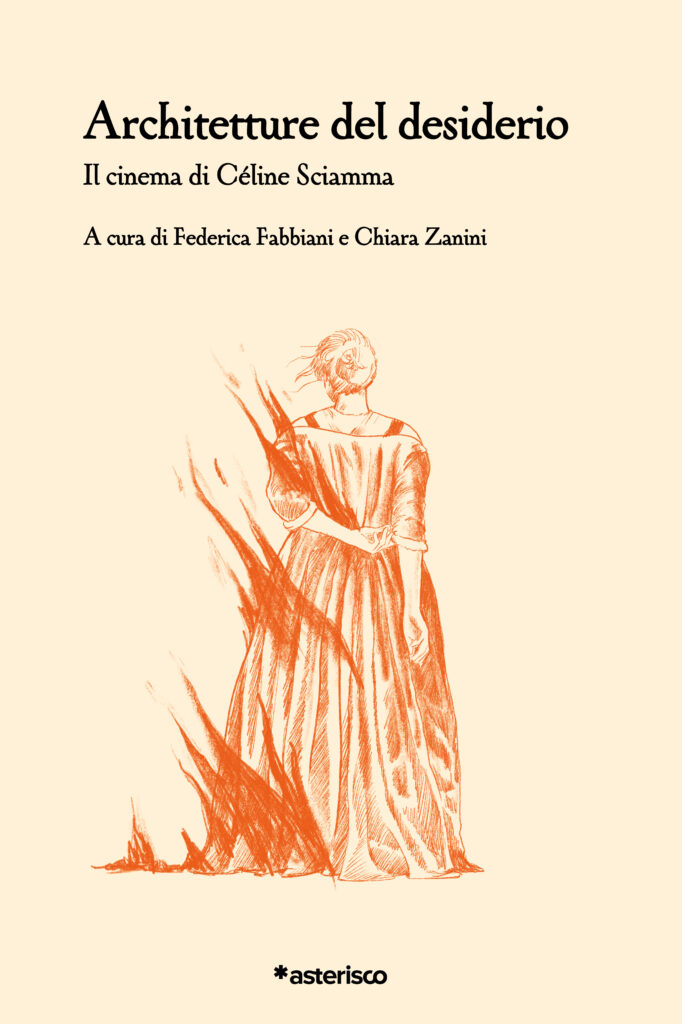
Prima di continuare, è necessaria una precisazione linguistica. La lingua,[6] per come la si utilizza prevalentemente, vincola le persone a una classificazione di genere esclusiva: gli esseri umani si dicono o al maschile o al femminile. Come rapportarsi, invece, con qualcuno che desidera sottrarsi a tale sistema o la cui configurazione di genere è mutevole nel corso del film, a seconda delle circostanze e dei personaggi con cui interagisce? Esistono ormai forme linguistiche ambigenere, inclusive o non binarie (per esempio la desinenza ǝ – schwa – o l’asterisco) che rimettono in discussione la classificazione nominale sulla base di un criterio sessuale che ha l’eterosessualità come norma di riferimento. Di conseguenza, in queste pagine identifico Laure al femminile e Mickaël al maschile quando tale è l’identità messa in gioco o riconosciuta nella scena che sto descrivendo. Altrimenti, mi sottraggo alla determinazione di genere o unigenere di Laure/Mickaël attraverso forme linguistiche inclusive o non binarie come la ǝ (schwa).
Nella prima interpellazione, Sciamma mette in scena il rituale di presentazione che tipicamente inaugura le amicizie infantili chiamando in causa la vulnerabilità linguistica del soggetto. La teoria della “vulnerabilità linguistica” di Judith Butler mette l’accento sul legame costitutivo tra l’essere e l’Altro non solo nella misura in cui ciò che siamo può esserci negato o riconosciuto ma poiché solo ciò che è riconoscibile esiste, ed è riconoscibile solo ciò che è stato in qualche modo codificato da pratiche sociali di inclusione ed esclusione:
«si ‘esiste’ non solo grazie al riconoscimento che si ottiene, ma, in un senso che viene ancora prima di tutto ciò, nell’essere riconoscibili. I termini che facilitano il riconoscimento sono essi stessi convenzionali, sono gli effetti e gli strumenti di un rituale sociale che decidono, spesso attraverso l’esclusione e la violenza, le condizioni linguistiche dei soggetti che possono sopravvivere»[7]
In Tomboy, l’interpellazione di Lisa «non ‘scopre’ questo corpo ma lo costituisce fondandolo»[8]. Lisa si muove entro un assetto di pensiero in cui solo i termini maschio e femmina sono riconoscibili. Dunque, non riconoscendo l’altro come femmina, lo identifica automaticamente come maschio e ciò potrebbe essere interpretato come una possibilità per Laure di attraversare il suo fantasma maschile[9]. Si tratta però anche di notare che il genere, qualsiasi genere, in quanto fascio di relazioni di potere, assetto di esempi, norme e aspettative estetiche e comportamentali, è uno script che crea i nostri corpi. Mentendo sul proprio nome e ribattezzandosi Mickaël, il personaggio si sottrae ai condizionamenti della femminilità ma innesca un processo che lo porta a incorporare una nuova identità attraverso strategie di apprendimento e performance della maschilità.
Un’analoga scena di interpellazione si trova anche in Stone Butch Blues, grande romanzo biografico in cui Leslie Feinberg, figura fondamentale nella storia transgender, narra la vita, gli amori e le battaglie di Jess Goldberg, soggetto che trasgredisce le frontiere di genere in quanto butch. Ciò avviene quando Jess, butch in erba, ha dieci-undici anni. Sin da piccola, Jess si sente continuamente rivolgere la domanda minacciosa: sei maschio o sei femmina? Sempre alla ricerca di libertà, Jess attraversa l’autostrada che costeggia il quartiere delle case popolari in cui vive per ritrovarsi tra prati, alberi e animali: «Mi aprivo un varco tra l’erba alta e bruna ai lati della strada e, una volta dall’altra parte, ero nel mio mondo»[10]. Quando è “dall’altra parte”, Jess rivolge scherzosamente a cani e corvi la domanda che la perseguita ma in risposta ottiene dei versi, ride e si rotola sull’erba. Nel linguaggio degli animali non c’è verbo e dove non c’è verbo non c’è divisione tra maschi e femmine. Un giorno, Jess incontra l’uomo della Protezione Animali che le dice: «‘Non mettere le dita dentro la rete, figliolo. Mordono.’ Sentii le punte delle orecchie diventarmi rosse»[11]. È la prima volta che qualcuno le si rivolge dando per scontato che si tratti di un ragazzo. Il passaggio dal mondo urbano al “suo mondo” dall’altra parte dell’autostrada permette a Jess di accedere a un luogo in cui un’altra esistenza di genere è possibile. Il rossore che le infiamma le orecchie è l’emozione di scoprire un mondo in cui la sua maschilità è riconosciuta ma forse anche l’apprensione di chi comprende che alla divisione maschio o femmina non si riesce a sfuggire quando si vive in società.
A fronte di questa libertà sempre condizionata dalle logiche identitarie, tanto nel romanzo di Feinberg quanto in Tomboy, il personaggio principale trova accoglienza nel bosco e pace tra gli elementi naturali: «Il cielo era celeste pastello. Finsi di essere sdraiata su nuvole bianche come fiocchi di cotone. La terra era umida sotto la mia schiena. Il sole era caldo, la brezza fresca. Ero felice. La natura mi teneva tra le sue braccia senza giudicarmi»[12]. Questo passo di Stone Butch Blues rinvia a sensazioni tattili (l’umidità, il calore, la freschezza) a cui ha accesso qualsiasi corpo umano, al di là del sesso o del genere, e a elementi visivi di cui si serve la stessa Sciamma sin dall’incipit del film come correlativi dell’anelito di libertà del personaggio: il celeste pastello del cielo, le nuvole bianche, il sole che filtra tra le fronde degli alberi, la brezza. L’enfasi di Sciamma sull’aspetto sensoriale e spaziale fornisce una rappresentazione del mondo e della fine dell’infanzia attraverso gli occhi del suo personaggio che diventa quindi soggetto partecipe di una narrazione capace di non sottovalutare né feticizzare i travagli dell’età.
La rivelazione
È Jeanne che, suo malgrado, contribuisce a far saltare la copertura di Laure/Mickaël sospingendo la narrazione verso lo Spannung. Un pomeriggio, la bambina piange perché è stata maltrattata da un compagno di giochi. Avverando il racconto inventato da Jeanne al suo arrivo nel gruppo, Mickaël picchia il compagno per vendicare la sorella. Lisa lo guarda con ammirazione. Anche Jeanne è lusingata da tanto slancio cortese quando a casa si medicano le ferite e Laure/Mickaël le disegna sul braccio un cuore di betadine. Poi, dalla stanza avvertono delle voci in corridoio, si affacciano sulla soglia e vedono la madre in piedi sull’uscio di casa. Fuori c’è il bambino picchiato con sua madre che reclama delle scuse: «È suo figlio che ha fatto questo». La madre di Laure pensa ci sia un errore, lei non ha un figlio. Poi la vittima riconosce Mickaël che nel frattempo ha raggiunto l’uscio. Laure/Mickaël conferma l’accaduto, la madre si fa rossa di onta e confusione, si scusa e promette: «Farò quel che devo, lo punirò[13]». Anche in Stone Butch Blues una bagarre tra Jess e un coetaneo fornisce alla madre un’occasione per impartire alla figlia una “lezione di genere” che nel seguito le verrà riproposta in forme sempre più violente:
«Mia madre mi chiamò a casa per cena. «Chi era quel bambino con cui stavi giocando?» Io non risposi. / «Gli mostravi i muscoli?» / Oddio, aveva visto tutto? / Lei sorrise. «Qualche volta, è meglio lasciar credere ai maschi che sono i più forti» mi disse. Pensai che era completamente pazza se ne era davvero convinta. Il telefono squillò. «Rispondo io» gridò mio padre. Erano i genitori del ragazzo a cui avevo fatto sanguinare il naso, lo capii da come mio padre mi fulminò con lo sguardo»[14]
In Tomboy solo la madre reagisce con violenza alla trasgressione: «Che hai fatto, Laure?». La donna è sconvolta e incalza: «Perché l’hai fatto?». Ma Laure/Mickaël non sa cosa rispondere e ha paura. La madre la scuote, sempre più adirata: «Hai fatto credere di essere un maschio? Hai mentito e hai trascinato dentro pure tua sorella?». Il primo piano della donna è sempre più ravvicinato e sconvolto: «Perché l’hai fatto?». Laure/Mickaël non risponde e così la madre le/gli molla una sberla. Gli occhi della donna si riempiono di lacrime, è arrabbiata e confusa. Laure/Mickaël, mortificatǝ, riceve l’ordine di andarsene in camera.
Nella penombra, piange da solǝ poi la macchina da presa arretra e vediamo che accanto c’è il padre, tenero ed estraneo alla funzione normalizzante della Legge, che l’invita alla comprensione: «Non avercela con mamma». Con una carezza, le/gli dice che andrà tutto bene ma Laure/Mickaël lo implora di traslocare, di fuggire via. Il padre non risponde, sembra in difficoltà. Il film lascia emergere dai silenzi le possibili domande che agitano l’animo paterno: è davvero l’arte della fuga quella che ha insegnato alla figlia? L’ha sempre assecondata, l’ha incoraggiata nella sua virilità, anzi, ha sognato di farne il suo compagno di poker, avrà fatto bene? La scelta di casting non è banale. Il padre è interpretato da Mathieu Demy, attore e figlio d’arte di una famiglia non convenzionale: la regista femminista Agnès Varda e il regista omosessuale Jacques Demy.
La punizione
La madre, dal canto suo, sembra nutrire più rabbia che dubbi e torna in mente Simone de Beauvoir quando afferma che:
«La figlia è per la madre insieme un doppio e un’estranea, la madre l’ama con imperiosa passione e le è insieme ostile; impone alla fanciulla il suo destino personale: che è poi un modo di rivendicare con orgoglio la propria femminilità, e nello stesso tempo, di vendicarsene. […] Così, le donne, quando una bambina viene loro affidata, vogliono, con uno zelo in cui l’arroganza si mescola al rancore, trasformarla in una donna simile a loro. E anche una madre generosa, che cerca sinceramente il bene di sua figlia, pensa quasi sempre che è più prudente farne una ‘vera donna’, poiché in tal modo le riuscirà facile acclimatarsi alla società.»[15]
Il film concentra la funzione antagonista su un individuo, la madre, anche se questa si legittima evocando un’istituzione, la scuola: «Cosa conti di fare esattamente? Vuoi passare per un maschio tutto l’anno? La scuola comincia tra due settimane, non abbiamo scelta, Laure, dobbiamo dirlo. Sono obbligata, capisci?». La donna dice di agire in nome della scuola e di non avere scelta se vuole evitare alla figlia esclusione sociale e sofferenza. Lo spettro normalizzatore della scuola aveva già iniziato a incombere quando Lisa aveva detto a Mickaël di aver cercato il suo nome tra le liste degli iscritti al nuovo anno scolastico senza averlo trovato.
Come nella scena in cui sancisce la fine del bagnetto, anche stavolta la madre traccia le linee di confine oltre le quali il gioco minaccia la realtà: «Non mi dà fastidio che tu giochi a fare il maschio. Non mi dispiace neppure ma non puoi andare oltre. Si hai un’altra idea dimmela ma io non ce l’ho. Hai un’altra soluzione?». La domanda di soluzione è retorica e Laure/Mickaël lo sa, per questo resta in silenzio. La madre ha chiarito che può essere un tomboy ma non una persona trans* pena la perdita del suo amore, cosa che a dieci anni è un prezzo troppo alto da sopportare.
Convinta che femminilizzare la sua creatura sia dire la “verità” sul suo conto, la donna la obbliga a indossare un abito, peraltro ironicamente blu, e a recarsi prima a casa del bambino picchiato per scusarsi e poi da Lisa. Si tratta di un outing[16] in piena regola, una gogna pubblica, un’umiliazione regolatrice. Tuttavia, la “verità” materna è sconfessata dal lavoro che il film ha operato sul nostro sguardo: con un abito indosso, Laure/Mickaël sembra travestitǝ e fa un effetto dissonante al contrario di quando indossa gli abiti di foggia più maschile. Lo stesso cortocircuito visivo è presente nella sequenza in cui Lisa gioca a truccare Laure/Mickaël credendo di femminilizzare un maschio. Tornando a casa con il mascherone in faccia, lei/lui corre in bagno per lavarsi ma prima di riuscire a farlo la madre lǝ blocca apprezzando l’effetto del trucco sul suo viso. La bellezza è negli occhi di chi guarda e a volte anche il genere.
L’ostensione di Laure/Mickaël in abiti femminili brucia al cospetto di Lisa che ha messo in gioco i propri sentimenti e desideri e a cui la “verità” impone una specie di coming out. Quando vede Laure/Mickaël in abiti femminili, Lisa lǝ osserva da capo a piedi senza dire una parola, poi scompare sbattendo la porta, al che Laure/Mickaël fugge sapendo di aver ferito e ingannato l’amica, innamorata di Mickaël. Nella fuga, Laure/Mickaël cerca rifugio nell’Eden in cui era statǝ felice, il bosco. Sosta tra gli alberi, poi si libera dell’abito e rimane con i calzoncini e la canotta che aveva conservato sotto il vestito, come una seconda pelle. Un movimento di macchina ascendente ci mostra il vestito appeso a un ramo, come una femminilità impiccata. Poi Laure/Mickaël intravede il bambino picchiato riferire agli altri maschi che Mickaël è una femmina, loro si accorgono della sua presenza e lǝ inseguono finendo per catturarlǝ e sottoporlǝ a un processo in cui riecheggia come riferimento intertestuale un noto film del decennio precedente, Boys don’t cry[17]: «Pare che tu sia femmina, ora verifichiamo». Fino a quel momento, nessuno aveva chiesto a Mickaël di mostrare il sesso per sancire se fosse un maschio o una femmina, si erano accontentati del suo nome, di ciò che davano a leggere il suo aspetto e il suo comportamento, per decidere della sua assegnazione. In quel momento arriva Lisa e ordina agli altri di fermarsi ma uno dei compagni la sollecita ad assumersi l’onere della verifica. Lisa prima rifiuta poi cede, incalzata dall’altro che minaccia la sua conformità sessuale: «Se è una femmina, tu l’hai baciata, non ti fa schifo?». «Sì, mi fa schifo», conferma Lisa dopo un momento di silenzio che lascia spazio all’idea che stia solo cedendo alla pressione dei compagni. La verifica avviene fuori campo mentre l’inquadratura mostra solo i due volti di Lisa e Laure/Mickaël di profilo. Sentiamo il suono della zip che viene abbassata, vediamo Lisa che con gli occhi cerca il sesso dell’altrǝ, lǝ guarda senza una parola, con impassibilità accusatoria, per poi richiudere la patta con un gesto stizzito. Colui che ha richiesto la verifica attende il responso. In soggettiva, osserviamo un primissimo piano di Lisa, torvo. La bambina distoglie lo sguardo, poi lo rialza, leggermente addolcito. Così avvertiamo che in lei l’affetto è ancora presente, che si tratti di Mickaël o di Laure, poco importa.
[1] S. de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Gallimard, Paris, 1949; tr. it. di R. Cantini e M. Andreose, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano, 1999, pp. 351-352.
[2] Ivi, p. 392. Nell’originale francese si legge «directement à l’homosexualité».
[3] J. Halberstam, Female Masculinity, Duke University Press, Durham, 1998; tr. it. di F. Frabetti, Maschilità senza uomini. Scritti scelti, ETS, Pisa, 2010, p. 31.
[4] Nella versione del film doppiata in italiano, in realtà, ancora prima della scena di interpellazione con Lisa, la mamma utilizza un participio femminile nel rivolgersi a Laure mentre nella versione francese questa marcatura di genere non è percepibile all’orale.
[5] «Le ragazze si sono truccate e i ragazzi si sono annoiati».
[6] Quanto meno le lingue che qui chiamo in causa ovvero l’italiano, il francese e l’inglese.
[7] J. Butler, Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York, 1997, tr. it. di S. Adamo, Parole che provocano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, p. 7.
[8] Ivi, p. 6.
[9] Cfr. quanto scrive G. Morel, Genre, surmoi et interpellation. À propos de Tomboy de Céline Sciamma, in “Enfances & Psy”, 2012/4, n. 57, pp. 65-74..
[10] L. Feinberg, Stone Butch Blues, Firebrand Books, Ann Arbor, 1993; tr. it. di M. Giacobino e D. Tolu, Stone Butch Blues, Il Dito e La Luna, Milano, 2004, p. 27.
[11] Ivi, p. 28.
[12] Ibidem.
[13] Al maschile nell’originale: «Je vais faire ce qu’il faut, je vais le punir».
[14] L. Feinberg, Stone Butch Blues, cit., p. 29.inglese.
[15] S. de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, cit., p. 337.
[16] La differenza tra coming out e outing sta proprio nel fatto che il primo è un atto volontario che il soggetto compie rivelando pubblicamente qualcosa che prima era nascosto (in the closet). Invece, l’outing è un atto che il soggetto subisce quando qualcuno rivela pubblicamente informazioni private sul suo conto. I termini si riferiscono generalmente all’ambito dell’orientamento sessuale ma possono essere utilizzati rispetto alla transidentità o, per estensione, in altri ambiti (pratiche alimentari, religiose o altro).
[17] Come racconta molto bene J. Halberstam, Trans*. A Quick and Quirky Account of Gender Variability, University of California Press, Oakland, 2018, pp. 99-106, per quanto resti un riferimento noto, Boys Don’t Cry è considerato oggi controverso. Cfr. ad esempio T. Bendix, ‘Boys Don’t Cry’ 20 Years Later: For Trans Men, a Divisive Legacy, in “The New York Times”, 9 ottobre 2019.


