Il modello narrativo del viaggio dell’eroe descritto da Chris Vogler ne Il viaggio dell’eroe prevede il ritorno a casa del protagonista e un lieto fine che riporta l’ordine. Ma che cosa succede se l’eroe non torna a casa? Su Scenari, Fabio Ciabatti prende in considerazione questa ipotesi a partire da Il viaggio rivoluzionario dell’eroe di Antongiulio Penequo (Mimesis Edizioni, 2020) e dal romanzo di Francesca Mannocchi Io Khaled vendo uomini e sono innocente (Einaudi, 2019).
Cosa succede a un eroe quando non riesce a tornare a casa? Questo caso è alquanto eccentrico rispetto al copione tipico della produzione cinematografica hollywoodiana. Il viaggio dell’eroe (Audino 2010) di Chris Vogler, uno dei manuali di sceneggiatura più celebri, ci dice infatti che l’eroe è proprio colui che riesce a riportare a casa un dono capace di restaurare l’ordine violato dopo aver abbandonato la sua realtà quotidiana e aver intrapreso un viaggio in un mondo straordinario nel quale ha dovuto affrontare prove mortali per sconfiggere il nemico. Questo pattern narrativo da una parte è indubbiamente capace di toccare corde emotivamente profonde (il bisogno di giustizia, il desiderio di un’utopia realizzata), dall’altra ha una evidente dimensione consolatoria, politicamente conservatrice. Per questo nel libro collettaneo Il viaggio rivoluzionario dell’eroe (Mimesis 2020), insieme agli altri autori del Gruppo di Studio Antongiulio Penequo, sono andato alla ricerca di esempi devianti rispetto a questo modello: eroi che rimangono a combattere nel mondo straordinario, che dopo il ritorno a casa partono per un nuovo viaggio, che allungano indefinitamente il loro percorso. Un’operazione che ha l’obiettivo di rivendicare una figura “calda” e potente dell’immaginario collettivo evitando di appiattirla unilateralmente su una caratterizzazione reazionaria che pur costituisce un attributo reale della dimensione eroica.
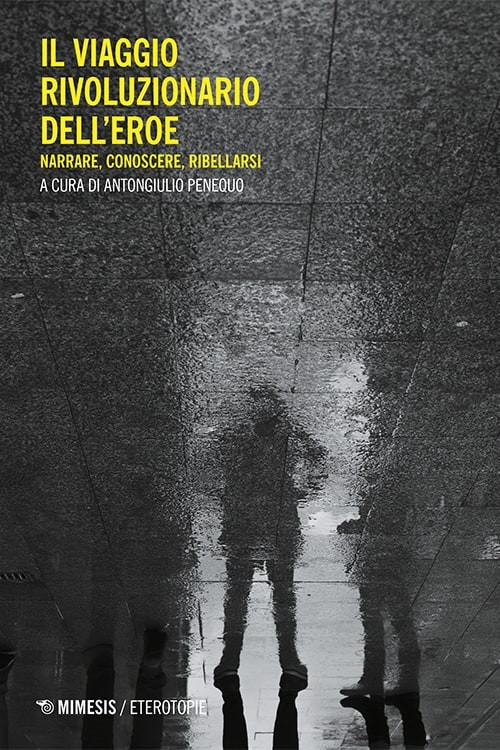
Nel solco di questa ricerca, è particolarmente interessante il protagonista del penultimo romanzo di Francesca Mannocchi, Io Khaled vendo uomini e sono innocente (Einaudi 2019). Khaled è uno scafista, figura che ha rappresentato per un certo periodo il mostro per eccellenza, il male assoluto nel discorso pubblico. L’esatto contrario di un eroe, almeno a prima vista. E infatti allo scafista vengono attribuiti poteri da stregone, laddove per stregoneria intendiamo la capacità di catturare l’anima di un soggetto, strapparla al suo mondo, svuotarla della propria forza vitale e asservirla a una volontà esterna. Senza scafisti, in altre parole, non ci sarebbero migranti perché sono i primi a spingere i secondi a compiere azioni che, se fossero in loro, mai farebbero. Il fatto che i migranti siano “posseduti” ci esime dal provare empatia nei confronti del loro doloroso percorso umano. In questo modo possiamo rimuovere la disumanità della nostra indifferenza, la stessa che non perdoniamo allo scafista.
Tornando al romanzo di Mannocchi, Khaled ci racconta in prima persona, senza seguire un ordine cronologico, la sua storia di bambino nella Libia di Gheddafi, di giovane che partecipa pieno di speranze e ideali alla rivoluzione contro il Rais, di reduce amaramente disilluso che compie i primi passi nel mondo del traffico di esseri umani ancora ostacolati dalla sua compassione per i migranti, di boss oramai affermato che, dividendo il suo business tra il traffico di uomini e la protezione delle postazioni petrolifere, si è oramai “salvato” perché non prova più niente. O almeno così dice.
Uscivamo dalla rivoluzione e io pensavo che la fuga, per gli africani, fosse una ribellione: la loro una rivoluzione senza armi, la rivolta delle ciabatte nel deserto e dei barconi.
Non penso più che cambieremo questo Paese. E non penso che gli africani cambieranno il loro futuro. Io non cambio il Paese e non lascio che lui cambi me. Oggi penso questo, gioco la mia partita. Resisto, provo a salvarmi. Loro vogliono scappare, e io li faccio scappare. È un accordo che serve a entrambi.
La verità è che oggi mi annoio, qualche anno fa no. Volevo ancora capire da dove arrivavano, da cosa fuggissero. Dove volevano andare. E soprattutto come.
Nelle parole di Khaled possiamo vedere che la speranza apre le porte dell’anima alla partecipazione emotiva nei confronti del destino altrui. La rassegnazione, invece, ci isola in noi stessi condannandoci all’indifferenza verso gli altri. Per questo possiamo cominciare a intravedere come il mostro Khaled rappresenti il nostro doppio. Egli è lo specchio di noi lettori italiani, occidentali che non speriamo più di cambiare le cose e per questo proviamo solo a salvare noi stessi, indifferenti al destino altrui, al grido di dolore dei migranti.
Rimaniamo al tema del doppio. Khaled ha il suo alter ego, il fratello maggiore Murad, che per lui è sempre stato un esempio da seguire e con cui ha combattuto nella rivoluzione. La coppia oppositiva è quella tra martire e sopravvissuto. Il martire può essere un eroe, il sopravvissuto no. Murad può essere celebrato anche se ha compiuto gesta terribili durante la rivoluzione perché è caduto nei combattimenti e nessuno gli chiederà conto delle crudeltà che ha compiuto.
Le mani che distruggono non sanno come costruire, chi serve a vincere la guerra deve essere il primo a sparire. La storia non mente, è già successo molte volte. Ma io della storia non sapevo niente, conoscevo solo la storia che stavamo vivendo e mi bastava… Forse la rivoluzione ci sta mangiando, ma questo dubbio l’ho cacciato via. Dovevamo pagare per i nostri peccati. E a me andava bene.
Nessuno può essere veramente un eroe, sembra dirci Khaled. Gli eroi che vengono celebrati sono solo quelli che non possono più dare fastidio nel presente, quelli che non possono più ricordare ai nuovi padroni che il loro mondo è stato costruito con il ferro e con il fuoco, quelli che non possono più proseguire la rivoluzione. I martiri appunto.
[…] tutti volevano farci pentire della rivoluzione. Tutti volevano essere certi che quella ribellione sarebbe stata l’ultima. E hanno cominciato a darci la caccia.
Un’altra coppia di opposti fondamentale nel romanzo è quella costituita dal padre e dal nonno di Khaled. Il padre è il classico “camaleonte” libico (termine utilizzato, non a caso, dal nonno per definire una delle caratteristiche tipiche del popolo libico): si adegua sempre alle circostanze con la più classica delle scuse, tengo famiglia, ma in realtà non si limita a subire passivamente perché approfitta delle diverse situazioni per trarne piccoli vantaggi, anche a costo di azioni riprovevoli come denunciare gli amici alla polizia del regime. Il padre non ama Gheddafi, ma ne ha paura.
Anche il nonno non ama Gheddafi, ma non lo teme. Il nonno è un uomo saggio e, come egli stesso diceva, “I saggi in questo Paese sono destinati alla solitudine, a vivere agli angoli della società”. Le parole del nonno, per Khaled bambino, erano un mistero.
Ho capito solo dopo che non erano parole, erano pozioni magiche, enigmi che mi stava lasciando in eredità. L’ho capito solo dopo, che eravamo così schiavi che i vecchi dovevano inventare una lingua magica, una lingua di sciarade per raccontare la realtà.
Le parole del nonno sembrano perdersi nell’aria ma si piantano come una radice. La sua è una lingua magnetica e selvaggia, come il silenzio del deserto che è profezia capace di indicare la strada, ma soltanto per chi vuole ascoltarlo. Le sue parole sono come la stella guida che si scorge nel cielo: ti sa dire dove sei anche se questo non basta perché per sapere dove andare, la destinazione deve essere già chiara dentro di te.
Gli eroi non esistono – è ancora il nonno a parlare – esiste solo la memoria. La memoria, Khaled, devi custodirla … le migliori intenzioni non fanno futuro se non c’è memoria. Se non c’è memoria non c’è libertà.
Il nonno e il fratello Murad sono gli interlocutori espliciti del racconto confessione di Khaled. Il fratello dà corpo al tono nostalgico del racconto. Nostalgia non per un passato perduto, ma per ciò che per un periodo Khaled pensava sarebbe potuto accadere. Nostalgia per quella libertà cercata a costo di mettere in pericolo la propria vita, ma che si era rivelata essere solo una ubriacatura momentanea. Nonostante le nefandezze compiute, la morte aveva cristallizzato il fratello nel momento magico in cui la libertà, la liberazione dalla paura sembravano a portata di mano.
Il nonno a prima vista sembra essere l’espressione di un’antica saggezza non contaminata dalle miserie del presente. E in parte è certamente così. Però, andando forse al di là delle intenzioni dell’autrice, si può dire qualcosa di più. La magia, secondo l’antropologo Ernesto de Martino, è uno strumento per scongiurare il rischio della disgregazione, del venir meno dell’ordine quotidiano, del tessuto delle relazioni e dell’affidabilità del mondo. E lo fa mettendoci in contatto con un mondo altro, non immediatamente visibile, non riconducibile alla meccanica degli elementi, abitato da forze e intenzioni potenzialmente benefiche (il silenzio del deserto che è profezia, le stelle che indicano la via). Possiamo pensare questo mondo come popolato da potenze primordiali che sempre sono esistite e che, anche se dimenticate, sempre esisteranno. Come la verità invisibile che sta sotto la fenomenicità del visibile. E allora la magia diventa una forma difensiva per riportare sotto il segno dell’eterno ritorno gli eventi che disgregano il nostro mondo. Oppure possiamo pensarlo come un mondo che sta al margine del nostro, come il mondo dell’immaginario, cioè la regione dove stanno il possibile, il potenziale, l’inattuale, il represso, i fantasmi, le memorie implicite e i presupposti inconsci. E allora può considerarsi come un modo per destreggiarsi in ciò che non è deciso in anticipo.
Di certo Khaled è una figura del margine. Così si chiude il romanzo:
Tutti cercano di muoversi verso la luce, nonno. Io no, resto qui, sul limite, sul confine. Sulla linea da oltrepassare, rimango sul limite.
Chi vuole attraversarlo verrà da me, che il prezzo lo pago restando.
Khaled è un eroe che non ce l’ha fatta a trasformare il mondo e si è trasformato in mostro. È un eroe che non è riuscito a tornare a casa: “La strada verso casa è la più dolorosa delle strade se casa non ti appartiene più”, gli dice l’amico Fahmi, con parole che non a caso ricordano a Khaled quelle del nonno. Khaled è rimasto sospeso tra il mondo straordinario di una rivoluzione fallita e quello ordinario della nuova Libia in cui non vuole avere un posto al sole, riciclandosi come uno dei tanti camaleonti libici: “Almeno io non mi sono seduto in un ministero, tra i riciclati. Ho scelto il lavoro sporco, sono più onesto”.
La lingua magica del nonno è una porta che rimane socchiusa verso un mondo altro in cui non esistono eroi, ma esiste solo la memoria senza la quale non c’è futuro e non c’è libertà. Ma al tempo stesso lasciare aperto questo spiraglio è ciò che danna Khaled, ciò che lo costringe a rimanere sul limite a piangere sui suoi peccati, come dice il nonno.
Khaled in effetti è uno stregone. Il patto che i migranti stringono con lui per raggiungere l’Europa è davvero un patto con il diavolo. Khaled si impadronisce della loro volontà per le sue finalità. Khaled si appropria delle potenze del mondo moderno: denaro, armi, rapporti con i suoi dominatori. Lo fa per non soccombere: “Non posso più fermarmi adesso. Devo rimanere forte perché ho visto cosa fanno ai deboli. E non voglio finire così”.

Ma Khaled non è il diavolo, è solo un intermediario. Il vero diavolo sono le potenze capitalistiche che hanno disgregato il mondo dei migranti e contemporaneamente li hanno ammaliati con la possibilità di raggiungere un altro mondo incantato. Lo stregone è oggetto della più profonda esecrazione perché a lui sono imputate le caratteristiche più oscure che l’accusatore non vuole ammettere appartengano a se stesso. E allora noi possiamo essere innocenti solo se anche Khaled lo è. E forse Khaled è meno colpevole di noi. Per quanto consciamente affermi di essersi salvato grazie alla sua indifferenza, il suo sonno è infestato dai fantasmi di coloro che ha visto morire affogati.
Smettila di torturarmi il sonno, crudele di una siriana. Non ne posso più di sentirti gridare ‘Aiuto, aiuto’ e ‘Salvatemi, salvatemi’. Sono tre anni che gridi aiuto, sono stanco della tua voce che mi opprime e mi perseguita.
Ma il fantasma che appare in sogno a un singolo non basta.
Siete morti in tanti, non mi pento. Ho fatto quello che dovevo fare. Hai dimenticato come imploravate di partire? Non ti ho uccisa io.
Non sei morta per colpa mia.
Finché i fantasmi non diventano memoria collettiva non bastano a spingere all’azione. Se rimangono una faccenda meramente privata e onirica portano soltanto a rimanere intrappolati, come Amleto, tra l’essere e il non essere.
Non riesco a dimenticare e non voglio ricordare, non voglio più ospitare il ragazzo che sono stato, che mi torna in sogno, il ragazzo ingenuo che si chiedeva perché non potessimo avere pietà di quelle persone, mentre gridavano chiedendo pietà e noi gridavamo chiedendo libertà stavamo già comportandoci come quelli che consideravamo nemici.
L’eroe che alla fine del suo viaggio torna a casa con l’elisir della felicità, come vorrebbe lo schema hollywoodiano alla Vogler, forse può essere solo l’eroe che sta dalla parte dei vincitori della storia. Per gli sconfitti la casa è ridotta a un cumulo di macerie. All’eroe che sta dalla parte dei perdenti non rimane che aggirarsi tra le macerie infestate dai fantasmi. Queste presenze spettrali, se diventano immaginario condiviso, possono spingerlo a combattere ancora. Se rimangono un demone personale lo immobilizzano in un mondo disumano trasformandolo in un mostro.


