Tra le opere più significative della letteratura tedesca del XIX secolo, Vittoria Accorombona, il romanzo storico a firma di Ludwig Tieck (1773-1864) pubblicato nel 1840 – e da poco ripubblicato per i tipi di Bompiani (collana Narratori stranieri), nella traduzione italiana di Francesco Maione e a cura di Stefan Nienhaus – raccoglie, all’interno della sua complessa trama, un “contenuto sedimentato” di motivi, riferimenti, spunti.
Se da un lato può essere considerato come il testamento poetico dell’autore, quasi un precipitato di questioni legate al Romanticismo tedesco, dall’altro i temi e la struttura dell’opera segnano un momento di rottura con l’assetto letterario tradizionale. Pagine coraggiose, queste di Tieck, come si evince già dalla scelta della protagonista: una nobildonna artista che muove i suoi passi in contrasto con il clima sociale, corrotto e violento, che attanaglia l’Italia di fine Cinquecento.
L’eroina del romanzo in cinque libri risponde al nome di Vittoria Accorombona (o Virginia Corombona). Si tratta di un personaggio realmente esistito, Vittoria Accoramboni (1557-1585), figura di intellettuale nativa di Gubbio da una famiglia nobile di origine marchigiana, che ebbe una vita tumultuosa tra intrighi e corti rinascimentali. Fu una donna di grande cultura e una poetessa, che finirà vittima di una serie di soprusi, senza trovare protezione da parte della giustizia. Anzi verrà barbaramente violentata e assassinata da chi per ottusità non riconobbe e non accettò la sua “via eccentrica”, la sua autonomia e intraprendenza, la sua identità personale e culturale.
Tieck non è il primo scrittore che si è lasciato ispirare dalla tragica “forma di vita” di Vittoria Accoromboni – già Stendhal aveva dedicato, quattro anni prima, un racconto alla poetessa italiana, ed entrambi gli scrittori mutuano dalla tragedia inglese poco nota del drammaturgo elisabettiano John Webster The White Devil, or Vittoria Corombona, del 1612.
La novità introdotta dalla penna di Tieck sta però nel suo indugiare sulla questione del femminicidio. In realtà, a ben vedere, la trama del testo è intessuta da diversi episodi di violenza, in una impressionante scia di sangue reale o ipotizzato tale che recide la vita, oltre che di uomini, anche di quattro donne illustri – come Isabella e Lucrezia de’ Medici, Eleonora di Toledo e la stessa protagonista.
Lo sfondo storico sul quale si stanziano questi fatti tragici è il tardo Cinquecento italiano (per la precisione l’arco temporale 1575-1585), caratterizzato da un’atmosfera oscura, di decadenza e di corruzione, in cui gli Stati hanno perso il loro ruolo di garanti dell’ordine e della giustizia, sopraffatti dai soprusi dei potenti locali e scardinati dalla ferocia dei rivoltosi masnadieri. È lo stesso Tieck a ribadire sin dall’introduzione che la sua opera non deve essere intesa nei termini di un’invenzione poetica, ma come un ritratto fedele dell’età rinascimentale. Un romanzo storico, quindi, ma anche altro. Di certo un monito per i lettori del romanzo di Tieck, in un periodo in cui già si presagivano i primissimi vagiti della rivoluzione del 1848.
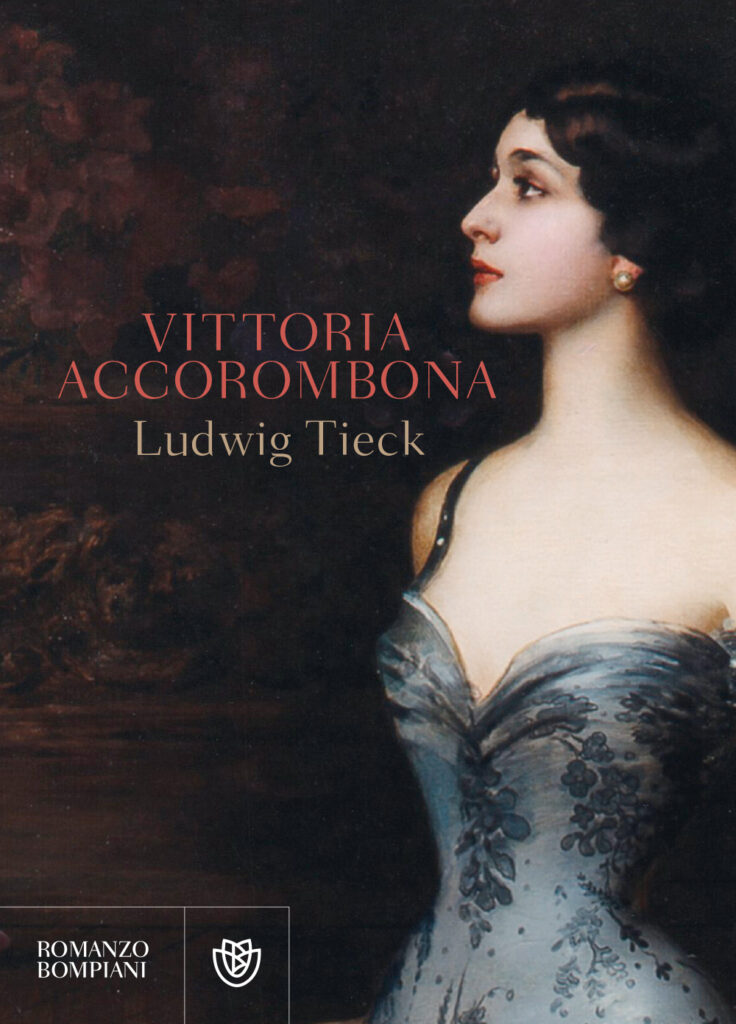
Nel panorama dalle tinte fosche che costituisce lo scenario del romanzo, colpisce ancora di più, come in un gioco di chiaro-scuro, la silhouette luminosa di una vita nobile e pura come quella di Vittoria, la sua giovinezza sotto l’accorto (ma mai costrittivo) sguardo materno, fino alla morte violenta per mano di chi non accettava la sua autonomia e indipendenza di donna e di intellettuale, la sua superiore intelligenza e il suo spiccato talento poetico. Quasi una traccia utopica (e romantica), quella tratteggiata dalla giovane artista, soprattutto nella sua breve ma intensa e paritaria unione (aura della sacralità) con Paolo Giordano di Bracciano.
La “prodigiosa bellezza”, così come la nobiltà, di Vittoria è al contempo fisica e spirituale, estetica ed etica. E infatti, pur sottolineando l’aura di “seduttività” corporea che caratterizza Vittoria, Tieck insiste sempre di più nel corso del romanzo sulla sua potenza espressiva che rivela i moti dell’animo. La bellezza di questa poetessa, sembra volerci dire Tieck, non è statica – e per questo non può essere associata a un quadro, neanche ad una raffigurazione di Tiziano (che pure si avvicina alla sua eleganza estetica) – ma piuttosto è dinamica, in trasformazione, fluida, patica. Non è un caso se, sin dal primo capitolo, la figura di Vittoria è associata al “bello naturale”, alla cascata, al torrente, al movimento (anche vorticoso) delle forze degli elementi. Una bellezza, quindi, che non si lascia “mettere in forma”, ma che piuttosto produce, espone le sue latenti potenzialità.
La sua concezione estetica risponde al paradigma della libertà, in una forma di creatività che non può certo prescindere dalla regola, ma che non deve neanche lasciarsi vincolare da questa, pena il rischio di un irrigidimento. Grazie anche alla vulcanicità della sua personalità artistica, la Vittoria Accorombona di Tieck dialoga alla pari con altre stelle del firmamento letterario. Interlocutore privilegiato delle sue conversazioni è Torquato Tasso, attraverso il quale vengono anche narrate le vicende rocambolesche della Gerusalemma liberata. Una scelta di certo non casuale, visto che Torquato Tasso era stato immortalato dal genio di Goethe come il poeta che personifica, per eccellenza, il conflitto lacerante tra potere e arte. Ed è forse proprio in questo dissidio che va ricercato l’altro filone del romanzo.
Se il potere cade in mano alla barbarie, se la vita politica è ottenebrata da un’atmosfera di calunnie e di complotti – come accadeva nella seconda metà del Cinquecento nelle corti italiane – la diversità, la non-conformità si copre di sospetto.
È per questo che la vita di Vittoria, poetessa e intellettuale indipendente, donna “fuori degli schemi”, non-contemporanea, “deve” essere offesa, la sua voce deve essere messa a tacere, la sua fiamma deve essere spenta. Questo almeno nell’intento dei malfattori che la trucidano con gesto esemplare nel buio della sala dedicata alle opere d’arte (secondo un sogno premonitore che Vittoria aveva avuto da ragazza), ovvero nel luogo che dovrebbe sancire, consacrare idealmente la bellezza prodotta dall’azione umana. Tieck non risparmia a questa scena i timbri forti e brutali che le si addicono, descrivendo attentamente un rituale di stupro e di sopraffazione che deve ristabilire le gerarchie di genere. Ma questa è solo la penultima parola.
Il romanzo tieckiano non termina con il quadro cupo di violenza e di morte dell’uccisione di Vittoria. Tieck decide di aggiungere alle scene narrate un’appendice finale che, descrivendo con minuziosa precisione storica la condanna di Orsini come mandante dell’atroce ed efferato delitto, punta a far intravedere un pur debole barlume di speranza.
Certo – come giustamente nota il curatore Stephan Nienhaus nella sua accurata postfazione – non è in gioco una “redenzione” volta a ristabilire un qualche senso alle vicende di insensata violenza descritte nel romanzo. Niente di tutto questo. Si tratta di una dichiarazione d’intenti, perpetrata attraverso la stesura dell’opera Vittoria Accorombona, di serbare memoria di questa “vita offesa”, restituendole la voce. In qualche modo vale anche per questo romanzo la famosa tesi esposta da Walter Benjamin nelle sue note sulle Affinità elettive di Goethe: “solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza”. E questo monito è nel panorama attuale ancora da tenere presente.


