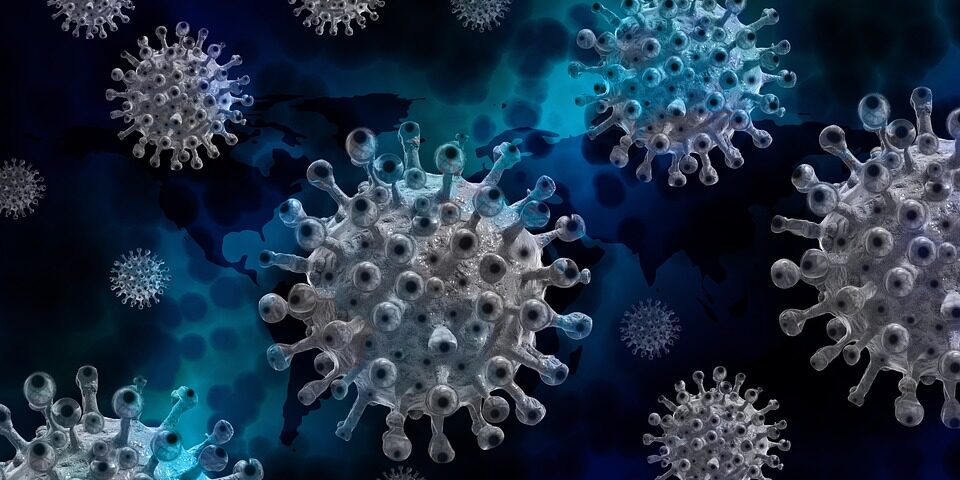È opinione diffusa che il coronavirus colpisca in modo indiscriminato e senza fare distinzioni tra ricchi e poveri, uomini e donne, giovani e anziani, lavoratori tutelati e lavoratori precari. Si tratta di una convinzione largamente condivisa e che gode di ampio sostegno, anche perché contribuisce a fare in modo che le misure adottate per impedire la diffusione del contagio vengano osservate da tutti gli strati della popolazione – dal momento che nessuno può ritenersi preventivamente immunizzato dalla possibilità di essere colpito dalla malattia. Non è detto però che le cose stiano esattamente così.
Sinora si è dedicata molta attenzione al tasso di mortalità correlato all’età e a malattie preesistenti. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità il tasso di letalità in Italia di Covid-19 è del 27,4% per gli ultranovantenni, del 30,8% tra gli ottantenni, del 22,6% tra i settantenni, dell’8,5% tra i sessantenni, del 2,3% tra i cinquantenni. La presenza di patologie preesistenti, specie cancro, diabete, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario rappresenta un fattore supplementare di rischio. In questo caso si può parlare di fragilità, dal momento che si tratta di fattori sui quali è difficile intervenire, per quanto sia noto che l’invecchiamento e l’insorgere delle malattie non condizionino le persone esattamente allo stesso modo. Almeno in una certa misura, presentano infatti caratteristiche differenti a seconda delle diverse possibilità socioeconomiche di accesso alle cure e alle risorse sanitarie. Vi sono tuttavia altre due situazioni nelle quali i margini di intervento sono maggiori e dove è sia possibile sia necessario intervenire.
La prima è rappresentata dalle diseguaglianze, che colpiscono i gruppi sociali svantaggiati e riguarda tutti coloro che vivono in alloggi e in condizioni abitative che sono tali da impedire il rispetto delle misure anche più elementari di prevenzione. Chi vive negli appartamenti dalle metrature ridotte e sovraffollati dei quartieri popolari o nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, oppure nei ghetti rurali nelle regioni del Sud – dei quali molto si è discusso negli anni precedenti e molto si discute tuttora a causa del bisogno di manodopera per la raccolta nel mezzo dell’emergenza socio-sanitaria – è più esposto al contagio rispetto a chi vive in condizioni igieniche adeguate e senza i rischi connessi alla promiscuità e al sovraffollamento. Ma vi è anche chi non è in grado di autoisolarsi perché situazioni di lavoro precarie o insicure non permettono il telelavoro oppure l’opportunità di usufruire di un congedo per malattia. Le disparità di cui soffrono questi gruppi sono oltretutto gravate da una doppia ingiustizia: da un lato li si incolpa per la maggiore esposizione al rischio di cui si rendono “colpevoli”, dall’altro li si sottopone a misure di controllo più repressive di quelle adottate per il resto della popolazione. Rischiano perciò più di altri di subire le conseguenze del virus: conseguenze sanitarie, per la probabile mancanza di un intervento tempestivo, e conseguenze sociali, per lo stigma cui rischiano di essere sottoposti a causa di responsabilità e inefficienze non loro ascrivibili.
La seconda è rappresentata dalla discriminazione, che riguarda le categorie di persone costrette, loro malgrado, a vivere in condizioni che ostacolano il rispetto delle misure precauzionali. I carcerati, anzitutto. Il noto problema di sovraffollamento delle carceri, per cui l’Italia è stata condannata nel 2013 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, le trasforma in luoghi ideali la diffusione del virus, poiché il distanziamento sociale ritenuto necessario per chi è libero non è possibile per chi è recluso. Il decreto Cura Italia ha permesso le detenzioni domiciliari a persone condannate per reati non gravi con meno di 18 mesi da scontare, ma la carenza di braccialetti elettronici ne ha limitato l’applicabilità. Un discorso analogo vale per gli stranieri internati nei centri di detenzione amministrativa per effetto della loro situazione irregolare e che, in attesa di essere espulsi, si trovano in una situazione che non si sa se sia più pericolosa o più assurda, dal momento che i voli necessari a riportarli nei paesi d’origine sono sospesi. Infine, i senzatetto e molti richiedenti asilo, sfrattati dai dormitori che li ospitavano e accampati nelle strade o nelle piazze in condizioni degradanti. In casi come questi non è improprio parlare di discriminazione, ossia di un trattamento sfavorevole basato su un criterio illegittimo, perché né il fatto di avere commesso un reato, né l’assenza di un permesso di soggiorno, né la povertà estrema possono giustificare una condizione in cui il rischio di contrarre una malattia potenzialmente letale è particolarmente elevato – e potenzialmente evitabile. Il migrante irregolare non è ovviamente iscritto al Sistema Sanitario Nazionale e di conseguenza non può ricorrere al medico di base, e ha diritto soltanto alle prestazioni sanitarie urgenti. Mentre in caso di una malattia non grave evita di indirizzarsi alle strutture sanitarie, nei casi più gravi non può fare altro che recarsi al pronto soccorso, violando i protocolli adottati per contenere la diffusione del virus. Il sans papier ha timore di presentarsi in un ospedale, perché potrebbe incappare in un controllo che lo porterebbe all’espulsione o alla reclusione in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio
Fragilità, diseguaglianza e discriminazione sono le tre categorie che ci permettono di capire come l’incidenza del virus non sia uguale per tutti. Naturalmente nessuna esclude le altre e nelle situazioni reali le sovrapposizioni non mancano, ma questa distinzione potrebbe risultare utile per riflettere su forme differenziate di responsabilità collettiva riguardo alle forme di intervento che si rendono necessarie per correggere queste disparità. Le misure di contenimento e prevenzione sinora attuate rappresentano certamente una risposta adeguata alle situazioni di fragilità. Ma un principio di giustizia sanitaria, che non sia solo di controllo o di polizia, richiederebbe soluzioni diverse per le altre due categorie. Certo, nell’immediato, una politica volta a contrastare le disparità dovute alla condizione socioeconomica può apparire velleitaria, poiché una diversa politica abitativa richiederebbe tempi lunghi. Nel caso della discriminazione, alcune soluzioni sono invece a portata di mano. Ad esempio, si potrebbero prevedere misure volte a favorire un deflusso controllato dagli istituti penitenziari e a contenere i nuovi ingressi in carcere, ampliando, quando possibile, il concetto di custodia cautelare quale soluzione di ultima istanza e favorendo pene meno afflittive, ma comunque in grado di assicurare le esigenze cautelari cui sono finalizzate. Oppure, nel caso dei migranti irregolari, ossia del mezzo milione di persone che popolano i più vari contesti sociali, dalle grandi stazione ferroviarie ai centri produttivi agroalimentari, dagli ex Sprar alle comunità presenti nei centri urbani, sarebbe opportuno pensare a misure non temporanee di regolarizzazione.
In realtà, la questione della diseguaglianza e della discriminazione riguarda, non solo in astratto, potenzialmente tutti. Se in situazioni di emergenza il numero di pazienti ricoverati risulta superiore a quello delle strutture di cura disponibili nei reparti di terapia intensiva, i medici devono necessariamente compiere una scelta tragica, quella di mettere una vita in contrapposizione con un’altra. La questione della diseguaglianza e della discriminazione diventa essenziale poiché è evidente il rischio che non tutte le vite vengano trattate allo stesso modo e che le differenze di trattamento siano indicative del diverso valore loro accordato. Apparentemente, con la pandemia, quando la questione della sopravvivenza è prima di tutto fisica, il valore della vita come fatto sociale e politico si riduce e si incrementa il suo valore come fatto naturale e biologico. In realtà, la tensione fra i modi specifici di esistenza e la comune condizione di umanità mette in luce come una gerarchia socialmente predeterminata delle vite possa essere implicitamente stabilita o persino esplicitamente ammessa. Per questo, considerare la vita nella prospettiva della vulnerabilità, della discriminazione e della disuguaglianza, piuttosto che nella prospettiva del principio della sua valorizzazione astratta, può offrire sia una diversa prospettiva di intelligibilità del mondo sociale sia nuove possibilità di intervento.