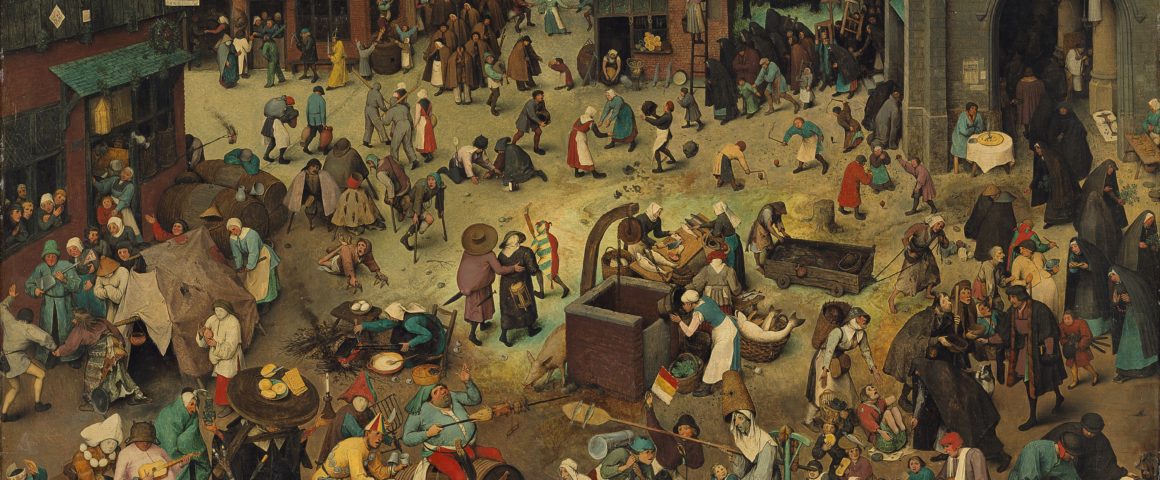«Così come il sentiero nasce camminando, allo stesso modo dobbiamo continuamente improvvisare modi di vita per andare avanti, cambiando rotta anche quando seguiamo le orme dei predecessori. Agiamo in questo modo, comunque, non in isolamento, ma in compagnia degli altri»
Tim Ingold
Ciò che realizzai in quel fatidico giorno del 1988 fu che questa concezione bipartita dell’uomo, con un piede nella natura e l’altro nella società, doveva sparire. Perché tra la connessione genetica e la categorizzazione sociale, non resta più spazio per la vita, che sparisce nella frattura. Nella vita, le relazioni non sono stabilite in anticipo, ma devono essere continuamente poste in essere. Le relazioni di parentela, ad esempio, si realizzano in una miriade di gesti di cura e attenzione in cui le persone vengono nutrite, cresciute ed educate. Nonostante ciò, la persona allevata in una matrice di relazioni parentali è un organismo, e cresce in un ambiente che include umani e non umani. La protezione familiare e la crescita sono quindi due modalità, rispettivamente sociale e biologica, di descrivere lo stesso processo di ontogenesi, il continuo perpetuarsi dell’essere o, altrimenti detto, della vita. Qualunque sia la disposizione che una persona dimostra nei confronti degli altri, in ogni momento, si sarà sviluppata all’interno di questo processo. L’amore dei genitori per i propri figli, ad esempio, nasce da un’intimità di vita condivisa in casa; non può essere ridotta all’effetto di una plausibile correlazione genetica. Ma non per questo è meno “biologica”. Gli umani, in breve, sono esseri biosociali, non perché essi siamo il prodotto dell’interazione tra geni e società, ma perché producono sé stessi e gli uni con gli altri in continuo, come creature viventi e che respirano. Non sono due cose, ma una sola.
Che gli esseri umani si costruiscano tra loro nel corpo e nella mente, così come nei compiti pratici della vita sociale, è oggi un’idea quasi scontata. Ma è potuta emergere solo grazie a uno dei più profondi cambiamenti dell’antropologia degli ultimi trent’anni, da un pensiero strutturale predominante dei primi decenni, a una modalità di ricerca che si concentra sulle relazioni, non solo perché derivanti dalla società, ma in quanto tessuto costitutivo della vita sociale. La realtà stessa, possiamo dire ora, è relazionale a ogni livello. Tuttavia questa affermazione non ci porterà molto lontano, a meno di chiarire con maggiore esattezza che cosa significhi.

Che cos’è in ogni caso una relazione sociale? La domanda ammette tre possibili risposte, ma solo l’ultima racchiude i principi di una vera ontologia relazionale. La prima risposta è che ogni relazione è una sequenza di interazioni che emergono nel corso del tempo. In un’interazione le due parti si incontrano e negoziano fino a quando la natura le mantiene reciprocamente vicine. Questa soluzione enfatizza l’approccio transazionalista spiegato in precedenza, proprio come la concezione sociobiologica della società che la concepisce come un aggregato di individui della stessa specie che interagiscono tra loro. La seconda risposta, con la quale gli antropologi hanno cercato di reagire alla sfida posta dalla sociobiologia, concepisce le relazioni in maniera piuttosto differente, non tanto come rapporto tra individui, quanto tra i ruoli che essi possono ricoprire all’interno di una struttura consolidata e istituzionalizzata, come tra genitore e figlio, tra maestro e allievo, tra dottore e paziente. Proprio perché il dibattito sociobiologico ogni parte intende per relazione qualcosa di diverso, hanno finito per parlare senza ascoltarsi. La terza risposta sostiene che le relazioni siano modi che gli esseri viventi attuano per andare avanti insieme e per modellare l’esistenza gli uni degli altri. Il fattore chiave è l’idea che le relazioni, nel loro svolgersi, generino continuamente gli esseri che legano. Nel gergo antropologico, gli “esseri-in-relazione” sono “mutualmente costituiti”. Per esprimerlo più semplicemente, le relazioni che intratteniamo con gli altri entrano dentro di noi, rendendoci ciò che siamo. E agiscono allo stesso modo anche negli altri. Quindi, quando ci connettiamo con gli altri e allo stesso tempo cerchiamo di differenziarci da loro, questi due meccanismi di unione e differenziazione agiscono dall’interno. Gli esseri non tanto interagiscono quanto intra-agiscono. Sono cioè dentro l’azione. Le implicazioni derivanti dal pensiero relazionale su cosa significhi essere una persona o esercitare agentività nei rapporti sociali restano il tema focale del dibattito attuale, in gran parte ispirato dagli sviluppi in antropologia del pensiero femminista, che si è abbondantemente speso per sfidare le tradizionali polarizzazioni di genere, tra agentività maschile e sottomissione femminile. Questo tipo di pensiero ha portato comunque gli antropologi sociali ha un clima di rinnovata tensione con i colleghi dell’antropologia biologica mainstream, che rimangono in gran parte fedeli alle convenzioni della teoria evoluzionista di Darwin. Il problema è che, per far funzionare la teoria, ogni essere dovrebbe essere postulato come un individuo discreto in una popolazione di individui, reso unico da un’eredità conferita a priori dalla sua vita nel mondo, e che si relaziona con gli altri sulle linee di un contatto esterno che lascia inalterato il suo corredo ereditario.
I biologi lo chiamano “population thinking”[1]. E contraddice in ogni aspetto il pensiero relazionale. Perciò, invece di constatare la complementarietà di due aspetti dell’essere, quello sociale e quello biologico, ci troviamo ora di fronte a una rottura tra due modi di comprendere dell’essere stesso, composto cioè da due ontologie, rispettivamente una “di relazione” e l’altra “di popolazione”. L’assoluta incompatibilità di queste ontologie è in gran parte responsabile dell’attuale stallo nei negoziati tra l’antropologia sociale e quella biologica. Per uscire dall’impasse ci vorrebbe addirittura una biologia radicalmente alternativa, che consideri l’organismo vivente come fondamentalmente costituito nella sua relazione con gli altri così come oggigiorno l’antropologia sociale intende la persona. Questo tipo di biologia ci chiederà di ripensare l’evoluzione non come un cambiamento nelle linee di discendenza ma come il dispiegarsi dell’intera matrice relazionale in cui si generano e sopravvivano tanto le forme umane quanto quelle non umane, e dovremo considerare queste forme non come geneticamente o culturalmente preconfigurate, ma come i risultati che emergono incessantemente da processi di sviluppo o ontogenetici. Questo ripensamento potrebbe significare una rivoluzione nelle scienze umane del secolo in corso, forse più della portata che ha avuto il paradigma darwiniano nei secoli passati. Il lavoro consiste nell’andare avanti. In campi così diversi come la biologia molecolare, l’epigenetica, l’immunologia e la neurofisiologia, le scienze biologiche sono in pieno cambio di paradigma verso un mondo postgenomico, in cui la logica darwiniana non viene più applicata. Questo lavoro sta convergendo verso una nuova sintesi, al tempo stesso processuale, evolutiva e relazionale. Una sintesi che ha spalancato le porte all’antropologia contemporanea e che sarà fondamentale per il futuro della disciplina.
[…] Lo scopo dell’antropologia è di attingere a ciò che abbiamo appreso, grazie alla nostra educazione con gli altri, per immaginare condizioni e possibilità di vita diverse. Come antropologi, credo, dovremmo apprezzare questa libertà di fare congetture, di dire ciò che noi pensiamo, senza fingere che le nostre parole siano di fatto un distillato delle visioni dei popoli tra cui abbiamo studiato. Naturalmente se non fosse stato per queste ricerche, non potremmo dire nulla di ciò che invece affermiamo. Ma non spetta a noi parlare a nome dei nostri insegnanti. Parliamo con i nostri cuori e le nostre menti, non con i loro, e sarebbe senza dubbio disonesto fingere il contrario. È proprio in virtù della ricchezza dell’esperienza umana di cui siamo portatori che noi antropologi abbiamo cose estremamente importanti da dire, e dobbiamo essere presenti per riaffermarle.
Se non saremo in grado di farlo, ci saranno altri, di tendenze più intolleranti o scioviniste, pronti a riempire il vuoto. In quale altra disciplina, in fin dei conti, i professionisti rinuncerebbero al privilegio di far sentire la propria voce? E se lo fanno loro, possiamo farlo anche noi. Inoltre, una volta che gli scopi dell’antropologia saranno distinti da quelli dell’etnografia, per gli antropologi si apriranno altre innumerevoli possibilità per prendere parte alla conversazione, ad esempio attraverso le pratiche dell’arte, del design, del teatro, della danza e della musica, per non parlare dell’architettura, degli studi museali e della storia comparata. Una proficua collaborazione con gli operatori di questi settori dipende appunto dalla consapevolezza che ciò che stiamo facendo non è etnografia.
Pur non considerando gli ostacoli esposti sopra, all’antropologia resta ancora una montagna da scalare per correggere i malintesi che circondano il suo profilo pubblico; gli stereotipi nell’opinione pubblica abbondano. Uno di questi è l’immagine dell’intrepido cacciatore di reperti fossili, determinato a scovare le risposte che rivoluzioneranno la storia delle origini dell’umanità, fino al punto di infiltrare tra le sue scoperte dei falsi per ingannare i colleghi. Ci vollero quattro decenni prima di capire che l’uomo di Piltdown, “scoperto” nel 1912 in una cava di ghiaia dell’East-Sussex, era una bufala. L’identità del falsario resta ignota, anche se abbiamo già incontrato uno dei principali indiziati nel terzo capitolo; nientemeno che Sir Arthur Keith, che nel 1938 inaugurò un monumento in memoria della scoperta e al suo “scopritore”, un certo Charles Dawson. Le immagini della creatura battezzata Eoanthropus dawsoni, irsuta, con una lancia in una mano e con un’ascia di pietra nell’altra, abbellirono per lungo tempo le pagine delle riviste popolari. Che grande opportunità che l’anello mancante tra scimmia e uomo giacesse proprio nel cuore dell’Inghilterra! Per coloro che erano cresciuti con il mito moderno delle origini, cioè che in un fatidico momento del passato i nostri geniali antenati avessero interrotto i legami con la natura per cominciare la loro inesorabile ascesa verso la civilizzazione, il ritrovamento dei reperti dei primi umani restò un argomento dal fascino intramontabile. L’ipotesi oggi in voga dell’Out of Africa presume che una stirpe di esseri superiori si sia allontanata dalla sua culla africana per colonizzare il mondo. Una supposizione che assomiglia incredibilmente alla storia della conquista coloniale messa in atto dai bianchi europei, favorita da Darwin e dai suoi contemporanei. La narrazione andrebbe rovesciata, ma la struttura è la stessa: una razza dominante, dotata di un’intelligenza superiore, in grado di soppiantare tutto il resto.

Il campo dell’antropologo non è ovviamente un laboratorio e nemmeno un luogo per esperimenti di natura scientifica in uno scenario allestito ad arte per poter testare delle ipotesi precedentemente formulate. Ma, come in ogni momento della vita quotidiana, possiamo sperimentare intervenendo nelle cose e andando dove ci portano i nostri interventi. Si tratta di fare domande sugli altri e sul mondo, e di aspettare le loro risposte. Questo è ciò che accade in ogni conversazione. E come avviene in ogni conversazione, questo cambia le vite di tutti coloro che sono coinvolti. Ma la conversazione antropologica, concepita come un’arte dell’inchiesta, non deve essere opposta alla scienza. Si tratta piuttosto di orientarsi verso un modo diverso di fare scienza, più umile, umano e sostenibile di quanto non accada oggi nella scienza. È prendere parte al mondo più che arrogarsi il potere esclusivo di spiegarlo. L’antropologia non aspira né alla mera riduzione dei fatti in puri dati né a convertirli in prodotti o in ciò che le ricerche a carattere politico descrivono come output. […] ciò che motiva gli antropologi, in ultima istanza, non è una pretesa di conoscenza ma un’etica della cura. Non ci preoccupiamo per gli altri se li trattiamo come oggetti di indagine, assegnandoli a categorie e contesti o fornendo spiegazioni su di loro. Ci prendiamo cura di loro portandoli in nostra presenza, in modo che loro possano conversare con noi e che noi possiamo imparare da loro. Questo è il solo modo per costruire un mondo dove ci sia spazio per tutti. Ed è solo assieme che potremo costruirlo.
[1] Si preferisce lasciare qui la definizione originale in inglese, facente riferimento a una teoria specifica, di cui non esiste traduzione italiana convalidata; per ulteriori approfondimenti si veda online alla seguente URL: www.edge.org/response-detail/27029 [N.d.C.].
Questo brano è tratto da T. Ingold, Antropologia. Ripensare il mondo (Meltemi Editore, Milano 2020, pagg., 112 €, a cura di Matteo Meschiari, trad. di Gaia Raimondi). Ringraziamo la casa editrice Meltemi per la gentile concessione.