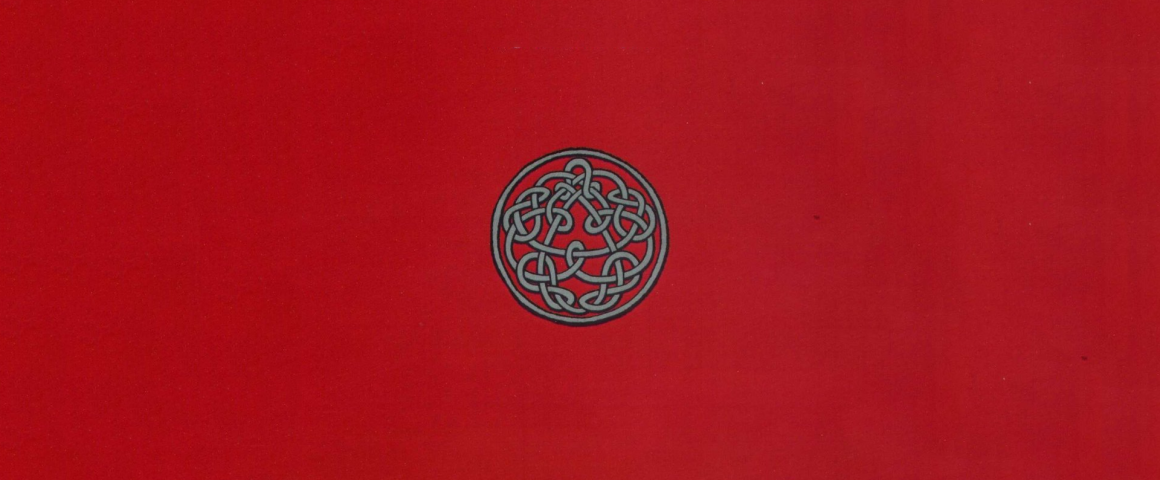Stefano Marino
La libertà è una forma di (in)disciplina: l’estetica dei King Crimson e gli Stick Men di Tony Levin live a Bologna
A mio padre,
che con la sua band, L’Ultima Ruota del Carro,
negli anni Sessanta, temerario e impavido,
osava suonare 21st Century Schizoid Man
anche alle sagre e alle feste di paese in Sicilia.
1. La bestia a sette/otto teste: la rinascita, o reincarnazione, dei King Crimson.
“Se l’obbedienza è dignità, fortezza. La libertà una forma di disciplina. Assomiglia all’ingenuità la saggezza”, recitano i giustamente ben noti versi di Depressione Caspica dei CCCP (dal disco Epica Etica Etnica Pathos del 1990; poi incisa, in una versione secondo me decisamente superiore a quella originale, anche nel disco In quiete del 1994 dei CSI). Credo che la “massima” di Giovanni Lindo Ferretti, trasposta su un altro piano, sia anche applicabile ai King Crimson, una delle più importanti rock band di sempre (anche se parlare solo di “rock” in un caso del genere è certamente riduttivo: “the precisionof a classical orchestra, the power of a rock band,and the freedom of a jazz band”, si legge nelle liner notes del loro recente, e invero entusiasmante, Live in Chicago 2017), al fine di comprendere l’estetica unitaria su cui si sono rette le loro avventure musicali dal 1969 a oggi, passando per varie fasi e numerosi cambi di formazione. Ciò, però, purché si specifichi che, nel caso della creatura musicale di Robert Fripp, la libertà è una forma di (in)disciplina, ovvero di disciplina e/ è indisciplina. Vale a dire che, dialetticamente, la prima può rivelarsi pienamente se stessa solo se mediata con il suo altro, con il suo opposto, andando a generare forme musicali fra le più libere, autonome, originali che la storia della musica popular del secondo ’900 abbia conosciuto proprio in quanto estremamente rigorose, metodiche, strutturate, disciplinate e, al contempo (e in maniera non disgiungibile da ciò), radicalmente indisciplinate, insubordinate, destrutturanti, talvolta sfocianti nell’anarchia. Un’anarchia, però, ossimoricamente sempre ben disciplinata e permeata da un innato senso della costruzione formale e dell’ordine; e, viceversa, un rigore architettonico sempre pulsante di inquietudini, fremiti, tumulti, scosse telluriche, e ben conscio dell’indomita forza del caos che incalza. Lo testimoniano bene, in moltissimi brani dei King Crimson, la misura e la compostezza, che arrivano quasi a sfiorare (in modo abbastanza inusuale nel rock) il limite della matematizzazione radicale del ritmo oppure quello del silenzio, ma che cedono poi improvvisamente il posto a distorsioni inquietanti e selvagge e ad assalti sonori inauditi (si pensi a Red, ad esempio, uno dei dischi più violenti di tutta la storia del rock, roba da far impallidire gli Slayer e i Sepultura, per non dire i Napalm Death: violenza sonora “vera”, e per questo terrificante, e senza avere minimamente bisogno di urla o altri cliché della cosiddetta musica hard o heavy). Un’estrema e ostentata freddezza – ben esibita anche dalla tipica postura da anti-rockstar del guitar hero Fripp (il guitar hero essendo invece uno dei modelli fondamentali del modo di essere, di apparire e di fare, se non “strafare”, della rockstar: dagli archetipi anni ’60 di Hendrix, Clapton e Page, alle versioni super-kitsch anni ’80 di Van Halen, Sambora o Malmsteen), che affronta da sempre sullo sgabello e seduto un po’ in disparte anche le platee più vaste –la quale si coniuga non accidentalmente, ma intrinsecamente, a un’ardente e trascinante forza propulsiva. Dunque, una tendenza alla statica (finanche nell’atteggiamento sul palco), alla costruzione e alla razionalità, e una alla dinamica, all’espressione e alla passionalità, che simmelianamente (per così dire) non si contrappongono astrattamente annullandosi ma vivono proprio della loro Wechselwirkung, “azione reciproca”.
Naturalmente, l’uso stesso dei termini disciplina e indisciplina, intesi qui come concetti adatti a descrivere la quintessenza dell’estetica kingcrimsoniana dalle origini al presente, richiama subito alla mente i titoli di due celebri brani, Discipline e Indiscipline, entrambi contenuti nell’album Discipline del 1981. Due brani che, nella loro opposizione/relazione dialettica (ovvero, contrapposizione che non si regge sulla mera esclusione di un polo rispetto all’altro, bensì sulla loro co-appartenenza reciproca e presenza dell’uno nell’altro), esemplificano in maniera particolare quello che, secondo me, è però un (se non forse il) tratto generale dell’estetica di questa band. Sotto questo punto di vista, la formula della co-appartenenza dialettica di disciplina e indisciplina funge bene non solo da principio di spiegazione della musica prodotta dai Crimson della cosiddetta trilogia anni ’80 ma, mutatis mutandis, anche da rappresentazione della loro cifra stilistica fin dai tempi di 21st Century Schizoid Man, il mitico brano di apertura del loro primo disco con la sua natura rigorosamente disciplinata costruita fin nei minimi passaggi e al contempo, per l’appunto, selvaggiamente “schizoide” e indisciplinata. Significative, in tal senso, possono risultare alcune dichiarazioni dello stesso Fripp ricavabili dal libro di Paolo Bertrando, King Crimson. Robert Fripp (Arcana, Milano 1984). “Ci sono diversi generi di libertà”, dichiara ad esempio Fripp negli anni ’70: “una libertà è quando non hai la minima restrizione strutturale e nella completa libertà esteriore trovi poi un punto fisso e quella è la tua libertà”; ma poi “c’è l’altro modo: in una disciplina strutturale molto rigida trovi un punto interiore che è libero”; e, nel caso della propria musica, Fripp spiega che talvolta “l’aspetto esteriore è piuttosto limitato, [ma] ci sono molti punti di libertà all’interno e però bisogna saperci entrare”. E, ancora, nell’articolo Creatività: alla ricerca della sorgente Fripp sembra alludere a una sorta di dialettica nella musica tra, da un lato, “diversi gradi di magia, analoghi ai gradi variabili della corrente elettrica” ed alla sorgente dei quali bisogna abbeverarsi, inserendosi nella corrente e lasciandosi trasportare o persino travolgere da essa, ma senza sovraccaricarsi (giacché talvolta “la corrente [è] troppo forte per il conduttore che la trasporta” e si può “morire d’intensità”, come nei casi di Parker, Coltrane e Hendrix che cita lo stesso Fripp); e, dall’altro, diversi gradi di disciplina, ad esempio di tipo fisico-corporeo, intellettuale ed emotivo-passionale, necessari tanto nel musicista quanto nell’ascoltatore. Ed è proprio da una tale dialettica che per Fripp scaturiscono – detto in maniera non poco ambiziosa, per inciso – la capacità di giungere alla consapevolezza che “la musica a volte ha un’esistenza obiettiva” e “può convogliare sensazioni che non appartengono esattamente a questo mondo”, e finanche la capacità della musica “di mutare radicalmente noi e ‘il mondo’, in misura ben maggiore di quanto normalmente si creda”.
King Crimson, secondo la mia ipotesi interpretativa, è allora più un concetto che il semplice nome di una rock band, cioè è soprattutto un atteggiamento generale verso la musica e forse addirittura verso la realtà, è un modo di fare musica che condensa in sé anche un modo di pensare e di essere. Nelle parole dello stesso Fripp: “King Crimson ha una vita propria, indipendente da quanto i suoi membri fanno e dicono. […] La musica ha una vita propria e invita certi personaggi improbabili a darle voce. […] King Crimson è una maniera di fare le cose”. Ovvero, nella mia interpretazione, è una maniera di sperimentare fino all’estremo la propria energia e spontaneità interiore, cercando di lasciarsi condizionare il minimo indispensabile da strutture costrittive esteriori e ponendosi dunque sotto il segno di una perenne spinta al non-adattamento e all’indisciplina, ma senza sfociare mai nell’eccesso di un puro, e per questo vacuo, “senza-forma” o “senza-vincoli” (che, dietro l’apparenza della dissoluzione di ogni legame, può nascondere varietà di alienazione e incatenamento a norme coattive interne, vissute irriflessivamente, non inferiori rispetto alla cieca obbedienza ai poteri normanti-assoggettanti esterni, vissuti in modo parimenti irriflessivo), bensì convogliando tale energia in vista di un incessante movimento di costruzione di forme e reperendo proprio in ciò, nel muoversi autonomo del soggetto all’interno dell’oggettività, anziché nella fuga (illusoria) da quest’ultima, il maximum possibile di libertà. Così come non si consegue l’autonomia illudendosi di potersi congedare in modo totale e completo dall’eteronomia ma addestrando pazientemente se stessi alla pratica dell’autonomia restando all’interno di contesti fatalmente esperiti almeno in parte come eteronomi, nella convinzione e nella speranza semmai di poter causare qualche crepa o frattura in questi ultimi, allo stesso modo non si consegue la libertà abbandonandosi meramente al caos ma collocandosi nello spazio intermedio (da non concepire però in termini di mero compromesso, tutt’altro) in cui l’indisciplina si media costantemente con la disciplina e viceversa. Cioè nello spazio in cui la spinta espressiva, condotta fino ai limiti della follia, si svela per ciò come razionale, e in cui la razionalità, divenendo consapevole del (anziché negando e sopprimendo il) momento di follia che dimora in essa, perviene per ciò a un grado superiore di consapevolezza e maturità.
Nel caso di Fripp & soci, poi, trattandosi di musicisti di livello tecnicamente superiore rispetto alla maggior parte dei musicisti rock (e non solo: si pensi ai loro frequenti “sconfinamenti” nel campo del jazz, della ambient music o di musiche d’avanguardia e cacofonico-rumoriste di vario tipo), una tale poetica della perenne ibridazione fra ciò che è rigoroso e misurato e ciò che è esplosivo si ripercuote con effetti notevolissimi e spesso sorprendenti, se non proprio scioccanti, non soltanto sul livello della composizione ma anche su quello dell’esecuzione o interpretazione, che nel caso dei King Crimson comprende anche un elevato tasso di improvvisazione. Notevoli, a mio giudizio, sono le implicazioni di un tale pensiero/atteggiamento anche su un piano culturale e sociale più ampio, per così dire. “Nessuna teoria sfugge più al mercato”, scriveva Adorno nella Dialettica negativa, ascrivendo/prescrivendo per questo motivo alla filosofia l’“essere nello stesso momento nelle cose e al di fuori delle cose” e di compiere perciò “il gesto del barone di Münchhausen che si solleva dallo stagno afferrandosi per il codino” (Minima moralia, § 46): tirarsi fuori dalla (o meglio: al di sopra della) realtà con un paradossale eppur possibile gesto di parziale autonomizzazione-emancipazione, ma al contempo non evadendo dalla realtà, non fuggendo da essa, bensì rimanendo in essa nel modo più insubordinato possibile. A ciò sembra idealmente rispondere Fripp con la sua celebre definizione del proprio scopo come musicista: “Lavorare nel mercato ma non essere governato dalle leggi del mercato”. E, si noti bene, Fripp dice questo come musicista rock e insieme estremamente colto, capace di concepire dialetticamente il massimo livello di apprendimento e affinamento delle proprie capacità strumentali come mezzo non per l’esibizione di una sofisticatezza ad ogni costo ma per il conseguimento di una spontaneità e innocenza di secondo grado, (ri)conquistata disapprendendo ciò che è stato faticosamente appreso, come quando scrive: “[ho] sempre lavorato con musicisti molto acculturati, incapaci di suonare musica semplice: non erano abbastanza bravi da suonare una tale musica. Se tu davvero padroneggi quel che fai, se sei in grado di suonare diecimila note ma sai che soltanto una è quella giusta, suoni quell’unica nota”. Commentando i versi “Resta all’inferno senza disperarti” e “Io risplendo in divergenza” del proprio brano Under Heavy Manners, Fripp ne fornisce una formulazione in termini quasi gnoseologici: “la canzone […] parla di quanto lontano si può andare con un processo di pensiero logico e quanto è possibile attraverso l’intelletto: [ma] è soltanto quando lo si supera che qualcosa succede”: là dove un tale “superamento” dell’intelletto non va però inteso, nel caso di un musicista “cerebrale” come Fripp (ma non per questo poco passionale: Fripp & soci sono tanto disciplinati quanto indisciplinati, si ricordi sempre), come gradino preparatorio per accedere a un presunto, o meglio illusorio, piano dell’intuizione immediata e dell’ispirazione-illuminazione diretta a scapito della “fatica del concetto” di hegeliana memoria, bensì come una sorta di Aufhebung, un superamento che conserva sempre in sé la memoria e la consapevolezza del superato, giungendo non all’oltrepassamento dell’intelletto come mero e banale abbandono di quest’ultimo bensì al suo superamento come approdo a un livello superiore di intellezione (cosa che, detto per inciso, può trovare egualmente bene applicazione nel campo della filosofia “pura”, nel campo della maestria tecnico-chitarristica e compositiva, o persino nel caso semplice ma non banale del nostro modo di vivere, pensare e agire nella quotidianità).
Ancora riguardo al rapporto inconciliato – ma non di fuga verso un’inesistente “esteriorità”, bensì di rifiuto dell’adattamento a un certo ambiente pur restando e dovendo restare al suo interno – tra i King Crimson e l’industria musicale (rapporto che, volendo, simboleggia poi su un piano più generale un possibile modo di rapportarsi dell’individuo alla società lasciandosi includere in essa ma poi auto-escludendosi parzialmente da essa e, proprio con ciò, cercando di cambiarla dall’interno nella misura del possibile), si possono citare le seguenti affermazioni di Fripp: “È mia opinione che qualsiasi politica diretta a cambiare i mezzi di produzione sia priva d’effetto senza un cambiamento del nostro modo di lavorare e produrre, e che quest’ultimo sia necessariamente personale. Se cambiamo il nostro modo di fare le cose, il mutamento strutturale segue necessariamente. Se vogliamo ottenere questo cambiamento personale ci serve disciplina e l’unica disciplina effettiva è l’autodisciplina”. E ancora: “La struttura dell’industria del rock è in grado di confondere il musicista rock almeno quanto le opere secolari della Chiesa riescono a confondere il penitente. Nel mondo del rock si perdono grandi energie a circondar d’attenzioni il musicista e ad accreditarlo come sorgente della musica. Ciò mette d’accordo tutte le parti, perché s’appella alla vanità dell’artista, consentendo all’industria di manipolare qualsiasi artista […]. Per contrastare tutto ciò, occorre disciplina. […] Nel 1969 suggerii che si poteva essere musicisti rock senza censurare la propria intelligenza. In un periodo in cui la moda del rock era il primitivismo, l’idea fu attaccata come pretenziosa. Se dovessi suggerire, nel 1980, che a mezzo della musica abbiamo la capacità di ottenere un mutamento qualitativo della natura umana, è probabile che l’idea incontrerebbe la stessa ostilità”. Eppure, è proprio a questa ipotesi così ambiziosa che sembra puntare l’estetica kingcrimsoniana della disciplina e/è indisciplina. Concludendo, se le cose stanno davvero come vuole la mia ipotesi interpretativa (qui presentata solo in modo sintetico e, mi auguro, destinata a un’esposizione più ampia in un libro, da qui a qualche anno), cioè se King Crimson è più un concetto e un modo di essere, fare e pensare che il semplice nome di una band progressive rock come Genesis, Yes o Gentle Giant, allora ha senso parlare di rinascite, o meglio ancora reincarnazioni, per le varie volte in cui, dopo lo scioglimento di una certa formazione e un certo periodo di pausa, i King Crimson sono tornati in attività (mai con la stessa line-up o lo stesso repertorio del passato, si noti bene).