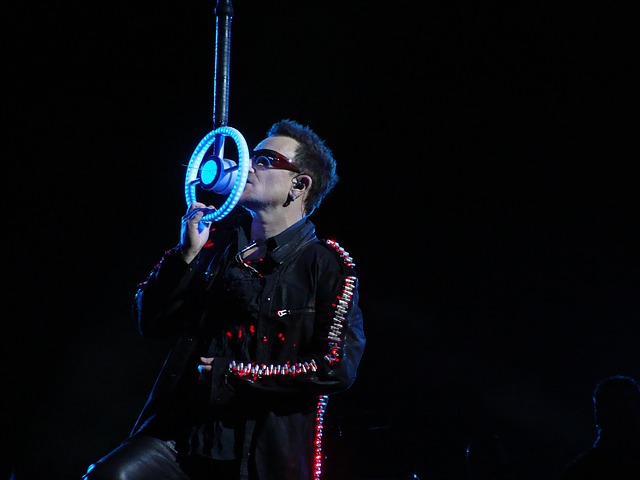Nel volumetto La filosofia degli U2 (Mimesis, 2013) ho tentato un’interpretazione filosofica delle liriche della band irlandese, fino all’album No Line on the Horizon (2009): una lettura incentrata sulla questione del conflitto tra le due facce dell’amore, eros e agape, ripercorso attraverso il rapporto, riflesso dai testi, tra un lui, la cui concezione dell’amore vorrebbe incentrarsi sull’agape, e una lei, discepola di eros. Due personaggi in larga misura riconducibili alla biografia del cantante Paul Hewson (Bono) e della moglie Alison. Nel frattempo è uscito, com’è noto, il nuovo album Songs of Innocence che, al di là delle polemiche sulla trovata pubblicitaria escogitata per la pubblicazione, in collaborazione con la Apple, ha diviso la critica riscuotendo alcuni elogi convinti, ma anche numerose stroncature. In questo articolo mi ricollego in parte ai temi del volumetto di cui sopra, cercando di evidenziare la specificità e il valore di questo nuovo lavoro che, a mio parere, rappresenta un capitolo importante – forse conclusivo, o quasi, nelle intenzioni dei suoi autori – del percorso di Bono e compagni.
Inizio soffermandomi sul brano di apertura, The Miracle (of Joey Ramone), forse uno dei meno riusciti sul piano strettamente musicale, ma che apre dignitosamente e con fresca energia l’album, introducendo su vari livelli quello che mi sembra essere il percorso di fondo dell’opera. Bella, in The Miracle, è l’idea di ritrovare nella memoria quel suono punk originario, Joey Ramone e la sua band, e la grande apertura al futuro che conteneva. Come scrive Bono a proposito di Joey in una nota all’album: “You could hear an echo of your pain in his voice… that’s why you believed him, surfing to the future on a sea of noise”. Nel brano c’è anche l’idea di ‘salvare i fenomeni’ inserendoli in un racconto personale: non celebrare i Ramones, ma contribuire a salvarli dall’oblio e dal conformismo mostrando ciò che di prezioso da essi è nato e può nascere. Poiché l’espressione ‘salvare i fenomeni’ – che impiego qui in un’accezione riconducibile a Walter Benjamin, ma che ha lontane ascendenze platoniche – potrebbe apparire fuori luogo in questo contesto, penso che essa meriti una breve digressione esplicativa.
L’espressione in questione, che si può anche rendere con ‘salvaguardare le apparenze’ (σώζειν τὰ φαινόμενα), è, appunto, originariamente appartenente alla tradizione platonica (la si trova in un commento di Simplicio) e ha a che fare con l’astronomia: quale ipotesi teorica, chiedeva Platone ai matematici, è in grado di salvaguardare le apparenze mostrate dai movimenti dei pianeti? In un senso filosofico più ampio e molto generale, la formula può significare che da un particolare evento o insieme di eventi storici, umili o grandiosi che siano, si riesce ad estrarre un’elaborazione concettuale in grado di spiegarli, un’idea capace di darne ragione: qualcosa di universale e oggettivo, potenzialmente in grado di parlare a persone di ogni tempo e luogo. Per fare qualche esempio, un romanzo di Fenoglio ‘salva’ determinati episodi della propria esperienza resistenziale inserendoli in una creazione artistica significativa. O ancora – su un piano più strettamente storiografico –, il Risorgimento italiano è una costruzione intellettuale che riesce a tenere insieme esperienze diverse, e per certi aspetti conflittuali, come quelle dei mazziniani, dei garibaldini, di Cavour, conferendo una collocazione significativa entro un tutto storico dotato di senso ad eventi fugaci e caotici, i quali vengono in tal modo, per così dire, salvati in quanto elaborati sul piano concettuale e compresi in un’idea. Nel senso più propriamente benjaminiano, poi, un fenomeno del passato viene ‘salvato’ attualizzandolo, cioè rileggendolo con gli occhi di un presente rivolto al futuro, a un futuro di giustizia e felicità, ossia a quanto Benjamin chiama “redenzione”; ciò che evidenzia la necessità di un filtro eminentemente e consapevolmente soggettivo, esistenzialmente e politicamente coinvolto nell’interpretazione – il filtro del narratore, dello storico, dell’artista, del filosofo – come tramite della tensione verso l’oggettività, l’universalità, la spiegazione autentica. Il fenomeno, pur indagato con accuratezza metodica, viene poi per così dire reinventato, ricreato tramite l’impegno spirituale dell’interprete, nella consapevolezza dell’impossibilità di restituirlo ‘così come è stato’: un aspetto, quest’ultimo, che è indispensabile per renderlo vivo, espressione di verità – in un’accezione di ‘verità’ diversa da quella ingenuamente positivistica –, e politicamente efficace nel presente.
In The Miracle c’è anzitutto il sound della chitarra, che intende ritrovare il suono originario dei Ramones, che all’epoca era una fragrante novità, ma lo rilegge attraverso il presente degli U2, rendendolo irriconoscibile. In questo modo lo fa rivivere in modo ben più significativo di quanto farebbe se tentasse di citarlo direttamente, o se venisse proposta una cover. In un’intervista, Bono ha affermato che, in vista della realizzazione dell’album, lui e gli altri membri della band si sono rimessi ad ascoltare i dischi che compravano all’epoca, a sedici o diciassette anni; che hanno riassorbito quel suono, ma poi si sono detti: “Ok, now let’s misremember it”. Non si tratta dunque di celebrare il punk, o qualunque altro evento passato, ma di renderlo attuale, di farlo rivivere “ricordandolo male”, trasformandolo attraverso il filtro della propria esperienza.
Il testo cerca, a sua volta, di ricostruire le sensazioni provate all’epoca di fronte a quel suono, e sono sensazioni e pensieri di libertà, pregni di futuro e di restituzione di senso al presente e al passato: “Heard a song that made some sense out of the world / Everything I ever lost, now has been returned / In the most beautiful sound I’d ever heard”. Insomma, quel suono, allora, nei Seventies, fu in grado di dare senso, di salvare il passato di Bono & C. rendendolo vivo e ‘spendibile’ per il presente e il futuro (anche, concretamente, tramite la possibilità che il punk sembrava dare a tutti di suonare e affermarsi senza particolari capacità tecniche, purché si avesse un’idea forte e personalità). E ciò rende ora quel suono degno di essere, a sua volta, salvato – se non dall’oblio (visto che la band di Joey è lungi dall’essere dimenticata), dal conformismo di una visione stereotipata del punk e dei Ramones – tramite una nuova traduzione musicale. Ma c’è anche un terzo livello di ‘salvataggio’, coerente con i due precedenti (il suono che salvò gli U2, e gli U2 che salvano quel suono), che testo e musica cercano di trasmettere. Non va dimenticato che i membri originari dei Ramones sono tutti morti. Joey peraltro se n’è andato ascoltando In a Little While degli U2. E The Miracle si confronta con quelle morti, e con la morte tout court, con le voci che sono state “rubate”, nella speranza/volontà di restituirle al presente e al futuro: “We can hear you…”; “Your voices will be heard”; “All the stolen voices will someday be returned”. Nell’ultima frase la prospettiva è chiaramente escatologica, in una dimensione – come quasi sempre in Bono – aconfessionale e adogmatica (Resurrezione dei corpi? Reincarnazione? Immortalità dell’anima? Il come resta indefinito, ma la fede è convinta che in qualche modo quel ritorno ci sarà, perché ci deve essere, come direbbe il Kant della teoria dei “postulati della ragion pratica”).
Qualcosa di analogo – e di più convincente sul piano musicale – avviene anche nell’incalzante e insolita This Is Where You Can Reach Me Now, dedicata a Joe Strummer: il ritmo di gioia rabbiosa dei Clash riascoltato attraverso la militanza disarmante degli U2. Anche qui viene ricordata la folgorante ‘lezione’ del punk: “One, two, three, four, was enough” e la novità assoluta di una presenza artistico-politica che non ammetteva di essere ignorata: “If you won’t let us in your world, the world just isn’t there”. Ma c’è poi la lettura distorta del messaggio politico dei Clash, interpretato nella chiave spirituale di ‘politica introspettiva’ tipica del post-punk degli U2, sia nel testo del brano (“Soldier soldier / We signed our lives away / Complete surrender / The only weapon we know / Soldier soldier / We knew the world would never be the same / Soldier this is where you can reach me now”), sia nella lunga nota all’album firmata da Bono: “Vedere i Clash per la prima volta durante il loro primo tour al Trinity College di Dublino fu un’esperienza che cambiò le coordinate mie, di Edge, di Adam e di Larry. Tornammo a casa quella notte spossati dal tumulto di rumore e idee. Non riuscivamo a dormire perché sapevamo di stare dormendo nei letti sbagliati. Eravamo migrati – mentalmente, spiritualmente… Joe Strummer era una specie di soldato… la sua chitarra un’arma, la sua bocca onnipotente. Non avevamo ben chiaro contro cosa e a favore di cosa esattamente stessero combattendo, ma quello era un public service announcement fatto dalle chitarre per conto dell’anima, e noi aderimmo”.
La band ha promesso l’uscita imminente di un altro album chiamato Songs of Experience, che completerebbe quello appena pubblicato (l’opera di Blake da cui gli U2 hanno preso spunto, se non altro per il titolo, è appunto Songs of Innocence and of Experience). Ma intanto abbiamo i “canti dell’innocenza”, titolo estremamente impegnativo – soprattutto se si pensa alla riflessione sempre rinnovata dalla band, dal primo album Boy (1980) in poi, sul tema della perdita dell’innocenza –, titolo che è certamente da ricondurre, in primo luogo, al tentativo dichiarato di raccontare i “first journeys”, i momenti virginali se vogliamo: il primo impatto con la violenza politica (Raised by Wolves: foto della guerra civile irlandese, dei rivolgimenti interni provocati dalla vista del sangue, dei corpi riversi sulle strade di casa); il primo incontro con i ‘maestri’ e ispiratori in campo musicale, come abbiamo visto; il rapporto originario di Bono con la madre (Iris, la madre del cantante, morta quando lui era un ragazzino, per la prima volta nominata direttamente in un brano degli U2: brano il cui testo è all’altezza della situazione, il ritmo ‘disco’ interviene al momento giusto per evitare l’eccesso di sentimentalismo, l’estraneità e la più intima vicinanza si fondono: “Hold me close / Like I’m someone that you might know”); e, ancora, i primi rapporti col miglior amico Guggi sulla strada di casa (nella bellezza viscerale di Cedarwood Road).
Abbiamo già visto in che modo questa “innocence” venga inevitabilmente e consapevolmente filtrata e trasformata dalla consapevolezza derivante da tutte le successive “experiences”. Tra l’altro, in Raised by Wolves, il verso “If I open my eyes, you disappear” richiama il celebre “I can’t close my eyes and make it go away” di Sunday Bloody Sunday, attestando la sostanziale risoluzione del conflitto in Irlanda del nord, alla quale gli U2 hanno senz’altro dato un significativo contributo culturale.
Anche da un’altra prospettiva, comunque, molte delle canzoni di quest’album sono già “canti dell’esperienza”. Song for Someone, ad esempio, al di là del riferimento alla “first time” (il primo rapporto sessuale?) è un brano in cui prevale l’accettazione dell’inevitabilità delle contraddizioni, della necessaria compresenza di luce e tenebra nella vita di tutti i giorni; la consapevolezza del fatto che il rapporto d’amore non può sempre essere come lo si vorrebbe: ha le sue fasi opache, ha le sue fasi luminose, tutte necessariamente da attraversare. “If there is a light you can’t always see / And there is a world we can’t always be / If there is a dark that we shouldn’t doubt / And there is a light, don’t let it go out” canta Bono: aver fede nel buio, cioè non dubitare che il male c’è e ci sarà, e che gli si può e deve dare un senso. Qui entra in gioco il grande tema della teodicea, della possibilità di giustificare Dio – o, in una prospettiva spirituale più ampia, la vita – per la presenza del male nel mondo. Del male fisico (il dolore, ma anche la sofferenza spirituale), del male morale (la colpa), del male metafisico (derivante dalla finitezza e costitutiva imperfezione umana) – per riprendere l’utile tripartizione di Leibniz. Ancora nel brano Yahweh, un paio di album fa, la teodicea era cercata ma non pienamente accettata: “Yahweh, Yahweh / Always pain before a child is born / […] / Still I’m waiting for the dawn / […] / Yahweh, tell me now, why the dark before the dawn?”. Invece oggi, nell’ennesima canzone dedicata da Bono ad Alison (il “someone” del titolo), la teodicea – seppure limitatamente all’ambito dei rapporti di coppia – è compiuta e accettata, pur sempre nel significato eminentemente attivo del credere nella possibilità di dare un senso e un valore al male, e non nel senso passivo del pensare che il male, di per sé, sia giustificato. Ed è sempre in questo brano (nella sua semplicità che, al primo ascolto, sfiora la banalità) che possiamo trovare uno dei pochi accenni impliciti al tema del conflitto tra eros e agape. “I don’t know how these cuts heal / But in you I found a rhyme”; “And I’m a long long way from your Hill of Calvary”; ”You were slow to heal, but this could be the night”, canta lui. L’accettazione del fatto che l’amore di coppia non può sempre essere una passione erotica totalizzante, ma che ha i suoi momenti di fragilità e opacità in cui deve intervenire la pietà, l’amore agapico per se stessi e per l’altro/a: tutto ciò rappresenterebbe la guarigione di lei (ma in realtà anche di lui, dell’io cantante, che di tale conflitto – di tale “croce” – ha sofferto da sempre). Su una linea analoga si muove Volcano: un brano di lapilli alla Franz Ferdinand, volto a celebrare il magma della passione mai addomesticata, dell’instabilità che “non vuole sapere”; un brano in cui la natura esplosiva e irrazionale di lei – “Volcano, you don’t wanna, you don’t wanna know… something in you wants to blow” – viene riconosciuta come necessaria per la pienezza della vita e dell’esperienza artistica di entrambi: “You are rock’n’roll, you and I are rock’n roll…”.
E, tuttavia, questi canti dell’esperienza sono al contempo davvero canti dell’innocenza. Non, qui, quella dell’inizio, dell’angoscia delle “first experiences”: è l’innocenza della fine, del superamento del tragico nella comprensione che, come affermava Simone Weil, risolvere una contraddizione è comprendere che non c’è niente da risolvere. Così, anche in uno dei brani più belli e significativi dell’album, California –una gioiosa visione dell’eternità della vita che fa tutt’uno con le effimere spiagge dei Beach Boys – Bono canta: “The weight that drags your heart down / Well that’s what took me where I need to be / Which is here / […] At the dawn you thought would never come / But it did / Like it always does / […] I’ve seen for myself / There’s no end to grief / That’s how I know / That’s how I know / and why I need to know that there is no end to love”. E il drammatico “blood red sky” dei tempi di War (1983) diventa ora un pacificato “blood orange sunset”: è il sangue, prima ancora del cielo, ad aver cambiato colore.
La teodicea – nel senso di un’accettazione attiva della vita, del mondo così com’è, nel tentativo di trasformarlo ma senza abbandonarsi al pensiero di una sua ineluttabile tragicità o “vanità” in senso leopardiano – sembra poi allargarsi al di fuori dell’ambito erotico, per assumere un significato globale, in quel gioiello elettronico che è Sleep Like a Baby Tonight: ninnananna che riesce a parlare di inedia africana (“Where there is silence and not screaming”), di squallida quotidianità (“Read about a politician’s lover”), lasciando a un estremo falsetto le cose meno dicibili: la speranza in una vera comunità umana (“Hope is where the door is / When the Church is where the war is: / Where no one can feel no one else’s pain”); la follia di Assisi (Like a bird your dreams gonna take flight / Like St. Francis covered in light / You’re gonna sleep like a baby tonight”). Che si possa “dormire come bambini stanotte” pur sapendo che l’indomani “albeggia come un suicidio” è sì probabilmente legato a un ricordo d’infanzia, ma è verosimilmente qualcosa che il Bono maturo, ormai non troppo lontano, anzi, dalla soglia della vecchiaia, sta dicendo al proprio cuore (e che chi ascolta può cercare di dire a se stesso).
The Troubles, che chiude l’album, è forse il brano più complesso e inquietante. Peraltro ne esiste una seconda versione – con un testo largamente diverso – inclusa nel secondo CD allegato al ‘cofanetto’: un ‘disc B’ che, oltre a esecuzioni acustiche, spesso tutt’altro che brillanti, di alcuni brani, include appunto due versioni nettamente diverse di The Troubles e di Sleep Like a Baby Tonight , oltre a due interessanti brani inediti. The Troubles appare, a un primo livello, una dichiarazione di libertà dai condizionamenti sociali (“I have a will for survival / So you can hurt me and then hurt me some more / I can live with denial / But you’re not my troubles anymore”) sovrapposta a un invasivo refrain-litania, affidato alla voce ipnotica e sensuale di Lykke Li, che invece ammette l’estrema pervasività di condizionamenti che arrivano fino al centro dell’anima (“Somebody stepped inside your soul / Little by little they robbed and stole / till someone else was in control”). I brani in questione si possono forse, in parte, riferire alla violenza pervasiva e per molti versi inafferrabile delle nostre società, contro la quale già in Acrobat (1991) ci si scagliava disperatamente (“I know you’d hit out, if you only knew who to hit…”) e, più in particolare, alla violenza dello show business, che ha fatto di Bono e compagni delle rockstar, dei personaggi “più famosi di Gesù”, come diceva Lennon dei Beatles, e sottoposti a una pubblica vivisezione della vita pubblica e privata, la cui asprezza è difficilmente comprensibile per chi la guarda dall’esterno (una violenza alla quale peraltro gli U2 sono perfettamente consapevoli di essere corsi incontro a braccia aperte, per una delle tante contraddizioni che li caratterizzano). “Steal back your innocence, that’s what they stole from you”, dice, fin troppo esplicitamente, la versione alternativa di Sleep Like a Baby Tonight, alludendo forse anche all’intimo rovello legato al continuo confronto con le conseguenze della ricchezza e della fama.Ma – si diceva – la litania apparentemente sociocentrica di The Troubles viene in parte sovrastata da una dichiarazione di libertà e, soprattutto, accompagnata dal riconoscimento radicale che voi non siete più il mio problema perché il mio unico problema sono io. “You think it’s easier / To put your finger on the trouble / When the trouble is you / And you think it’s easier / To know your own tricks / Well it’s the hardest thing you’ll ever do”.
Lo “you” di “You’re not my troubles anymore” può riferirsi alla società turbocapitalistica, agli irriducibili della guerra civile irlandese (The Troubles è anche l’espressione con cui comunemente ci si riferisce al conflitto nord-irlandese), ai tanti haters di Bono nel dibattito pubblico e scandalistico, alle trappole dello show business. Ma può riferirsi anche a lei, con la sua incompatibile visione dell’amore. E potrebbe riferirsi perfino agli stessi conflitti tragici – quello di eros contro agape, o quelli inerenti al problema della teodicea (la fede nell’amore divino contro la constatazione della pervicace esistenza del male nel mondo) – vissuti come realtà oggettive, esterne a sé. Insomma, dalla dimensione politica, religiosa, esistenziale e – in ultima istanza – filosofica, il focus sembra spostarsi su una prospettiva psicologica, di psicologia del profondo, direi quasi su un riconoscimento della nevrosi quale fonte della propria avventura artistica.
Uno dei luoghi più netti, in questa direzione, viene offerto da uno dei due brani inediti del ‘Disc b’, Lucifer’s Hands. Anche qui sembra esserci anzitutto un riferimento a una first experience adolescenziale (“Punk rock party in a suburban home / […] / We got no music cos the speaker’s blown apart”), ma il presente di Bono viene decisamente in primo piano, in un implicito dialogo, estremamente significativo, con una grande canzone degli anni Ottanta: Rejoice, dall’album October. La carica esplosiva di Rejoice esprimeva come pochi altri brani lo spirito migliore di quel decennio: la sostituzione della battaglia politica dei Seventies con una lotta spirituale per la trasformazione interiore, in vista di un cambiamento sociale nonviolento. “I can’t change the world, but I can change the world in me, if I rejoice!”, urlava Bono nel 1981, sfidando in chiave religiosa l’altro polo del ripiegamento introspettivo della critica sociale negli anni di fango: quello pessimistico e rabbioso degli Smiths, soprattutto, e di tanti altri. Oggi, Lucifer’s hands ammette pacatamente: “Yes I can change the world. Yes I can change the world. The poor breaking bread that’s made out of stone / The rich man won’t eat, he’s eating, alone / That’s easy / But I can’t change the world / In me.” Il testo si riferisce evidentemente ai risultati ottenuti dal decennale impegno del cantante sui fronti dell’inedia e delle malattie trascurate nel Sud del mondo. Tutto ciò appare “facile” se paragonato all’introspezione psicologica, allo smascherare i propri “tricks”. La prospettiva di fondo religiosa non viene certo annullata – lo si comprende già dal riferimento a Lucifero nel titolo! – ma, alle orecchie di chi segue da tempo l’avventura degli U2, appare evidente che l’elemento davvero nuovo e interessante sta in quel riconoscimento dell’impossibilità di trasformare radicalmente il proprio paesaggio psichico (il che non impedisce di agire politicamente per trasformare la società).
Concludo parlando dell’ultima parola del ‘Disc B’, o meglio del modo in cui essa viene pronunciata, cantata. La parola è “child”, all’interno di una frase che suona “To take your heart back to where you can feel / Like a child”. Diventare come bambini è il dettato evangelico che percorre tutta la produzione degli U2, dalla tremante Into the Heart, nel primo album Boy (“Into the heart of a child / I can’t go there / I can’t stay a while”), all’impossibilità di restare innocenti di fronte all’eros (“She sees the man inside the child” – si ascoltava in Mysterious Ways, in un fantastico dialogo a distanza con la Woman di John Lennon), fino alla preghiera rivolta al figlio di Edge – “Please stay a child somewhere in your heart” – in quella Original of the Species che rappresenta un po’ la Hey Jude degli U2, per sottolineare ancora una volta la continuità spirituale con i Beatles. Bene, la parola “child”, alla fine di Songs of Innocence, non viene in realtà né pronunciata né cantata: forse neanche urlata… viene cercata con la voce, in un sforzo eccezionale. Gli U2 appaiono, da questo punto di vista, ben consapevoli del delicato rapporto tra il significato etico-spirituale di una parola e la sua espressione musicale. A proposito del già citato brano Yahweh (2004), Bono ebbe a dire: ”The title’s an ancient name that’s not meant to be spoken. I got around it by singing. I hope I don’t offend anyone”. Un understatement che nasconde, mi pare, una consapevolezza ben precisa. L’etica è azione, azione coraggiosa. Perciò parlare – pacatamente, scientificamente – di etica rischia di essere un controsenso. Cantare l’etica è già meglio, perché il canto è più vicino all’azione rispetto alla parola detta: perde la dimensione possessiva del concetto, costringe a mettersi più radicalmente in gioco e ad aprire il cuore. Gridare l’etica, nel modo giusto – come si può sempre ascoltare, ad esempio, in quell’antica gemma che è Like a Song (1983) – è ancora meglio. O cercarla in un impeto finale con la voce, come fa ora Bono con la parola “child”, facendo capire che l’innocenza, come ogni cosa bella, non è mai acquisita una volta per tutte.