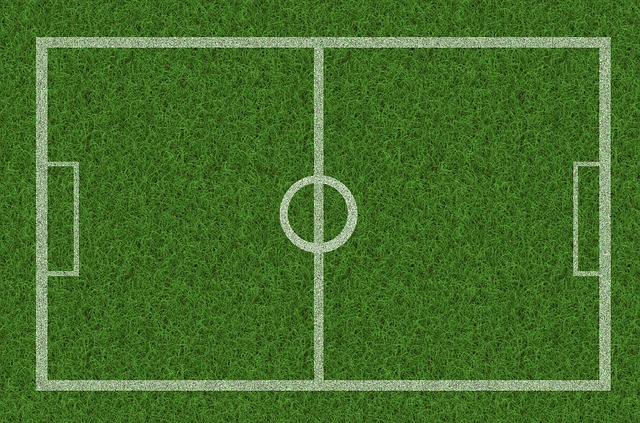Il calcio, come lo sport in generale, nelle società occidentali complesse, è venuto configurandosi progressivamente, dai decenni iniziali del Novecento in poi, come uno degli ambiti più influenti dell’industria culturale dello svago, volti a intrattenere, divertire e anche occupare le masse. La dimensione socio-politica del calcio è, quindi, un aspetto ormai acclarato e l’idea che esso, come tutti gli sport, sia da considerarsi solo un gioco, immune da logiche di potere, economiche e implicazioni di altro genere, può essere sostenuta solo assumendo una posizione più o meno inconsapevolmente ingenua. Dunque, a ben guardare, soprattutto nell’età globale, l’evoluzione del calcio, non costituisce un qualcosa di a sé stante e resta un fenomeno esemplificativo di più generali mutazioni della società in cui viviamo. In tempi recenti, le continue vicende legate a scandali su scommesse, partite truccate, gestioni economiche fallimentari, forme di corruzione, sino a episodi di razzismo e violenza e cadute di stile di svariato genere, mostrano inequivocabilmente una condizione di abbassamento morale e culturale. Questo genere di episodi, peraltro, sembrano avere tendenza a moltiplicarsi esponenzialmente, mentre, parallelamente, si accresce la connotazione puramente mediatica del calcio. L’età del calcio globale, che possiamo identificare nell’ultimo venticinquennio, porta alla luce evidentemente tutto ciò. Un punto, in tutto questo contesto, appare cruciale. Il fatto, cioè, che lo spettacolo stesso del calcio, anche al di là di questi scadimenti, appare meno interessante, si può ritenere più banale e prevedibile, ed è il riflesso più acceso della società attuale, in cui, dietro il progresso tecnologico, comunicativo, informatico-informativo, dietro l’estetica estrema, dietro l’attenzione alle formalità, dietro social network e selfie, si cela una sostanza non all’altezza, un vuoto perturbante e ambiguo di senso.
Possiamo esplicitare brevemente questo discorso d’insieme attraverso alcune rapide osservazioni, che possono costituire una prima forma di riflessione per chi volesse dedicare qualche considerazione attenta a questo fenomeno. Notiamo, innanzitutto, una cesura fondamentale che riguarda la società in generale prima che il calcio. Ormai un quarto di secolo fa, è caduto il muro di Berlino, sancendo la fine dei blocchi e della contrapposizione USA-URSS e portando il mondo in un’epoca più disincantata e sostanzialmente post-ideologica. Il calcio globale comincia sostanzialmente da allora. Sino alla fine degli anni Ottanta, le squadre di club avevano un una specifica connotazione nazionale e numero limitato di stranieri (addirittura i giocatori delle squadre dell’est non potevano trasferirsi all’estero prima di aver raggiunto l’età dei 28-30 anni e comunque con enormi difficoltà e limitazioni burocratiche); alla Coppa dei campioni partecipava solo chi vinceva il rispettivo campionato, il numero di partite in tv era più contenuto e non si giocava ogni giorno; c’era una ritualità nei tempi e nei momenti, un rispetto(se non un culto) quasi reverenziale per certe tradizioni, legate a colori delle maglie(oggi non di rado stravolte) e stili di gioco, come quello nordeuropeo atletico e mai domo, quello sudamericano tecnico e spettacolare, quello mediterraneo scaltro e astuto, quello slavo sornione e un po’ misterioso; in fondo, quegli stili di gioco rimandavano, sociologicamente, allo spirito dei popoli che li attuavano. Le stesse tattiche di gioco avevano analoghe connotazioni specificamente nazionali: il calcio belga e olandese con zona e fuorigioco sistematico, quello italiano con libero e contropiede, il futbol bailado brasiliano fondato su dribbling e fraseggio, sino alla tradizione elegante del “calcio danubiano” di ambito austriaco-ungherese-ceco, quasi riflesso sportivo della raffinata cultura intellettuale mitteleuropea. E ancora, prima dell’avvento del calcio globale, perfino la numerazione dei calciatori dall’1 all’11, attribuiva ruoli a numeri a seconda delle specifiche latitudini: così, per fare esempi, mentre in ambito europeo il 5 era in genere attribuito allo stopper o al difensore centrale, in Sudamerica il 5 era attribuito al centrocampista centrale di regia(il volante); mentre in Italia e altri paesi il 6 era del libero, in Brasile era del terzino sinistro, e nel Nord Europa in genere era attribuito invece a mediani o centrocampisti; in Occidente il numero del centravanti era il 9, all’Est Europa poteva essere invece il 10.
Pian piano tutto ciò è cambiato profondamente. La caduta del muro ha sfaldato potenze calcistiche nazionali, come erano l’URSS e la Jugoslavia, in tanti piccoli Stati e, se una volta le squadre dell’Est europeo competevano spesso alla pari con quelle occidentali, in incontri che avevano un che di epico-ideologico, poi, progressivamente e inesorabilmente, esse sono state marginalizzate dal calcio che conta: non sembra un caso che l’ultima squadra dell’Est Europa a vincere la Coppa dei campioni sia stata la Stella Rossa di Belgrado nel 1991(ultima edizione, peraltro, della Coppa dei campioni tradizionale tutta con eliminazione diretta prima dell’avvento della formula con gironi tipica della Champions’ League), poco dopo la caduta del muro e che, da allora sino a tutt’oggi, per le squadre dell’Est, nel più prestigioso torneo, come massimo risultato, si può registrare solo una semifinale della Dinamo Kiev nel 1999. Lo sbalzo situazionale è innegabile se si ricorda che nel decennio precedente 1980-89, invece, oltre alla vittoria della Steaua Bucarest nel 1986, vi furono ben 6 semifinaliste dell’est(CSKA Sofia nel 1982, Widzew Lodz nel 1983, Dinamo Bucarest nel 1984, Dinamo Kiev nel 1987, Steaua nel 1988) e la stessa Steaua perse la finale nel 1989. Si deve poi rilevare che la liberalizzazione delle frontiere e dei vincoli contrattuali (questi ultimi alterati a metà anni Novanta dalla legge Bosman, che consentiva, ai calciatori il cui contratto scadeva, di trasferirsi da un club a un altro senza che il club che acquisiva il giocatore con contratto scaduto, pagasse alcuna somma alla squadra precedente come invece accadeva in passato) ha portato a squadre costituite interamente da stranieri: gli stili e le tattiche di gioco si sono, di conseguenza, maggiormente uniformati e, con l’avvento delle maglie personalizzate(da metà anni Novanta), con numero fisso e nome del calciatore sulla schiena – l’esempio forse più simbolico dell’individualizzazione tipica del modello di società neoliberale – il legame tra ruoli e numeri e specifiche tradizioni è in massima parte volatilizzato: il 45 di Mario Balotelli come il 21 di Andrea Pirlo, o il 99 di Samuel Eto’o, tanto per citare qualche calciatore-icona dei nostri tempi, non hanno, neanche lontanamente, alcun significato tattico, sono al contrario la spia di una destrutturazione.
Ancora, i grandi club occidentali, ormai simili a multinazionali, gestiscono fatturati iperbolici (indicativamente, negli anni 2000, per identificare il Real Madrid, è stato spesso utilizzato l’appellativo di Galacticos) e sono coinvolti in flussi di capitale e influenze transnazionali come quelle di oligarchi russi e di sceicchi arabi: questi club attraverso la nuova formula della Champions’ League costituiscono praticamente una lega elitaria continuamente arricchita da sponsor e diritti economici e le squadre potenti e vincenti restano sempre le stesse; per tutte le altre squadre il massimo traguardo è una partecipazione solo ai gironi preliminari del torneo. La qualità delle partite ne risente(molti incontri dei vari tornei nazionali e internazionali, diventano concretamente poco influenti) per l’inflazione dell’offerta e anche i campioni dell’età globale sono sempre più personaggi d’immagine, interamente integrati in un circuito mediatico specifico, sistematizzato e privilegiato, in cui l’apparenza conta forse più della tecnica: dal 2008 a oggi, tutti i Palloni d’oro (massimo riconoscimento individuale per calciatori) assegnati sono andati solo a Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ciascuno guarda caso front man dei due principali colossi di abbigliamento sportivo che oggi si spartiscono il calcio che conta, Nike e Adidas. E del resto, scorrendo l’albo d’oro della Champions’ League, si può pure osservare emblematicamente che i club che l’hanno vinta dal 2000 a oggi sono stati immancabilmente sponsorizzati da Nike o Adidas (tranne il Liverpool nel 2005 comunque sponsorizzato da un altro grande nome dell’abbigliamento sportivo globalizzato come Reebok, che, coincidenza quantomeno significativa, viene poi assorbito da Adidas): ecco dunque Real Madrid (2000, 2002, 2014), Bayern (2001, 2013), Milan (2003, 2007), Chelsea (2012), per Adidas; Porto (2004), Barcellona (2006, 2009, 2011, 2015), Manchester Utd (2008), Inter (2010), per Nike. Potremmo proseguire ancora questi discorsi, aggiungendo il rastrellamento sistematico dei giovanissimi calciatori in Africa e Sudamerica(ma anche nell’est europeo, ancor più quando i paesi quest’area entrano a far parte politicamente dell’UE), da parte dei più ricchi club europei, con un retrogusto di imperialismo difficilmente eludibile.
Insomma, una chiara organizzazione generale, istituzionale, economica e comunicativa, in cui i divari e le disuguaglianze, tra potenti e non potenti, si accrescono di continuo e la cui unica cifra emblematica è la logica sistemica di produzione e marketing: tutto ciò è molto palese e non andremo certo a scomodare oltremodo l’applicazione di vetuste forme di critica marxista, per appurare che l’ideale sportivo del calcio non è più qui da tempo. Se si guarda il calcio globale, quello che si osserva è semplicemente la rappresentazione in scala della società del modello turbo capitalista e neoliberista, de-idealizzata, utilitarista, edonista, liquida (per usare la celebre espressione di Zygmunt Bauman), post-nazionale, finanche post-umana. Un minimo sguardo sociologico, come quello che abbiamo provato indicativamente a proporre, coglie necessariamente tutti questi singoli punti e riesce a mettere a fuoco il quadro completo che essi delineano. Ovviamente, la sociologia ha però questioni molto più pressanti e complesse cui dedicarsi, che non la vicenda del calcio globale, ma forse a queste osservazioni potrebbero interessarsi con maggiore attenzione almeno i tanti media e giornalisti che, come è noto, gravitano attorno al mondo del calcio e il cui ruolo dovrebbe anche essere, in qualche misura, volto a trasmettere quella che si definiva cultura sportiva, ossia una preliminare comprensione storico-sociale e etica dello sport. Non ci si illude certamente che questo possa accadere e neanche che ciò possa avere qualche importanza; in fondo, il mondo del XXI secolo appare disperatamente sempre più senza redenzione, un mondo in cui davvero sembra impossibile pensare un altro futuro e non ripetere gli stessi errori legati alle evoluzioni ineffabili della modernità: così inutilmente remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato. Nel calcio globale come nella vita attuale.